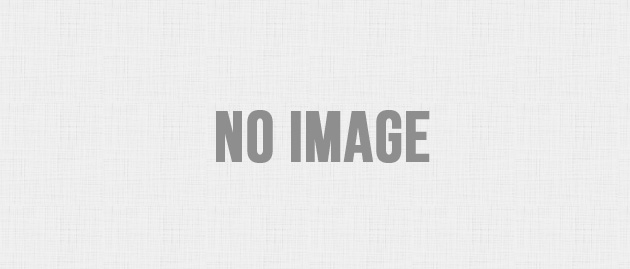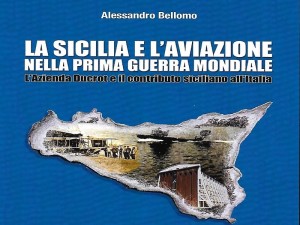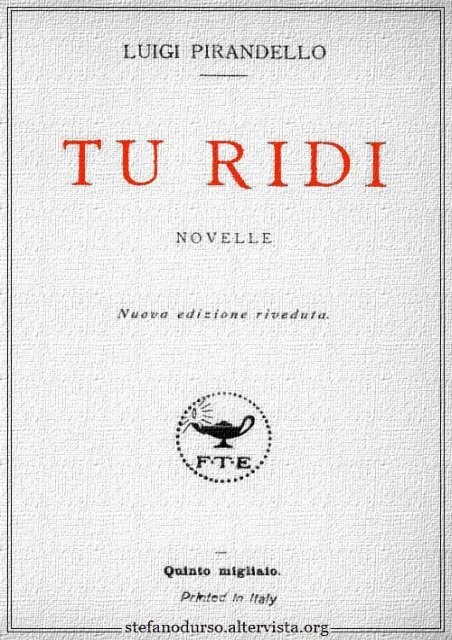Myriam De Luca, "L'invisibile nutrimento" (Ed. Thule) - di Anna Maria Bonfiglio
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 25 Febbraio 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1558
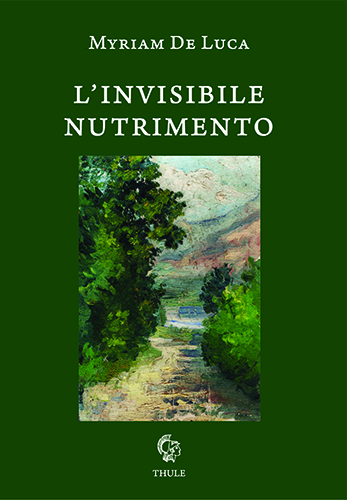 Presentando la prima raccolta di poesie di Myriam De Luca, Esortazioni solitarie, ebbi modo di riconoscere nella sua scrittura una forte potenzialità di evoluzione per le caratteristiche di appassionata sensibilità e per il linguaggio curato e suggestivo. Nell’accostarmi alla sua nuova raccolta, L’invisibile nutrimento, scopro con compiacimento che il percorso compiuto l’ha portata ad impadronirsi di una propria cifra stilistica costituita innanzi tutto da una scrittura “onesta”, dal verso curato ma scevro di ricercatezze sovrastrutturali, e dall’apertura tematica che, oltrepassando la soglia autobiografica, si misura nel ri-conoscimento del sé. Tra “l’insidiosa tentazione di compiacersi e la voglia di liberarsi dai suoi vizi”, l’anima-coscienza fluttua fino al rifugio sicuro dell’innocenza primigenia, e da questa posizione idealistica esterna la propria ricchezza interiore “così che la poesia di un attimo/brilli per sempre”. Vi è in questa raccolta una totale aderenza alla vita, nell’inganno o nel disincanto non viene mai meno la forza di oltrepassare le strettoie e attendere che “le stelle scure (siano) scadute come il disamore”. I testi poetici di Myriam De Luca non si limitano ad attraversare sic et simpliciter gli stati d’animo o a decantare le ricchezze della natura, né a lamentare retoricamente quanto nella società stia andando allo sfascio, si aprono piuttosto ad ogni possibile aspetto della realtà personale e umana, tangendo altre più varie questioni quali: il vuoto di un modus vivendi arido e intossicato dove “la memoria di anni gentili/sembra un insulto/all’insolenza dilagante”; o la problematica del ruolo femminile nella vita affettiva (Fammi sentire donna/anche senza un abito sensuale) e in quella sociale (Di me il prezzo pattuisce/con labbra sottili e cattive). E nella poesia Donne si compendia il ritratto del femminile usato e abusato nella mitologia del quotidiano: “Cantano di noi i poeti/ci immortalano i pittori/tra rose pallide/e tramonti di vetro”. Sin da questi primi quattro versi si delinea il nucleo pungente del testo che polemizza con il topos ormai desueto della donna-angelo del focolare. “Siamo uomini e padri/nella pazienza e nell’attesa/(…) A volte abbiamo voglia/di essere avare ed egoiste/di spiccare voli senza ritorno”. L’apparente disincanto di questi versi non è mero desiderio di revanche ma sottile richiesta di considerazione, di attenzione alla soglia sulla quale si può rischiare di inciampare. Tutto il registro linguistico della silloge è pacato, a tratti amorevole, nell’acquisita convinzione di essere “altro” da quello che il sentire comune vorrebbe e si alimenta di cifre semantiche che trasmettono sensazioni di serenità e pacificazione, di aggettivi quali calmo, sereno, dolce, morbido, in comunione con lo spirito di quella mediterraneità che si connatura all’autrice.
Presentando la prima raccolta di poesie di Myriam De Luca, Esortazioni solitarie, ebbi modo di riconoscere nella sua scrittura una forte potenzialità di evoluzione per le caratteristiche di appassionata sensibilità e per il linguaggio curato e suggestivo. Nell’accostarmi alla sua nuova raccolta, L’invisibile nutrimento, scopro con compiacimento che il percorso compiuto l’ha portata ad impadronirsi di una propria cifra stilistica costituita innanzi tutto da una scrittura “onesta”, dal verso curato ma scevro di ricercatezze sovrastrutturali, e dall’apertura tematica che, oltrepassando la soglia autobiografica, si misura nel ri-conoscimento del sé. Tra “l’insidiosa tentazione di compiacersi e la voglia di liberarsi dai suoi vizi”, l’anima-coscienza fluttua fino al rifugio sicuro dell’innocenza primigenia, e da questa posizione idealistica esterna la propria ricchezza interiore “così che la poesia di un attimo/brilli per sempre”. Vi è in questa raccolta una totale aderenza alla vita, nell’inganno o nel disincanto non viene mai meno la forza di oltrepassare le strettoie e attendere che “le stelle scure (siano) scadute come il disamore”. I testi poetici di Myriam De Luca non si limitano ad attraversare sic et simpliciter gli stati d’animo o a decantare le ricchezze della natura, né a lamentare retoricamente quanto nella società stia andando allo sfascio, si aprono piuttosto ad ogni possibile aspetto della realtà personale e umana, tangendo altre più varie questioni quali: il vuoto di un modus vivendi arido e intossicato dove “la memoria di anni gentili/sembra un insulto/all’insolenza dilagante”; o la problematica del ruolo femminile nella vita affettiva (Fammi sentire donna/anche senza un abito sensuale) e in quella sociale (Di me il prezzo pattuisce/con labbra sottili e cattive). E nella poesia Donne si compendia il ritratto del femminile usato e abusato nella mitologia del quotidiano: “Cantano di noi i poeti/ci immortalano i pittori/tra rose pallide/e tramonti di vetro”. Sin da questi primi quattro versi si delinea il nucleo pungente del testo che polemizza con il topos ormai desueto della donna-angelo del focolare. “Siamo uomini e padri/nella pazienza e nell’attesa/(…) A volte abbiamo voglia/di essere avare ed egoiste/di spiccare voli senza ritorno”. L’apparente disincanto di questi versi non è mero desiderio di revanche ma sottile richiesta di considerazione, di attenzione alla soglia sulla quale si può rischiare di inciampare. Tutto il registro linguistico della silloge è pacato, a tratti amorevole, nell’acquisita convinzione di essere “altro” da quello che il sentire comune vorrebbe e si alimenta di cifre semantiche che trasmettono sensazioni di serenità e pacificazione, di aggettivi quali calmo, sereno, dolce, morbido, in comunione con lo spirito di quella mediterraneità che si connatura all’autrice.