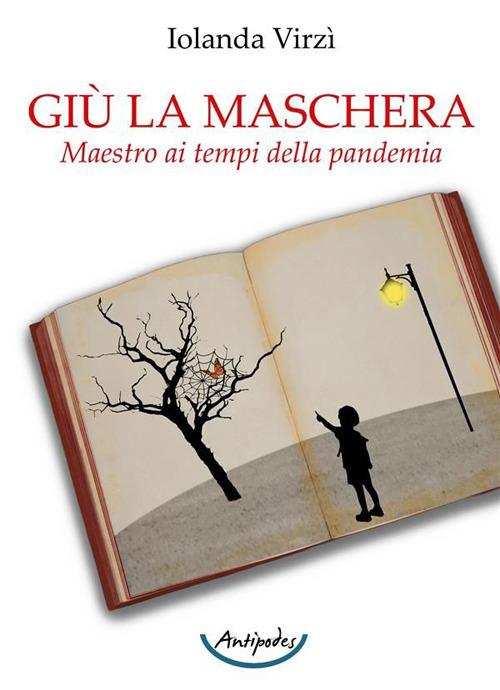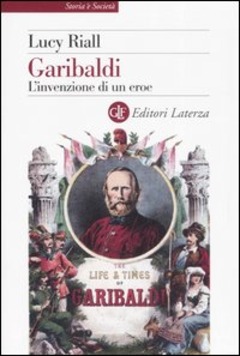“Cico c’è" e "Cosa vedi": due romanzi di Vanessa Ambrosecchio a confronto” - di Vittorio Riera
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 15 Febbraio 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2587
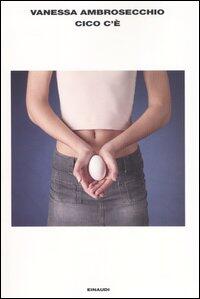 Era mia intenzione scrivere una recensione sull’ultimo libro di Vanessa Ambrosecchio Cosa vedi, (il Palindromo, Palermo 2018), ma a lettura ultimata mi sono convinto che sarebbe stato un errore prescindere dal precedente romanzo d’esordio Cico c’è (Einaudi, 2004). E ciò perché i due romanzi sembrano sotto alcuni aspetti speculari e, sotto altri, contrastanti senza che ciò ne rompa l’unitarietà. Ecco perché in questo momento non ci interessano le vicende narrate nei due romanzi (a riguardo, rimandiamo alla recensione di Gaspare Agnello rintracciabile in Internet) e preferiamo mettere in evidenza le cornici entro le quali quelle vicende si dipanano.
Era mia intenzione scrivere una recensione sull’ultimo libro di Vanessa Ambrosecchio Cosa vedi, (il Palindromo, Palermo 2018), ma a lettura ultimata mi sono convinto che sarebbe stato un errore prescindere dal precedente romanzo d’esordio Cico c’è (Einaudi, 2004). E ciò perché i due romanzi sembrano sotto alcuni aspetti speculari e, sotto altri, contrastanti senza che ciò ne rompa l’unitarietà. Ecco perché in questo momento non ci interessano le vicende narrate nei due romanzi (a riguardo, rimandiamo alla recensione di Gaspare Agnello rintracciabile in Internet) e preferiamo mettere in evidenza le cornici entro le quali quelle vicende si dipanano.Partiamo dai titoli: Cico c’è - Cosa vedi, due titoli formati da due parole secche, neutre, diremmo quasi, che non suggeriscono alcuna chiave di lettura, alcuna tesi o problematica più o meno attuale come lasciano intendere in genere i titoli delle opere narrative odierne. Il lettore dinanzi a quei titoli rimane perplesso: Cico, Cico c’è. Ma che cosa vuole dirci l’autrice? A che cosa allude? E analogamente per l’altro titolo: Cosa vedi. Sembra quasi che Vanessa voglia divertire e divertirsi allo scopo proprio di suscitare curiosità nel lettore. Ma questa è solo una delle tante coincidenze, secondo noi volute, nelle quali non può non imbattersi un lettore attento. Ma altre ve ne sono e di ben altra consistenza.
I luoghi, i siti, infatti, dove si svolgono le due vicende: Venezia in Cico c’è, Palermo in Cosa vedi, due città, agli antipodi, potremmo dire, quasi all’estremo Nord e galleggiante sull’acqua, l’una, quasi all’estremo Sud e dal clima mite e che l’acqua, l’acqua piovana, intendiamo, la conosce nei mesi autunno invernali, l’altra; due città destinate a divenire personaggi, protagonisti dei due romanzi; due città, così lontane eppure così vicine accomunate come sono da un destino pressoché, nella visione che di esse ha l’Ambrosecchio, analogo: la siccità, una siccità, un’arsura che tutto brucia e soffoca. Cico c’è si chiude con una visione a dir poco apocalittica di Venezia, come, del resto, è anche detto nel testo: “Venezia è asciutta”, si legge a p-198. E subito dopo: “Le case, i palazzi, i campielli sembrano nidi arroccati su scogli.” La descrizione del prosciugamento della città lagunare così continua: “Le calli mostrano alla luce del sole le fondamenta imputridite da secoli” (p. 198). Non una goccia d’acqua nei canali, che “lasciano intravedere il fondo” (p. 198), il fondo di una Venezia putrefatta da cui cominciano a sprigionarsi gas che mettono in fuga gli abitanti.
Non diversamente Palermo, una città, lo apprendiamo fin dalle prime pagine, che è tutta un cantiere e dove, ed è ciò che l’avvicina a Venezia, non piove da due decenni, dove il cielo è “lucido come uno specchio” (p. 13). E ancora, rievocando zone della città note anche ai non palermitani e con una scrittura densa che si avvale di immagini che si incidono nella memoria del lettore: “Fuori, un cielo di smalto si abbassa su via Maqueda sfigurata: radure di lavori in corso […] si alternano a palazzi implosi, squarciati come quinte sul gheriglio fossile del centro storico” (p. 14). E subito dopo: “Più avanti, facciate regali sconnesse da crepe lunghe un palmo, velate da reti che ne imbavagliano i cornicioni, fanno pensare a un veliero a lutto, pronto a salpare.”
Ma se la fine e l’inizio dei due romanzi coincidono, non così il finale a sorpresa della grande, violenta pioggia che sembra come una benedizione volta cancellare e a purificare una città ‘sfigurata’ materialmente e moralmente e politicamente. Una prima avvisaglia della fine della siccità si ha quando l’Ambrosecchio ci avverte, con un linguaggio innovativo di cui a breve ci occuperemo, di un “ultimo sibilo di scirocco [che] coagula un’unica nuvola al centro della calotta, che manda aliti algidi, piccole scariche elettriche sulla pelle” (pp. 152-153). Poi, qualche pagina più avanti, “un tuono scassa l’aria […]”. E se, come si è visto, a Venezia la siccità provoca fughe di gas, qui, a Palermo, “la prima acqua sprigiona effluvi di verdure putride, suole marce” (p. 158). Poi, poi tutto si fa convulso, frenetico, spasmodico. È, come si è detto, la grande pioggia: “Piove, sì. Timidamente all’inizio, quasi osasse sfidare un veto divino. Poi un tuono dopo l’altro straccia la nube viola, che invece di dilaniarsi scende paurosamente di più, o è ciò che si mescola alla notte.” (p. 158).
È all’interno di questo scenario, di questo Grande Cantiere “che distrugge per ricostruire […] la Città Vecchia” (p.15), che si muovono nella vicenda narrata, i personaggi, che fanno il pendant, pur con qualche variante, con i protagonisti di Cico c’è. Q ui i personaggi principali sono tre donne (due ragazze, la fragile e ingenua Mariú, l’esuberante Erina, la saggia Rachele che in quarant’anni di professione di bambini ne ha visti nascere, meno che il suo) e uno maschile, Federico. In Cosa vedi, si ha un analogo numero di personaggi principali, quattro, ma con la variante che i personaggi maschili sono tre (Hagar, il fotografo, Hyppolite, il fioraio, Aureliano, il cliente misterioso, e uno il personaggio femminile, la sfuggente e altrettanto misteriosa Dana).
Ma ciò che caratterizza soprattutto i due romanzi. ciò che colpisce dell’Ambrosecchio è la scrittura o, se si vuole, la ri-scrittura della lingua italiana, la ‘cura’, ricostituente, cui la sottopone, obbligandola quasi a un bagno salutare, svecchiandola da modi dire e immagini di cui sono infarciti i romanzi dei nostri scrittori d’oggi. Dei quali è opportuno quindi andare a una ricognizione per meglio comprendere l’operazione compiuta dall’Ambrosecchio. Ecco alcuni esempi di scrittura tratti da romanzi usciti in Italia da cinque anni a questa parte: “Il mattino dopo, prima di andare al lavoro, Orsola scese le scale con la solita tazzina termica del caffè…”; “Prese a occuparsi quasi a tempo pieno della casa e dei bambini…”; “Poi, con un gesto, congedò il cameriere.” Ed ecco altre citazioni tratte da un libro di una scrittrice locale che pubblica con la Mondadori. Apriamo ancora a caso e leggiamo: “I quattro canti di città sono un palcoscenico a cielo aperto.”; “Il corridoio finiva con una porta pesante che dava accesso alle camere.”; “Marò non ci vide più, prese il piatto con le olive e glielo lanciò contro.” Ed ecco un esempio di un'altra scrittrice che va per la maggiore Apro ancora un suo libro e leggo: “Grazie al passaparola […]”.
E gli scrittori, ci si chiederà, come se la cavano? Riescono a impressionare il lettore dal punito di vista della lingua? Leggiamo anche qui alcuni esempi di autori noti: “Tornò a casa con i sacchi vuoti e un bel gruzzoletto di denaro” (un bel gruzzoletto di denaro, boh, roba da scuola media); “Rimasi a fissarlo. Non capivo e lui riprese a girare al largo” (girare al largo, un modo di dire così scontato); “il tono ironico della risposta lo aveva messo al riparo dal rischio di essere preso sul serio” (mettere al riparo, essere presi sul serio, frasi di ogni giorno, che sentiamo ripetere continuamente). Ed ecco, infine, un ultimo esempio. Traiamo dal romanzo di uno scrittore che esordisce in questo genere, mentre è più che noto nel campo televisivo: “La sera andai a disputare la finale del campionato di calcio”; “Promisi a me stesso che quel weekend mi sarei dato una calmata”; “Vidi Tommaso arrivare trafelato”. Potremmo continuare, ma non troveremmo nulla di nuovo. Siamo in presenza di una scrittura piatta, senza sussulti, senza picchi che lascino traccia nel lettore, senza fare violenza, ché di questo si tratta, violentare la lingua, ringiovanirla, renderla ardita e nelle costruzioni e nelle immagini. Anzi, si ha l’impressione che gli scrittori odierni facciano di tutto per cristallizzarla la lingua, per renderla omogena, comprensibile al massimo col preciso intento di non disturbare il cervello dei lettori, di lasciarlo in pace sottovalutandone la capacità di comprensione e comprfendonio. Tutto viene giocato sulla vicenda narrata che può essere più o meno accattivante per la ricostruzione di ambienti e per lo studio psicologico dei personaggi come nel caso della Ferrante con la nota quadrilogia che tanto successo ha riscosso e continua a riscuotere.
Con l’Ambrosecchio si è in un altro mondo, in un altro versante. Altro che Camilleri e la lingua posticcia che nessuno parlerà all’infuori di lui, altro che Ignazio Apolloni e la sua scrittura sia pur scintillante, con l’Ambrosecchio si va oltre. Bisognerebbe andare a un catalogo, se non proprio a un dizionario per comprendere a fondo il suo tentativo e chissà che in futuro non si dia inizio a un progetto del genere. Qui, ci limiteremo a dare alcuni esempi tratti dai due romanzi avvertendo che non c’è pagina quasi nella quale l’Ambrosecchio non lasci il graffio di una innovazione linguistica o di una immagine inedita che, negli esempi che seguono, evidenzieremo in corsivo, come si è fatto in precedenza.
Apriamo a caso Cico c’è: “Mariú si ripete che ha proprio ragione papà, ma talmente ragione che andando sente i suoi piedi staccarsi da terra” (p. 99); “Venezia è femmina. Non lo vedi subito. Planandoci sopra, un labirinto di terre fra le acque e acque fra terre: un’impronta di gheriglio” (p. 101); “Mariú si lascia inghiottire dalla penombra del pianerottolo” (p. 36); “schioda il pacchetto di Camel sprimacciato nella tasca del pantalone, lo corica buono buono” (p.26); “Ernesto salta su in allarme” (p. 163); “Alle sette, ora di visita, arrivano le zie: entrambe occhi aguzzi e culi alti sotto vesti chiazzate di fiori famelici” (p. 112); “Mariú pesta tre volte sul tasto del volume” (p. 197); “Ha una gran faccia abbronzata che scoppia di peli da tutte le parti” (p.87).
Vediamo, adesso, alcune esemplificazioni tratte da Cosa vedi. Fin dal primo rigo l’Ambrosecchio si presenta offrendoci un primo assaggio del suo inesauribile repertorio linguistico: “La sveglia elettronica scatta. Scarica chicchi di grandine” e, subito dopo un’immagine che si fissa per sempre nella nostra mente: “Il paralume avvampa nel buio al comando dell’interruttore.” E ancora, nella stessa pagina: “Scollo la lingua dal palato.” Basterebbero queste tre immagini per capire la naturalezza con cui la scrittrice sa maneggiare e padroneggiare la lingua italiana liberandola dalle pastoie cui siamo abituati vuoi per pigrizia mentale vuoi per rendere semplice e chiara al massimo la comprensione di un testo. D’accordo che gli studiosi del settore ci dicono che alte percentuali di italiani non sanno ricostruire ciò che leggono, guardano e ascoltano, ma qui non si vuole offrire un italiano complicato, difficile da capire anche per una persona culturalmente attrezzata. Non è questo, a nostro avviso, il problema che l’Ambrosecchio si pone e ci pone. L’Ambrosecchio peraltro – e ciò va rimarcato – insegna lettere in una scuola media della periferia di Palermo e quindi ha l’opportunità di guardare alle sorti della lingua italiana da un osservatorio privilegiato, che le consente di toccare con mano l’evoluzione e, meglio, l’involuzione della nostra lingua. Il problema quindi che la scrittrice tenta di risolvere non è quello di offrire un italiano complesso, che ne renderebbe quindi più difficile la comprensione, ma un italiano, una lingua accattivante, un linguaggio con cui divertirsi a giocare, accostando verbi e sostantivi in una forma fuori del comune scrivere se non proprio del parlare, ferme restando le regole che sottendono al loro costrutto. Ma, e ci avviamo alla conclusione, ecco altri esempi scelti a caso: “Ma sono i suoi occhi a farmi paura. Guardo la serrata dei pennoni, dietro di lei, da non distinguersi l’azzurro, il Promontorio in fondo, acquattato in riva al mare come una bestia narcotizzata nel sonno, le zampe tuffate nella spiaggia.” (pp. 65-66). A pagina 130 leggiamo: “Che dici, mi fai paura adesso… Come gli scatti di Aureliano, sì, quello dei tempi d’oro, il corpo di burro, gli occhi accesi”. E, infine, ma potremmo continuare ancora compulsando pagina dopo pagina: “ – Hagar…– respira Dana, un respiro come uno scroscio, mentre la porta tintinna richiudendosi” (p. 96).
Quali le conclusioni a cui pervenire? Il nostro convincimento è duplice: da un lato, l’Ambrosecchio non si pone il problema di inventare nuove parole, di sconciare la lingua italiana come fa notare Nino Agnello a proposito di Pirandello, né si propone di partire dall’italiano per arrivare al siciliano, come nel caso di Camilleri, il suo progetto è un altro, lei parte dall’italiano per arrivare…all’italiano, un italiano svecchiato, come si è detto, da modi di dire che ritiene superati, non più ripercorribili. Del resto, non a caso a un recensore del suo ultimo libro ha dichiarato che se avesse dovuto scrivere in maniera ‘classica’, e cioè piana, piatta, avrebbe rinunciato a scrivere. Ciò da un lato. Dall’altro lato, nutriamo l’impressione che con Cico c’è e con Cosa vedi si sia davanti a due romanzi di una trilogia non dichiarata tali e tante sono, e lo abbiamo mostrato, le relazioni e le connessione che legano i due romanzi mentre è certo che l’Ambrosecchio continuerà a offrirci una lingua – la nostra – in continua effervescenza ed ebollizione liberandola dalle scorie e dalle pastoie che l’appesantiscono. Mi auguro soltanto – e mi scuso per il riferimento personale – di non dovere attendere altri quattordici anni per vedere l’esito delle mie intuizioni. Sono troppi per chi, come lo scrivente, ha oltrepassato da qualche tempo le quattro ventine.