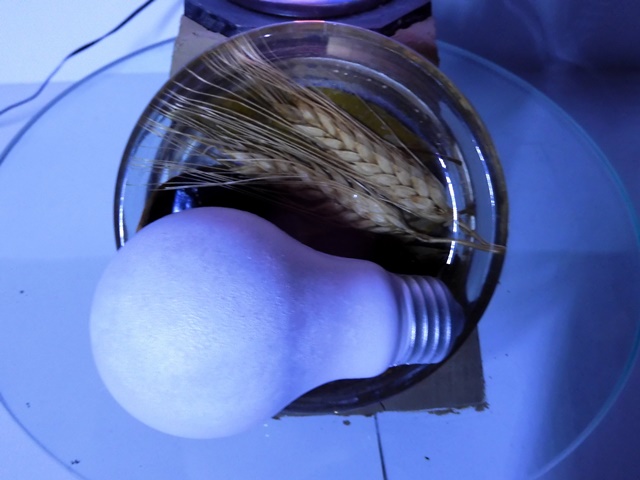Il giardino fra mito, simbolo e arte
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 17 Marzo 2018
- Scritto da Tommaso Romano
- Hits: 11078
 La mitopoiesi dell’Eden ci riporta nella grandiosa bellezza dei boschi e delle selve dove la forza della natura primigenia è congiunta alla primordialità incontaminata, incantata, eppure dove vivo è il riflesso della mano di Dio, del Dio o degli Dei. Aver trasgredito all’ordine divino, con un frutto di quell’Eden, è aver violato volontariamente tale ordine paradisiaco in terra e scontare così la tentazione che si manifesta nello smarrimento e nel velo squarciato.
La mitopoiesi dell’Eden ci riporta nella grandiosa bellezza dei boschi e delle selve dove la forza della natura primigenia è congiunta alla primordialità incontaminata, incantata, eppure dove vivo è il riflesso della mano di Dio, del Dio o degli Dei. Aver trasgredito all’ordine divino, con un frutto di quell’Eden, è aver violato volontariamente tale ordine paradisiaco in terra e scontare così la tentazione che si manifesta nello smarrimento e nel velo squarciato.
La nostalgia del Paradiso Terrestre, di un’armonia primigenia, è nel mito, nella tradizione, nella religiosità come legame con il sacro, non solo nella parola divinamente ispirata dell’universo simbolico e culturale ebraico-cristiano, ma sotto diverse forme e rappresentazioni in ogni autentica tradizione sapienziale che sente e canta la perfezione perduta.
Se il bosco e la selva sono reali quanto archetipici (si pensi a Dante quanto a Jünger), fondamenti di una visibile e portentosa forza che persiste (sempre più consumata dall’ingordigia espansiva umana, in ogni latitudine), il giardino è la possibilità che l’uomo si è data di ricostruire, ri-creare in spazi più o meno limitati, con arte non dissimile in fondo da quella che comunemente intendiamo come tale.
Le geometrie variabili, le piante, i fiori, i frutti sono coltivati, curati, per essere conservati, a sfidare il Tempo o per morire nel tempo e rigenerarsi da un seme, come concime per l’humus della terra.
Un giardino che si cura con amore partecipe è la possibilità, con infinite variazioni quasi musicali, di poter comprendere e contemplare, con partecipazione diretta, con pazienza e umiltà, riscoprendo lo scandire dei cicli e lo stupore di una nascita e la pena per ciò che fu rigoglioso.
Nel giardino che si possiede o che si ammira possiamo cogliere fantasia in azione, fascino, mistero, attrazione, sviluppo del sentimento, potenzialità di educazione estetica, l’odore che risveglia altri sensi senza artificio, il sogno, la sensazione che può divenire meditante contemplazione onde intuire attraverso il visibile le cose, dell’invisibile, la loro anima profonda.
L’arte è anche, linguisticamente, un congiungimento all’essenza, ma è anche contemporaneamente sé che è areté, Idea, Principio, che si riflettono nella bellezza e nella cura della bellezza che possiamo coltivare.
La tradizione ci ricongiunge al Giardino delle Esperidi con i frutti d’oro della felicità, alla rosa di Bellinda, a quella fresca, aulentissima, desiderata di Cielo d’Alcamo, e il frutto “lo quale sta né lo tuo giardino” nel desìo di sera e mattino. Nel giardino di Academo insegna Platone ad Atene, un luogo recintato e sacro; lo stesso giardino è il luogo della parola per Epicuro; Boccaccio fa le sue narrazioni in giardino; il giardino è l’apoteosi della regalità che si manifesta come bellezza a Versailles e Vienna, come a Venaria e a Caserta; nel giardino dei Finzi Contini si prefigura la tragedia. La poesia ha sempre avuto un cardine nel giardino come simbolizzazione e speranza rispetto a miseria e naufragio. E ancora il giardino degli Dei di Gilgamesh, l’isola dei beati, i giardini di Hallah e, non ultimi, i giardini che sbocciano nelle città quasi a contenere la caoticità del divenire, a Londra e al Luxembourg di Parigi, a Villa Borghese a Roma, a Bomarzo e all’isola di Borromeo, o a New York, nel labirinto parmense di Franco Maria Ricci, o nello splendore dei giardini d’Oriente, giapponesi e zen.
Molto pregnante è ciò che scrive Robert Pogue Harris nel suo Giardini. Riflessioni sulla condizione umana (Fazi, Roma, 2017): “È proprio perché siamo gettati nella storia che dobbiamo coltivare il nostro giardino. In un Eden immortale non c’è bisogno di coltivare, poiché tutto è già dato spontaneamente. I giardini umani possono apparirci come piccole aperture sul paradiso nel cuore di un mondo caduto, ma il nostro dover creare, mantenere e prenderci cura dei giardini tradisce la loro origine postlapsaria. La storia senza i giardini è un deserto. Un giardino staccato dalla storia è superfluo”.
Fecondare la terra, i deserti, è fondazione regale per la vita, dare un ordine a erbe e piante è un desiderio di cui si attende una manifestazione, è spinta dall’ideazione mentale e spirituale verso la creatività rivelatrice. Coltivare un giardino è coltivarsi nel discernimento, è proteggere e proteggersi. Tutti i pittori si creano il loro giardino di colori, trasparenze, venti e silenzi, di amori e fantasie, come i veri poeti sanno fare con la verità della parola che sanno risacralizzare. Artisti come ordinatori di materia, pietra, colore, suono, quando essi la vivificano di un fuoco interiore, di un desìo, dell’amor ch’è ditta di Dante. La pianta, il fiore sono un dono per l’altro e per sé stessi, senza paragoni con un banale regalo materialmente consumistico. Solo le pietre preziose, l’oro, stanno al pari. Espressione di umana felicità.
Nella sua opera Del principio Poetico, Edgar Allan Poe giustamente pone il giardino accanto alla pittura, alla scultura, alla musica, in particolare assegnandogli un ruolo “assai più specialmente e con più vasto campo di azione”. Perché il giardino è ritmo, armonia, come nell’Arte delle Muse, “la giusta rispondenza delle parti con l’intero”. Il “giardino come paesaggi” di Poe, simbolo della natura da cui sorge la poesia, supplemento alla bellezza come partecipazione e collaborazione attraverso l’uomo. Se il cosmo è “serie ordinata di creature” magnam citram come ci ricorda il sacerdote medievale Gerhoh di Reicherberg (cfr. Georges Duby, L’Arte e la società medievale, Laterza, Bari, 1977), l’uomo disegna il giardino secondo una composizione come nell’opera d’arte, alla ricerca della bellezza, del proporzionato, dell’armonia in unità, una koinonìa naturale, un legame che non soffoca, per poter intravedere nella bellezza, in quella bellezza, un’immagine dell’ordine celeste e della verità in cui potersi ritrovare, come a contemplare uno specchio del creato, dell’ordine universale che si riflette nel particolare, nel microcosmo.
Il Libro della Vita, dice Oscar Wilde, comincia con un uomo e una donna messi in un giardino, per “guardare in faccia la verità”. Questo smarrimento davanti alla presunzione dell’umano porta ad errare, al dolore. Ma la memoria del ricordo non si perde e si riscatta con l’albero della croce, di legno.
Non solo il patimento di Leopardi, nella metafora di ciò che si “corruga, langue, appassisce”.
La verità è eterna e rinasce, si pro-crea, come la vita di un fiore, di un bimbo, con la creazione nuova, in legami che non si possono recidere con l’universo e con Dio. L’arte, e l’arte del giardino, sono un tramite di questa ricerca e conoscenza, una virtude in atto, per evitare lo smarrimento, l’abisso, il nichilismo, il terrore.
Penetrare un’opera d’arte è pari alla felicità che si prova nel gusto di un frutto, al profumo che esala dal calice di un fiore, un piacere sublimato, magari nell’attimo, in un lampo improvviso, superiore allo scorrere del tempo caotico.
I giardini d’Oriente ci hanno portato fiori e pomi, agrumi, gigli, rose, melograni, cedri e aranci, essenze come la zagara, un tutto di splendore e luminosità, come lo sono i miti, le favole, le leggende, i simboli di cui sono carichi e quindi gravidi di bellezza. Il fiore d’arancio fu il mitico dono della Terra per le nozze di Giove e Giunone ed è rimasto simbolo dello sposalizio. Le nozze in cielo che continuano in terra, si rilegga la lezione di Eliade.
Si consideri, ancora, la raffigurazione preziosa dell’albero della vita nella tessitura sacra dei tappeti e nei tappeti-preghiera, oltre che in quelli usati dai musici, atti a riprodurre, ripetere, la connessione fra giardino-armonia-bellezza-invocazione metafisica e suo simbolo. E l’albero della vita è sempre presente anche in tessuti, mobili, vasellame di ceramica, in manufatti d’oro o argento, in fregi floreali si iscrivono pure versetti sacri. I fiori sono nei templi e nelle dimore domestiche, accompagnano la sorella morte corporale, e con i fiori si onora pure il corpo che giace e che ci è memoria di una vita e, spesso, di una felicità.
Il fiore del giardino e lo stesso bonsai sono intesi come un congiungimento, non a caso elevato a simbolo e costante nelle opere d’arte. Fiore, frutta, erba, hortus, giardinus, alberi, sono parole che l’uomo ha attribuito per evocare, si pensi alla fiaba, anche per questo si può parlare di verità del linguaggio (Attilio Mordini), il quale non è solo un suono o una fallace nominazione effimera, ma un valore che assume senso e di significato proprio nell’ulteriorità del simbolo. “Quel Giardino donne fiore ornato deve stare piantato l’arbore de la vita”, come canta Jacopone da Todi. La vita monastica benedettina ha, poi, il suo cuore nell’orto monastico che si congiunge alla preghiera, nell’ora et labora, così similmente è l’hortus deliciarum colmo di fragranze e delizie. Terreno circoscritto fu già così concepito nel mondo romano, e nella sua fisionomia ordinata scorgiamo la festa degli occhi, che è già la sintesi dell’espressione artistica, insieme alla musica, alla danza e al canto per una possibile felicità del cuore.
Anche il chòrtos, un luogo recintato per il pascolo, ci riporta all’idea vitale del nutrimento che la natura procura. Egualmente la coorte militare è una sezione limitata, come la corte regale, autonoma, fortificata nella recinzione. Anche il cortile ha una simile origine.
Inoltre, si è dottamente sintetizzato, “da chòrtos deriva il verbo chortàzo che significa mi nutro e mi sazio perciò chortasìa è il saziare e la sazietà, quindi la pienezza e l’abbondanza e anche il gaudio, che è affine a chàris. Se la parola italiana <cortesia > ha perso a poco a poco il suo contenuto d’origine trasformando la “gentilezza” della corte provenzale in un atteggiamento solamente formale, San Francesco, che ne sente ancora il senso completo, la chiama <una proprietà di Dio> e <sorella della Carità>, così come Dante, per la stessa ragione, si rivolge più di una volta al <Sire de la Cortesia>. Luogo circoscritto è anche il chòros, l’area dove il popolo si riuniva a invocare, con la danza e il canto, il favore di qualche divinità; perciò con lo stesso nome si indicava il luogo, la danza e il canto <corale>. E poiché si danzava di solito intorno alla statua del dio o a un oggetto ritenuto a lui sacro, il chòros si identificava con chiclos il cerchio, tanto che in latino chorus significava <danza in tondo> e, per traslato, l’armonico movimento degli astri e delle costellazioni intorno al sole (ovvero intorno alla terra, come allora si credeva). Sarà superfluo ricordare che di qui prende origine non solo il valore simbolico e coreografico della danza, quanto di tutte le relative figurazioni poetiche dantesche, dai cori angelici alla caròle (danze in tondo) degli spiriti beati; inoltre, ovviamente, si originano da questa parola anche termini di oggetti, dal noto e costante valore simbolico e sacrale, come corone, corolla. Com’è noto la figura geometrica che rappresenta l’idea di chiuso in assoluto è infatti il cerchio, il cui perimetro o circonferenza, non ha soluzione di continuità, come si dice per definizione, ovvero non ha né principio né fine, ed essendo perciò un richiamo all’infinito e all’eterno, ha avuto sempre, presso tutti i popoli, un valore sacro. Anche il termine <paradiso>, e non a caso, comporta anzitutto un’idea circolare ed è chiamato dai Testi Sacri hortus conclusus; è il giardino degli eletti, dove regna la felicità, che è pienezza di frutti, realizzazione perfetta dell’essere e sogno di ogni uomo sulla terra”. (Maria Antonietta Di Paco Triglia).
La perdita, insieme simbolica e sacrale, del valore da attribuirsi al giardino, all’orto, ha trasformato il concetto in” area verde”, in “fondo”, un’idea di paradisiache attese. Il pessimo uso del linguaggio corrente del cosiddetto “pollice verde” come un hobby fra gli altri. Così anche l’hortus gardinius si stempera nell’ecologismo più superficiale, nell’utilitarismo del verde pubblico, nella susseguente e scarsa definizione di ville e giardini pubblici, con conseguente incuria per i monumenti che vi albergano, nella perdita di concetto del centro di aggregazione, specie giovanile, se non per essere luogo per consumare droghe e sconcezze.
La perdita è anche data dalla manualità che la lentezza imponeva nella cura del giardino, con la sua proiezione, fatta di abilità e fatica, in quella humanitas che sosteneva il grado, il genere e il valore di una intera civiltà, non solo contadina, peraltro.
Privarsi concettualmente, idealmente e materialmente del valore derivante dalla terra da coltivare, ingentilire, far fruttificare e far diventar sempre più bella, è una perdita contro natura, un segno ulteriore di dissoluzione, che snaturano l’ars del fare, del creare. Tutto si riduce a sofferenti piante d’appartamento, fra fiori finti e bonsai non amati, scordando l’arte dell’ikebana. Lievi segni di una sensibilità al tramonto, di una cura che va invece ridestata nel profondo perché, malgrado le suggestioni commerciali e la veicolazione delle stanze nude di tutto, a cominciare dall’anima di chi vi soggiorna, rivela una pur tenue nostalgia, magari assai degradata o sopita.
Perché piantare, coltivare, è un segno arcano, un dato di vitalità che vuole prolungarsi nell’esito sublime di un fiore, di un frutto, è l’aspirazione a non perire, perché raccogliere un frutto è pari alla contemplazione di un’opera d’arte viva, non morta.
Dolore è, invece, l’infecondità, il vuoto, la terra desolata e brutta, la tela bianca, la pietra non sbozzata, la parola che non esprime verità, la musica disgraziatamente sconnessa rispetto all’armonia.
Coltivare la terra è un’arte come coltivare la propria anima e personalità; il solco era considerato sacro come lo era Il tocco di un pennello che ritraeva la Madonna da latte.
La fretta, la velocità, la superficialità sono il contrario della pazienza, dell’attesa, del saper aspettare e far maturare l’opera dell’ingegno o della terra, intesi come consapevolezza dell’essere che lega al mistero della terra e dell’universo che manifestava Dio, la Sua gloria, potenza, benevolenza e misericordia.
I “campi” dello scibile, macroscopicamente ingranditi, sono appannaggio di pochi specialisti e arati dalla finanza speculativa esattamente come avviene per il mondo dell’arte. Le stesse lettere dell’alfabeto, come avviene nella kabbala che li ritiene elementi propri dell’Universo, si identificavano con i numeri e con le figure geometriche: “Dedicarsi alla conoscenza degli uni significava trovare paralleli con le altre; studiare i fenomeni naturali era rapportarli al corpo umano e questo al Cosmo e a Dio.” Il mondo georgico era vissuto e sentito come parte imprescindibile della speculazione umana dai filosofi, matematici, letterati, fisici, astronomi, medici, mistici e artisti i quali erano ritenuti, con i sacerdoti, i nobili sintetizzatori delle discipline e della cultura a misura d’uomo e da proiettarsi, come un virgulto, dalla terra all’infinito: coltivazione e cultura trovano la loro affinità nel concetto fondante di plasmare la materia (terra o uomo) e trasfondervi un seme di vita secondo una forma, per la sua crescita materiale, intellettuale e spirituale, nel contingente e nel trascendente, nel molteplice e nell’Uno come fonte primigenia, origine.
Coltivazione, culto, cultura, arte sono legate, anche nell’etimologia, e rispondono al movimento circolare dell’universo verso l’ignoto, l’infinito: è la dynamis, che dà sostanza ai cicli stagionali e alla forma linguistica, alla rappresentazione per immagini e alla luce dell’intelletto nell’ordine naturale che è ordine cosmico che da Dio proviene e che si manifesta con l’epifania del sacro, con il culto. Ecco che coltivazione, cultura e culto si riconoscono e si legano senza scissioni.
La crisi della modernità sta tutta in tale perdita di consapevolezza e di interrogante necessità, nel misconosciuto dettato dai cicli e dalla natura nella forza creativa, intellettiva, morale e quindi artistica che li sostiene.
Il giardino è, quindi, parte dell’architettura del sacro, della suggestiva manipolazione artistica della terra che si mette in opera, come un lembo di cielo in terra, esso è stato sempre presente in miti, riti, tradizioni, religioni, fiabe, storia e nella creatività d’arte, insomma.
Fare è realizzare la visione, il pensiero, e l’opera d’arte è anche nell’ideazione e messa in opera del giardino che si realizza, si ammira, e che poi si assapora con tutti i sensi e con lo spirito che eleva verso l’alto, che tende all’Assoluto. Il sottosuolo è, invece, l’humus, la patria delle radici, la terra degli avi dove pure riposano i corpi, o, come soprattutto per moda avviene oggi, nella pratica della cremazione che, comunque, disperde simbolicamente le ceneri alla terra e al cosmo.
La scala di Giacobbe, le zikkurat dei Sumeri dai mille, così gradini come i templi del Messico, i monumenti di Genizah, le piramidi, i giardini pensili della Babilonia, la colonna e l’architrave, la ricerca della luce, come approdo di conoscenza e di bellezza nelle cattedrali gotiche, con le vetrate multicolori istoriate con la rappresentazione della vita sacra, come pure si manifestava nelle pareti istoriate di pietra o di affreschi o di campi musivi, come giardini fioriti di mille colori, confermano la grandiosità artistica che si riassume nella mirabile e insuperata immagine dantesca del “giardino di Cristo che s’infiora”; sfondo, orizzonte, quasi obbligato per l’arte sacra, infatti, era quasi sempre un giardino a dimostrare che la bellezza è attributo non decorativo reso alla Verità. Solo per citare, ricorderemo inoltre la visione dei Preraffaelliti e dell’arte floreale nell’Art Noveau e quindi del Liberty, o nel Parc Gruell di un genio come Gaudì.
La coltivazione è, quindi da considerarsi, autentica cultura, quando queste si divaricano, si ignorano, si contrappongono giunge inesorabile la crisi dissolutiva, la riduzione all’esteriorità, la banalizzazione grottesca dell’etica, la sessualità senza eros e amore, la visione senza contemplazione. L’opera e l’opera d’arte così si sfaldano con orgoglio autoreferenziale nel proprio rettangolo, senza alcuna paziente coltivazione e cura, senza sentire necessità di una materia da plasmare e senza avvertire l’urgenza dell’acqua che disseta, fortifica e fa vivere.
Non è secondario, ancora, rammentare il simbolo proprio del Getsemani, dell’orto degli ulivi, nel luogo in cui Cristo volle vivere.
Il giardino non è, come qualcuno sostiene, una sorta di violenza su boschi e selve, intese romanticamente e quindi incontaminate, dato che il paesaggio - come ha insegnato il sommo Rosario Assunto - è opera dell’uomo che lo ha plasmato o violentato a seconda delle circostanze e del degrado di civiltà di un popolo.
Il giardino, come opera d’arte esso stesso, non è quindi prepotenza dell’uomo sulla natura. È una forma altissima di cooperazione con la natura e con il Creatore. La sacralità della natura può esaltare o degradare la maggior natura dell’uomo, come dovrebbe fare un maestro, un padre, nei confronti dei fanciulli.
Legame è atto di religiosità che si nutre negli altri elementi supremi, acqua, fuoco, aria, come intuirono i nostri antenati con l’intuito e con l’ordine della ragione, coniugato alla nativa creatività iscritta nel cuore dell’uomo.
In un hortus, come abbiamo ricordato, nacque la filosofia e pure nell’ hortus del convento di San Marco, a Firenze, cominciò la sua arte Michelangelo che, affermò, “vince la natura”, oltre il tempo e la morte. Analogamente avviene per il Rucellai e cento altri, alla ricerca della platoniana e poetica “natura prima”.
Il seme divino che scende nell’animo umano è costituito di una specifica sua responsabilità per farlo germogliare con l’opera o lasciarlo invece essiccare, perire.