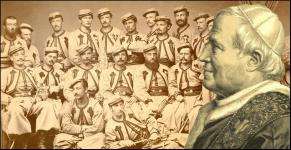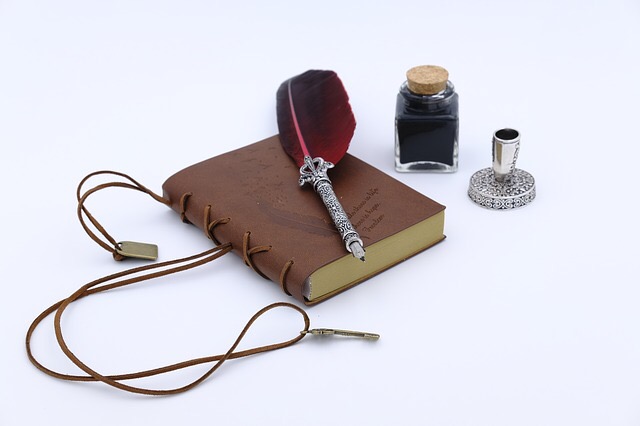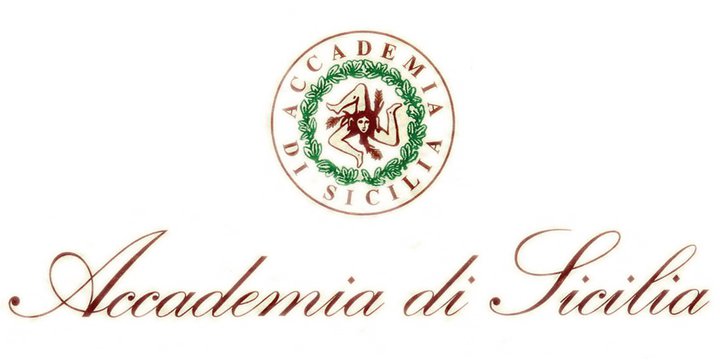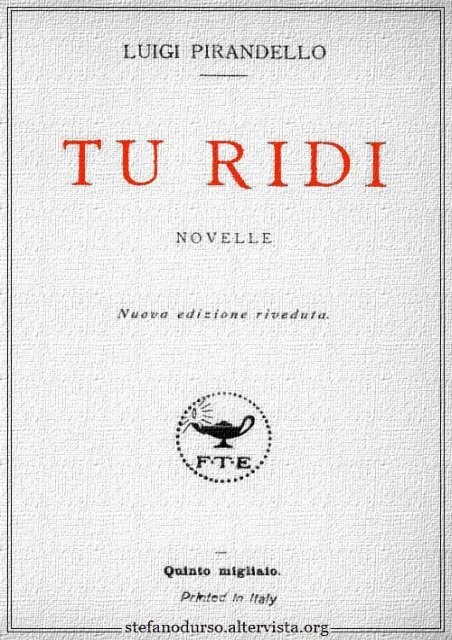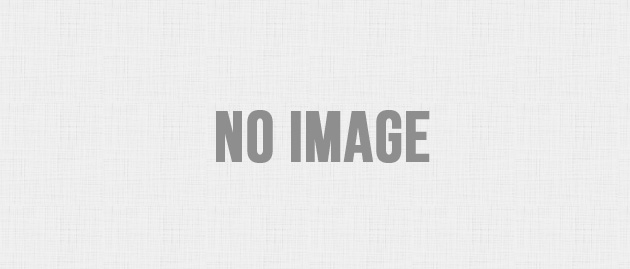“Sapori e tradizioni di Sicilia nelle pagine autobiografiche di Ercole Patti” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 21 Febbraio 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 709
 Il dono della scrittura di Ercole Patti sta nella naturalezza con cui cose, persone, piccoli animali selvatici e domestici, si collocano nel loro contesto specifico, conservando la spontaneità e la freschezza dei diversi ritmi vitali, ma anche il malinconico struggimento del rapporto inevitabile con il tempo, la morte, la disillusione, la vanità sostanziale dell’esistere. Tale dialettica negativa, tipicamente novecentesca perché giocata sul versante della perdita, del “lutto”, innesca il meccanismo della nostalgia, del ricordo, della ricerca della felicità perduta, che illuminano la caratteristica di fondo del suo “narrare”: l’andare a ritroso, il tornare sui propri passi.
Il dono della scrittura di Ercole Patti sta nella naturalezza con cui cose, persone, piccoli animali selvatici e domestici, si collocano nel loro contesto specifico, conservando la spontaneità e la freschezza dei diversi ritmi vitali, ma anche il malinconico struggimento del rapporto inevitabile con il tempo, la morte, la disillusione, la vanità sostanziale dell’esistere. Tale dialettica negativa, tipicamente novecentesca perché giocata sul versante della perdita, del “lutto”, innesca il meccanismo della nostalgia, del ricordo, della ricerca della felicità perduta, che illuminano la caratteristica di fondo del suo “narrare”: l’andare a ritroso, il tornare sui propri passi.
Del catanese Patti (1903/1976), scrittore giornalista sceneggiatore cinematografico, sono più noti al grosso pubblico i romanzi Un amore a Roma (1956), La cugina (1965), Un bellissimo novembre (1967), Graziella (1970), anche per la loro realizzazione filmica rispettivamente nel 1960, 1974, 1969, 1973. Ma interessanti risultano pure i due testi più direttamente autobiografici: Roma amara e dolce (1972), dove l’autore ripercorre il progressivo realizzarsi della sua precoce e ostinata (nonostante l’opposizione paterna) vocazione letteraria, dall’adolescenza catanese all’ombra dello zio poeta Giuseppe Villaroel ai primi anni romani al definitivo, ufficiale, ingresso nel giornalismo della capitale (collaborazione al Tevere, Gazzetta del Popolo, Il popolo di Roma) e nel mondo letterario; e Diario siciliano (1971; 1975), dove raccoglie, ma andando qui all’indietro, dal 1974 al 1931, brani scritti in momenti diversi della sua vita, figurandovi ora come io narrante, ora mimetizzato in terza persona o in un “noi” di gruppo. In Roma amara e dolce il cibo “catanese” fa da contrappunto trepido e intimamente gioioso in due singolari episodi della vita dello scrittore. Il primo lo vede bambino in fuga per un giorno dal Collegio Pennisi di Acireale, retto dai gesuiti, dove stette dai 10 ai 12 anni per volere del padre che riteneva il collegio con la sua disciplina indispensabile alla formazione dell’uomo, mentre afferma Patti: <<nella vita non ho mai sofferto più atrocemente di quando mi trovavo in collegio. Rientrare in quelle aule, in quei lunghi e tetri corridoi dopo le felici vacanze pasquali e natalizie era come morire>. Ed è proprio a un rientro forzato post-vacanze di Pasqua che, fingendo di avere dimenticato di dire una cosa al nonno che lo ha appena riaccompagnato, esce di corsa dal portone di quel palazzone bucherellato, sale su un tram e se ne torna a Catania, girovagando da solo per le strade della città e dentro la Villa Bellini fino al tramonto, assaporando -scrive- un po’ felice e un po’ spaventato quella doppia libertà dal collegio e dalla famiglia, e placando la fame alla rosticceria Giardini e Montanara in via Etnea, dove sul banco erano esposti gustosissimi arancini tiepidi e fragranti; quelli rotondi con la carne dentro e quelli conici con la mozzarella e l’uovo sodo. Ne mangia quattro, due di ogni tipo, avidamente, e quando a sera si presenta a casa dei nonni che non pensano affatto a sgridarlo, gusta a coronamento del suo giorno “rubato” di libertà infantile le verdurine serali cucinate dalla affezionatissima nonna cinquantenne, la frittata arrotolata chiamata “pesce d’uovo”, le pere che essendo state appese in cantina per maturarsi avevano ancora attaccato al gambo un pezzetto di spago, insomma quei cari cibi -sottolinea lo scrittore adulto- di casa mia che mi davano l’emozione di essere libero. Altrettanto liberatori saranno in uno degli ultimi capitoli del libro i ricordi suscitati dalla vecchia rivoltella del padre, la piccola Velodog, che affiora dal vaso di fiori dove la ragazza di allora di Patti, Nic, l’ha nascosta dopo il suo arresto, il 1 ottobre 1943, da parte dei repubblichini fascisti nella Roma occupata dai nazisti. Rientrato dopo quattro mesi stressanti di carcere, uscito in terrazza nella luce di una mattinata di gennaio (ma la sera di quello stesso giorno dovrà di nuovo fuggire e nascondersi), recupera la rivoltella dal vaso, la ripulisce e viene annotando, in un momento di tregua interiore, che gli ricordava gli anni felici della [sua] infanzia, certi autunni siciliani, [il] padre giovane e allegro, gite di ottobre nei castagneti intorno al Milo sull’Etna, l’odore gustoso delle salsicce d’autunno che rosolavano nelle cucine delle vecchie case di campagna e l’odore si spandeva in giro attorno alle antiche cisterne vellutate d’erbetta umida, attirando i gatti che miagolavano eccitati. E la Sicilia, con i suoi paesaggi, luoghi, atmosfere, care tradizioni, e con tutto il vissuto personale dello scrittore, esplicito o implicito, fa da invadente e qua e là esuberante protagonista del Diario siciliano, opera che chiude a inizio anni Settanta la parabola psicologica dell’uomo e dell’intellettuale Ercole Patti, perché in essa il binomio vita/morte, dopo il crescendo di cupezza e pessimismo esistenziale consegnato ai romanzi sopra citati e al loro travagliato, tragico, erotismo, viene esprimendosi e distendendosi in toni pacatamente “elegiaci”, in un atteggiamento cioè di tranquilla accettazione ormai dello scorrere vanificante dei secoli e della Morte, e di pietoso sorriso sulla futilità degli egoismi e passioni umane.
Sul “trionfo” della Morte prevale infatti nel Diario il canto disteso e arioso della felicità perduta dell’infanzia e della adolescenza, quando il mondo si presenta felice ed eterno… e nessuno pensa che un giorno dovrà morire (Il pometo), quando si sentono sotto la mano il proprio braccio o il proprio ginocchio elastici con tutti i tendini vivi e leggeri (L’adolescenza), quando anche il gusto del cibo si impone come segno/sintomo evidente e “materico” di tale incontenibile, sensuale, vitalità. Nell’adolescenza -scrive Patti- l’acqua del mare nei tuffi dal trampolino della scogliera di Guardia Ognina a Catania scorreva sul corpo compatto e abbronzato in un desiderio struggente della pasta con le melanzane che aspettava a casa sotto un piatto capovolto ancora tiepida, desiderio simile come intensità a quello di vedere gli occhi della figlia dell’avvocato che si affacciava alla bassa finestra della casa di fronte. Molte pagine del Diario ricreano efficacemente proprio questa indeterminata, adolescenziale, tensione vitale e “felicità piena” del corpo e dell’anima recuperabili attraverso la “memoria”, che nel libro or ora citato coincide pure col potere, tutto “fisico/sensoriale” anch’esso, di evocazione di un vecchio mobile, di un oggetto antico restaurato, di una estemporanea escursione nell’oggi sull’amata montagna Etna o in campagna, col restauro stesso nel 1956 della casa paterna immersa fra i limoni in un tratto di territorio tra Catania e Taormina. O ancora, con la villetta nuova di un colore rosa sbiadito che nel 1962 Patti si farà costruire dentro un vecchio uliveto, davanti al mare di Pozzillo (Acireale), con l’intento specifico -precisa- di ricreare il clima felice e struggente di “quel” tempo, con nonni, genitori giovani, ragazzini scorazzanti nei boschi e nella campagna, cugine con le trecce, parenti e amici villeggianti fra castagneti e vigneti, tutti dolcemente avvolti dall’alone di sapore di certi cibi (maccheroncelli con le melanzane, salsicce arrostite) e odore di certi vini e mosti, quale quello che ancora veniva sprigionandosi nel 1963 dai due tavoli rotondi di castagno fatti ricavare dallo scrittore a un falegname da vecchi fondi di botti dei suoi bisnonni, botti che avevano contenuto mosti e vini dei tempi di Garibaldi. Doveva la villetta “restituire” a lui inurbato a Roma -scrive nel 1963- il ricordo di certe case autunnali dell’infanzia in campagne poco lontane da qui, ricordo rimastogli nella mente (e l’abbiamo visto nel precedente brano di Roma amara e dolce) come l’espressione più alta della felicità (sic!). Insomma una casa/medicina per alleviare un poco quelli che nel 1974 chiamava i traumi e le ferite che infligge la vita di oggi, sintetizzandoli nella immersione e ritorno obbligati nel clima [cittadino] dei motori a scoppio, insalate minacciate da epatite, cozze forse al vibrione, sequestri di persone e quotidiane rapine con sventagliate di mitra e di morte (Erano gli sciagurati anni di piombo!). Donde, per reazione, il procedere “a ritroso” del Diario di cui si diceva all’inizio, che crea, entro il vasto incanto del paesaggio etneo, delle sue stagioni, e di certe consuetudini del costume siciliano, una continuità di inebrianti esperienze sensoriali, fra felicità “passata” rievocata e felicità “attuale”, cioè parzialmente ritrovata nella vita adulta o senile in tutte quelle scaglie minute di esistenza quotidiana che riaccendono, pur sotto il peso della delusione esistenziale, guizzi frammentari dell’eterno, accorante, empito vitale.
Il mare limpido, non ancora inquinato ad esempio di Pozzillo in estate con la vista di ragazzi e ragazze che pescano ricci o raccolgono patelle con il coltellino, o le stesse immersioni di Patti in esso con la maschera, gli ricordano il mare catanese dell’adolescenza che lo inebriava con il sapore degli spicchi color ceralacca dei ricci lattiginosi e con quello delle patelle e degli occhi di bue carnosi che rabbrividivano sotto le gocce di limone. Parimenti, delle triglie acquistate ad Acireale in un novembre del 1956 col proposito di arrostirle sulla carbonella appena appena inumidendole durante la cottura a brevi intervalli con un ramoscello di prezzemolo intinto nell’olio e limone, nel programmatico distanziamento del “suo” pensiero dalla gara atomica e spaziale allora in atto tra Usa e Urss, gli suggeriscono questo singolare “affettivo” elogio degli umili pesci: meglio occuparsi delle triglie che sono sempre le nostre care triglie siciliane con quell’odore vivo di mare, spruzzate di carminio, identiche a quelle di quando ero bambino e a quelle che mangiavano i miei bisnonni. Una “immobile” adolescenza dei sensi vogliono dunque riguadagnare e fissare molti brani del Diario attraverso i ciclici ritorni dello scrittore in Sicilia, e le particolarità di alcuni cibi (sapore, odore, vista, preparazione) e il pittoresco dei mercati (Pozzillo, Acireale, Catania) nei loro colorati dettagli rappresentano per il suo spirito disincantato una fra le tante forme cercate di sensuoso, gratificante e per così dire “retrogrado” appagamento. Perciò rinasce nel ricordo il sapore delle granite di mandorla post-siesta pomeridiana dell’estate del 1920, preparate in casa con la neve dell’Etna, trasportata dai muli in grosse balle pigiate e pesanti avvolte in un involucro di felci e tenute poi nel buio fresco della cantina del vinaio sotto una coltre di foglie secche, sapore che sciogliendosi in bocca si associava al pensiero della figlia dell’avvocato e dei suoi occhi nocciola che guardavano dall’alto del balcone di antica pietra bianca. E con le granite, i gelati della Birreria Svizzera serviti nel pomeriggio ai tavolini allineati sui marciapiedi in ombra di via Etnea dai lastroni di lava poco prima innaffiati dai potenti getti dei fontanieri del Municipio. Un ottobre del 1932 restituisce una vendemmia a Monte Ilice con i pigiatori, con calzoncini corti e scarponi massicci zuppi e arrossati di mosto, che cantavano e ballavano allegramente, a grandi pestate tenendo i pollici infilati sotto le ascelle alle maniche del panciotto, mentre la massara davanti alla porta del palmento preparava per loro la colazione: grosse fette di formaggio salato e oleoso, acciughe, peperoni arrostiti, grandi fette triangolari di pane fitto e pesante, un bariletto di vino rosato e limpido. Diversa la colazione del padrone, che gli arrivava da casa in due piatti avvolti in una salvietta: polpettine, uova fritto, un pezzo di caciocavallo piccante, una bottiglia di vino a cui la massara aggiungeva un grappolo d’uva speciale, dura e dolce. E non mancano a completare il prezioso rustico tableau, implicitamente pregno di ricordi infantili, le vendemmiatrici che cantavano nella vigna curve sulle viti, i carrettieri che arrivavano nel pomeriggio con gli otri sgonfi da riempire e portare nelle varie cantine del paese, e il ragazzo che con un sasso lanciato fra i rami di un grande castagno faceva cadere un grappolone di castagne verdi e spinose sì che dalla crepatura del riccio facevano capolino le castagne lisce e lucenti, di mogano. Ma non meno forte del fiato pungente del mosto in fermentazione nelle tine e che dava un leggero senso di vertigine sarà in un novembre più tardo del 1969, nel frantoio di un paesetto vicino Pozzillo, l’odore dell’olio nuovo ricavato dall’autore dai pochi olivi della sua villetta rosa, costruita appunto negli anni Sessanta. Ogni cosa -scrive nel Diario- nell’ampio camerone del frantoio è imbevuta di questo potente e sano (sic!) sentore che riempie le narici e sembra attraversare i vestiti e le suole delle scarpe. Un Natale del 1952 “rappresenta” (e restituisce al ricordo negli anni Settanta) una via Etnea sconvolta dai lavori di ristrutturazione di selciato e marciapiedi per la nuova fognatura e per i tubi dell’acqua, della luce, e del gas e tuttavia formicolante di passanti che portano in mano cartocci e pacchetti festivi, torroni, panettoni e soprattutto cassate di ricotta ricoperte di canditi, morbide e fragranti, mentre dai Caffè arriva il profumo dei loro meravigliosi espressi realizzati con almeno tre miscele diverse…. studiate e dosate da gente che ha il culto del caffé… e mentre dal fondo di Piazza Duomo dietro la scrosciante fontana dell’Amenano infuria il gran mercato della pescheria (tonni, alalunghe…) e nelle stradine vicine piramidi di carciofi salgono dai marciapiedi fino ai primi piani accanto a mostre di salsicce, capretti sventrati, soppressate tra il vocio misto e sonoro dei venditori. Una festa degli occhi e dei sensi!
Altrettanto raffinate come i Caffè catanesi e sempre allettanti nel trascorrere degli anni e in ogni mese dell’anno si presentano le dolcerie di Acireale ricche di paste cassate gelati e a novembre di dolci dei morti (tibie, piccoli scheletri di zucchero calcinato su basi di pasta croccante), e mattiniero e altrettanto animato e variopinto è il suo mercato: la piazza, nel brusio mattutino, è vitalisticamente piena di ceste e di pesci freschissimi, di grandi tonni compatti, di aguglie, di triglie, di polipi… le botteghe… di carni macellate, di fette di baccalà, di salsicce, di caciocavalli rettangolari, di pani croccanti e dorati, di frutta colorata. Una visita novembrina del 1966 a un aranceto fornisce l’occasione allo scrittore per le dettagliate descrizioni di una melagrana (ma -precisa- per lui mangiare un melogranato, sin dai tempi dell’infanzia, è sempre stata una piccola delusione), delle arance e dei mandarini ancora verdi tra le foglie, dei mandaranci invece già primaticci, e della singolare colazione alle otto del mattino del mezzadro, del fratello e del figlio, i quali, su uno sfondo di cani spinoncini e cirnechi festanti e galline bianche e grossi galli e conigli nei grandi recinti, stanno arrostendo e ripulendo certi loro speciali peperoni tozzi e grassi la cui polpa sul piatto ha lo spessore di una bistecca, peperoni che, chiacchierando di ladri di polli, mangeranno stillanti di olio buono con grandi fette di pane di casa di puro frumento. Altrettanto particolareggiato e compiaciuto il racconto del pranzo rustico approntato in un ottobre del 1955 a Cassone, a più di mille metri sull’Etna, in un pometo con salsiccia, due o tre tipi di formaggi e vino nero. A mano a mano che andavamo avanti nella salita -scrive- l’aria diventava sempre più fina e penetrava nei polmoni purificandoli (sic!). Le mele avevano -aggiunge- le bucce tirate e lustre come se fossero di marmo lucidato e… lucevano in mezzo alle foglie come levigate dall’aria di montagna. Mentre assaggiano, in questo sempre nuovo tripudio della Natura e della vita così carnalmente intenso, lui e i compagni le mele offerte dal massaro (le varietà “Testa di re” venate di giallo e rosso e le “gelate” di un verde pallidissimo che nell’interno duro e fresco avevano irregolari zone di gelatura quasi trasparenti, di sapore gustosissimo), uno di loro arrostisce le salsicce su due grandi tegole ricurve e man mano -puntualizza lo scrittore- che rosolavano le andava rivoltando con un virgulto appuntito pungendole leggermente perché sfiatassero e lasciassero colare il grasso tenero, che imbeveva la terracotta, spandendo intorno un odore inebriante. Più elaborati sono stati invece sempre i pranzi casalinghi del quasi sessantenne e scapolo don Pietrino (una delle tante controfigure di Patti) consumati abitualmente (e ancora sensuosamente nel flusso dei ricordi di un settembre del 1957) nella vasta sala da pranzo della grande casa padronale, sul grandissimo tavolo ovale: quante costate di maiale, quanti timballi di riso con l’uovo sodo dentro e falsomagri [i tipici rotoli di carne farcita con uovo sodo, prosciutto, verdure…] e spaghetti con le melanzane! Ma negli anni ultimi delle villeggiature a Pozzillo (‘62/’74) dello scrittore nulla avranno da invidiare ai pranzi di don Pietrino le cene estive di Patti sulle terrazze illuminate affacciate sul mare, con la luna piena che splende nitidissima, con il respiro del mare fra gli scogli di nera roccia lavica, e con sulla tavola piatti di peperoni gialli e verdi arrostiti, olive nere e fette di pesce spada cotte sulla carbonella, o la “gran pace” mattutina e serale (allora!) del piccolo paese marinaio. Il bar di Pozzillo che apriva alle 5 del mattino, l’accendersi con la primissima luce della bottega della fornaia, del negozietto di detersivi e formaggini, della saletta del barbiere-giornalaio, l’arrivo alle sette delle prime barche da pesca con i pesci più piccoli mentre quelli più grossi arrivavano a mezzogiorno o nel pomeriggio (tonnacchi, palamidi, spada, caponi, dotti, giovanissimi squali, cernie). E lo scrittore anziano indugia, compiacendosene, sui pesci piccoli brulicanti nelle ruvide cassette di legno con luccichii di argento bagnato le alici e le gostardelle o splendori di carminio le triglie e gli scorfani. Squisite -dice- le gostardelle, soprattutto arrostite sulla carbonella; il piccolissimo cicirello invece -viene ancora insegnando- si può mangiare crudo, o fritto, o bollito in una gustosa poltiglia con olio e limone. E da friggere sono i pesci chiamati sorci per i loro dentini aguzzi, pesciolini rosei e piatti -osserva- di una vitalità irrefrenabile (sic!).
E proprio questi pesci/sorci si possono -forse- assumere come metafora del senso doloroso, disperato, della vita per Patti. Mordono infatti i sorci le mani delle donne che li puliscono per friggerli e a volte -aggiunge lo scrittore- anche dopo sventrati saltano giù dal piatto sul pavimento (in fuga dalla morte?) e raccattati continuano a mordere coi loro sottili dentini da topo.