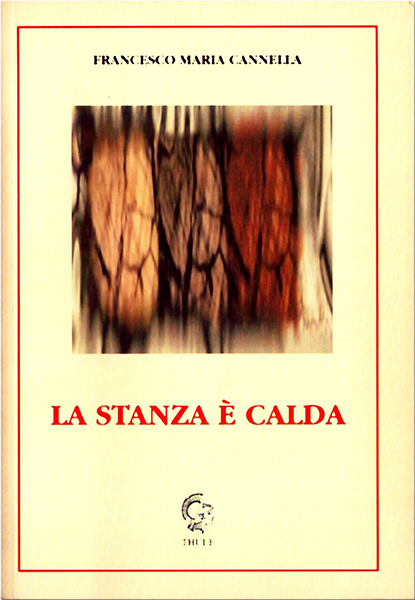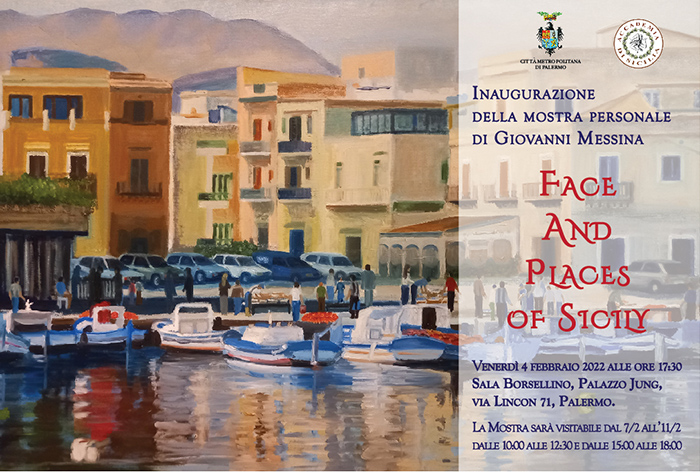Guglielmo Peralta recensisce “La morte di Empedocle” di Franco Di Carlo (Ed. Divinafollia)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 28 Aprile 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1933
 “Ormai Empedocle è morto e con lui
“Ormai Empedocle è morto e con lui anche la voce degli dei e dell’essere
fatale destino dell’Occidente,
il dire ermetico e il travestimento metafisico:
una grande illusione senza avvenire”
(F. Di Carlo)
Possiamo considerare la leggendaria morte di Empedocle, il suo “precipitarsi” nelle viscere dell’Etna, una metafora legata alla ricerca di quella verità, “principio” o archè di tutte le cose, che troviamo a fondamento nella storia della filosofia presocratica e che egli pose al centro della sua riflessione. Delle quattro “radici”, cui egli fa risalire l’origine di ogni cosa, il fuoco è il primo elemento dal quale sarebbero derivati gli altri tre e, dunque, preferito da Empedocle in quanto espressione di creatività e di potenza, già considerato tale dai filosofi greci e, in particolare, da Eraclito secondo il quale il cosmo avrebbe avuto origine proprio dal fuoco. E perciò non è da escludere che esso sia stato associato metaforicamente al Lògos, al soffio vitale del divino Zeus col quale il primo elemento era identificato. Fuor di metafora, allora, la “morte” di Empedocle è da interpretare come la grande ‘devozione’ del Filosofo al dio, alla verità dell’essere, al Pensiero, e, dunque, come gesto sacro, ‘ideale’, come brama di ritornare alla prima ‘radice’ per raggiungere la felicità, la vita autentica nella piena e perfetta unione con quella divinità ardente. Solo un simile gesto può avere mosso Hölderlin a dedicare al filosofo politico agrigentino un poema, “La morte di Empedocle”, appunto, anche se, nella seconda stesura, il poeta tedesco lascia supporre che quel “sacrificio”, quella decisione sacra sia stata un atto di ribellione e di libertà contro l’ordine politico costituito della sua città, nonché un’hybris, al punto che il “suicidio” vi appare involontario, come un disegno divino. Ma noi propendiamo per il primo motivo: filosofico, poetico, ontologico, perché tale, pregno di simile sostanza è il pensiero di Hölderlin, versato nella sua poesia. Ed è il medesimo motivo che, sicuramente, ha sollecitato il nostro Franco Di Carlo ad elevare un canto ad Empedocle con un componimento che reca il medesimo titolo hölderliniano, dal quale traspare il suo grande interesse sia per il filosofo che per il poeta, oltre che per la vicinanza dei temi, anche perché in loro si rispecchia la sua anima, la quale si nutre del medesimo sentimento della bellezza, e dunque, dell’amore, della passione per la poesia e la filosofia, che egli coglie nella loro identità in quanto entrambe pensiero poetante al “servizio” dell’essere, verso il quale si pone in cammino il linguaggio poetico che cor-risponde a quel pensiero. Perché l’uno si esprime in versi, l’altro fa il verso al pensiero. E in quanto hanno in comune la meta e cioè l’essere, e ne indagano la natura divina e la potenza creatrice, costituiscono insieme una nuova ontologia, la quale anima l’intero poema del Nostro, che si apre col grande “Monologo”: “un silenzio che parla con se stesso e dice l’essere / prossimo alla voce”. E ciò in linea col “profeta”, la cui parola mette in atto “un processo ontologico che viene dal profondo” e che segna quel cammino necessario in questo nostro tempo della povertà, ancora più povero di quello denunciato da Hölderlin e il cui avvento questi fa risalire alla morte del filosofo agrigentino, con la quale viene meno, come ci ricorda Di Carlo, “anche la voce degli dei e dell’essere”. Perché dopo Empedocle ha inizio quella fuga degli dei che si compie con la crocifissione del Cristo e che fu “fatale all’Occidente” proprio in quanto l’essere, secondo la lezione di Heidegger, sarebbe stato ‘destinato’ all’oblio dal pensiero metafisico da Platone in poi; una dimenticanza che avrebbe caratterizzato ogni aspetto della vita moderna e contemporanea. È questo uno dei temi principali, caro a Di Carlo, e che prende corpo nel suo poema con “il linguaggio che si svolge nel regno del disvelare”, là dove “l’essere s’annuncia rivelato o negato”: “Evento accessibile per via estetica”, la quale fa del nostro poeta un viandante, un pellegrino alla ricerca continua della parola degna dell’annuncio; che confida e si affida alla poesia che lo sostanzia, come egli stesso dichiara: “Sono fatto di poesia e di nient’altro”. E la Poesia è la sorgente e la giustificazione di questo suo ‘viaggio’ che possiamo definire, ricordando S. Bonaventura, un Itinerarium mentis in deum , tale è il fervore che ne segna le tappe a partire dal “Monologo”, che, in quanto pensiero dell’Uno, è quasi un’invocazione: la stessa che mosse il ‘Doctor Seraphicus’ a invocare il “Primo Principio” e che per il Nostro è l’elevazione allo stato di estasi, che consente il ‘distacco’ dai limiti conoscitivi della metafisica, necessario per il superamento dell’oblio dell’Essere e per accedere alla Conoscenza. Ma pensare l’Uno non è ancora conoscerlo, e il Logos, che include tra i molteplici significati la ‘parola’ quale si articola nel discorso, dà al monologo il contrassegno della difficoltà del linguaggio ad esprimere quell’Uno che pure è Parola: il dire originario verso il quale lo stesso linguaggio tende e mette il Dichter in cammino. Impresa titanica per l’ineffabilità dell’essere, che, a lungo sepolto nella sua epoché[1], lascia che il linguaggio proceda “solitario” e interroghi l’oracolo senza poter chiudere il cerchio. Perché parlare è “un rispondere già dato (che) preesiste a ogni domandare”. Perché, ancora, parlare è vedere, è «pro-fanare»: portarsi in prossimità del sacro, stare davanti al tempio nel cuore dell’oscurità profonda; ed è “Nostalgia della morte”: desiderio di ritornare là, nel luogo dove Orfeo volle incontrare la verità cogliendola, per un istante, nel volto trasfigurato di Euridice; là, dove Empedocle, quale ce lo racconta il mito, volle “sacrificarsi” (farsi sacro) unendosi al suo “ardente” Principio.
Franco di Carlo intraprende questo “viaggio” non soltanto per sé stesso, per soddisfare la propria passione, per nutrirsi del cibo quotidiano della poesia rispondendo alla chiamata del dio che si “palesa” lasciando avvertire la propria presenza nell’interiorità profonda; ma anche per il dovere di alto valore morale verso l’uomo, verso la società; per il sentimento d’incontenibile bellezza che non può tenere solo per sé; sì che per lui donare poesia è la difficile scommessa contro la considerazione superficiale ed errata dei molti che la reputano inutile. Egli affida alla poesia, “ultima risorsa d’un cuore inerme”, il compito di mettere gli uomini sulla via, quella giusta e smarrita, quella “diritta”, dantesca. Da qui, l’invettiva contro gli “empi mortali” che esorta a destarsi, “battere l’ali / verso sentieri, per luoghi beati,” a lasciare i loro “sepolcri imbiancati” e risorgere: “ Rinascete alla vita e distinguete / il vero dal falso, riprendete / il viaggio incompiuto”. C’è un’implorazione implicita in questo suo ‘grido’ - quasi un «Lazare, veni foras» - là dove sembra raccomandare il ‘risveglio’ prima che giunga il tempo della morte: “Tempo verrà che nessun moto, mai più vi scuoterà / dalla notte del sonno e lì resterà / sempre immutato, l’eterno dolore”. Al tempo della povertà, divenuto pericoloso e abissale e, dunque, insostenibile, occorre sostituire il tempo della poesia in quanto ricchezza, ovvero, quel “Sentimento del tempo”, avvertito da Ungaretti nel profondo del cuore, come una sorta di “avanguardia” dello spirito contro la tradizione e gli sperimentalismi delle avanguardie: nel senso, cioè, e di una svolta nella narrazione poetica e di un rinnovamento del cuore dell’uomo, di una “renovatio mundi”. Non più il tempo di Chronos, empirico, in continuo divenire e orizzontale, ma, semmai, di un nuovo orizzonte, proprio quello che qui indica il cammino, ne segna le tappe e orienta lo sguardo del poeta, il quale sogna la/in prossimità dell’Uno, della Parola degna dell’ascolto, alla quale “obbedire” (ob audire) e con cui ‘monologare’ e da interrogare come l’oracolo attendendone l’infinita risposta dentro il domandare infinito. Perché mai si esaurisce, o si concede alla temporalità e mondanità del linguaggio e dell’«esserci», il Verbo: voce dell’Essere, dell’Aion, del tempo eterno, assoluto, circolare.
Sulle tracce del dio procede la scrittura che resta incompiuta ed è “terra di nessuno”, la quale, nonostante le coltivazioni e le fioriture, mai pone fine al cammino perché sempre l’immaginazione lascia fuori di sé ciò che “vogliamo” e “che non possiamo”. E se non lo può il poeta, se egli, pur “mirando la forma della luce”, resta prigioniero e incompiuto nell’ombra della parola quando, tolte le parentesi al mondo, cessa l’investitura dell’angelica forma di quel raggio, di certo non lo potrà il mondo, istruito ed esperto nell’“ars tecnologica”, nelle “mercificazioni” e s-caduto nel processo inarrestabile di massificazione della società e nella progettazione e realizzazione nichilistica dell’infouomo. Solo “quando la parola / diverrà esternamente muta e beata / inscrivendo l’inanimato corpo dentro il linguaggio”, solo allora accadrà il “miracolo” (mira-oraculum): la contemplazione dell’oracolo e del definitivo responso. Ed è questa l’attesa, la promessa, l’avvento tanto desiderato, agognato dal nostro poeta Franco: “Udì la voce invisibile, lo spazio lontano / l’ultimo tempo. / Una renovatio mundi impensabile”. Allora “il ciclo del ritorno” sarà compiuto, se allo sguardo che lo pensa ed ascolta si concederà l’Ereignis nella sua rotondità perfetta, dove il pensiero il linguaggio la scrittura saranno l’identità eterna, il Dire originario: l’Uno, l’Essere, la Parola, il Principio, il Primo Elemento, l’Arché, il Fuoco.
In Di Carlo la “morte” di Empedocle non resta imprigionata nel mito, ma, fuori di esso, si fa avventura: narrazione e interpretazione del cammino dell’uomo /poeta attraverso la scrittura e le sue opere; ed è, al tempo stesso, ‘occasione’ (ob-cadére) e ‘progetto’ (pro-jacere): “ciò che cade davanti, a proposito”, che gli consente di esprimere al meglio il suo pensiero e “ciò che viene gettato davanti”, ciò che egli offre come un dono agli altri essendo, a sua volta, il dono ricevuto, la vertigine e l’estasi dinanzi alla visione sacra. Un progetto autentico, sentito, in quanto vocazione poetica e vita (“Sono fatto di poesia e di nient’altro”, egli dice e lo ricordiamo ancora); dunque, un pensiero poetante intriso di dedizione morale e spirituale, una weltanschauung, un’estetica dell’avvento che, avendo nell’essere il suo fondamento e orientamento, è un’ontologia, un cammino etico-filosofico che, sulle orme di Empedocle, di Hölderlin e di Heidegger, procede oltre il tramonto metafisico dell’essere. Con l’auspicio che se ne possa intravedere la luce; che questa si diffonda “intorno alle figure / agli sguardi e ai sensi svelati” affinché non si perda di vista la meta e sia resa possibile la “Redenzione dell’uomo modello di perfezione / fornita di senso e perciò di direzione”.
[1] epoché: gr.: "sospensione dell’assenso". Qui il termine è usato nel significato che Heidegger attribuisce all’essere, in riferimento, cioè, al suo differire la propria manifestazione rivelandosi (e, insieme, nascondendosi) nell’ente, in modo sempre diverso nelle varie «epoche» della storia della metafisica. La Poesia qui è assimilata all’Essere.