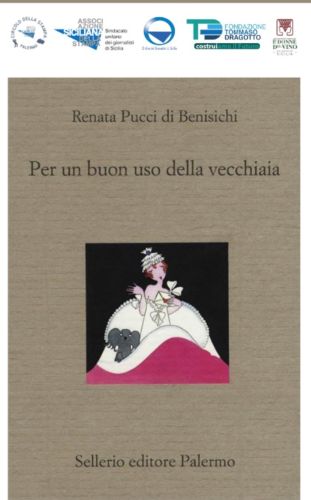Oltre “Il Signore delle Mosche”: viaggio nell’opera di William Golding, lo scrittore che raccontò alla modernità il peccato originale
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 26 Marzo 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2653
di Luca Fumagalli
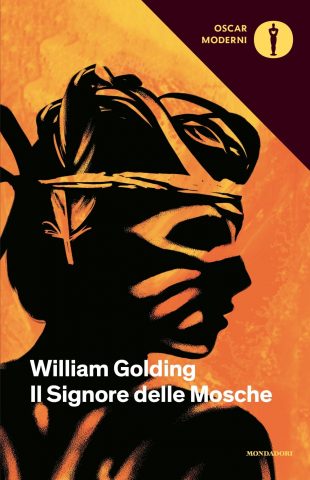 La fine giunge sempre, nei romanzi come nella vita. Per l’inglese William Golding (1911-1993) fu improvvisa e rapida, quella di uno spirito magno, di un grande vecchio che con le sue storie aveva invitato un’intera nazione intorno al focolare della narrativa favolistica.
La fine giunge sempre, nei romanzi come nella vita. Per l’inglese William Golding (1911-1993) fu improvvisa e rapida, quella di uno spirito magno, di un grande vecchio che con le sue storie aveva invitato un’intera nazione intorno al focolare della narrativa favolistica.
La celebrità era giunta con Il Signore delle Mosche (Lord of the Flies, 1954) e, nonostante una lunga carriera costellata di premi e successi – compreso il Nobel, nel 1983 –, il suo nome è rimasto inscindibilmente legato a quell’unico capolavoro. La vicenda dei piccoli naufraghi, soli su un’isola deserta in compagnia della bestia che abita in loro, è diventata un classico della letteratura occidentale e continua a essere letta, ancora oggi, anche sui banchi di scuola, a decenni di distanza dalla pubblicazione.
Ma quell’unico libro, per quanto avvincente e profondo, non basta a definire un’esistenza condotta al limite, sempre sul filo del rasoio e quotidianamente attratta da un mistero sfuggente. Picconatore di miti e fustigatore di vulgate, attraverso la sua opera Golding si pose l’obiettivo di contestare il passato per rileggere il presente alla luce di una rinnovata consapevolezza della natura umana. In questo fu certamente un intellettuale scomodo che, fuggendo da ogni facile consenso, divenne coerente pellegrino del proprio pensiero, attento solo alle esigenze dell’io.
Lo scarso seguito che, in generale, ebbero i suoi lavori, testimonia soprattutto il disagio che essi procurarono in molti lettori, terrorizzati anche solo all’idea di trovare tra le pagine, come in uno specchio, il riflesso terribile di un’anima sfigurata dal peccato. Lo spaesamento dell’uomo contemporaneo in rapporto alla conoscenza del proprio essere è il vertice e lo scacco generazionale promosso dallo scrittore.
In un mondo lacerato dalla guerra fredda, in cui era facile cadere in una semplicistica divisione manichea dell’universo in buoni e cattivi, la sua voce, una delle poche, intonava invece il tragico inno della realtà del male, un problema con cui tutti devono fare i conti. Il benessere derivato dal generale miglioramento delle condizioni di vita, l’illusoria libertà prodotta dai movimenti di contestazione e il cieco ottimismo del progresso tecnologico – particolarmente osteggiato in The Scorpion God (1971) – furono bersaglio di una critica al vetriolo che mirava a svelare l’autoinganno della modernità. Chi aveva ceduto alla pia illusione che la natura umana fosse cambiata in meglio si trovò faccia a faccia con Golding e con il suo memento teologico popolato da terribili allegorie e da figure tradizionalmente evocative.
Sia che si tratti di un romanzo di ambientazione storica o di una favola morale a carattere contemporaneo, la sua opera svetta innanzitutto per la grande umanità che trasuda dalle pagine. I protagonisti, invischiati nell’esistenza, anche se molto diversi gli uni dagli altri percorrono un medesimo cammino alla ricerca di un senso che sappia rendere ragione della vita. Sofferenti, prostrati e sconfitti, a loro tocca sollevare gli occhi al cielo oltre quella cortina malvagia che sommerge il mondo e l’anima.
Nella bibliografia di William Golding si segnalano, però, continui cambiamenti e riposizionamenti da parte dell’autore circa l’esito di questa indagine, segnale di una mente vivace, attenta a scansare soluzioni banali.
Nei primi lavori trionfa una netta sfiducia nella possibile redenzione di una creatura dilaniata dal peccato originale. Fragili e malevoli, i personaggi portano dentro di sé la ferita della caduta, apparendo come intrappolati dalla colpa, predestinati alla rovina. I giovani protagonisti del romanzo d’esordio arrivano addirittura a commettere un duplice omicidio, mentre i Neanderthal di Uomini nudi (The Inheritors, 1955) fuggono dagli inseguitori lasciando dietro di sé un’orrenda scia di sangue. Il culmine descrittivo del trionfo del limite si ha, però, con La folgore nera (Pincher Martin, 1956), dove i tremendi sbagli commessi da “Pincher” Martin sembrano destinarlo addirittura a una sorta di punizione metafisica. Pur nella crudezza della narrazione, anche in libri come questi è tuttavia riconoscibile un velato appello alla compassione universale, un’invocazione d’aiuto che è lucida espressione del desiderio di sfuggire al peccato.
Da una posizione che ricorda il radicale scetticismo protestante, romanzo dopo romanzo Golding apre progressivamente le porte alla possibilità del bene, mosso dalla convinzione che la vita non sia riducibile a schemi o teorie preimpostate. A partire da Caduta libera (Free Fall, 1959), si affaccia così l’ipotesi di un lieto fine che ha la sua massima espressione in diversi testi successivi come La guglia (The Spire, 1964), La piramide (The Pyramid, 1967) e L’oscuro visibile (Darkness Visible, 1979). L’inglese si muove dunque sul duplice versante del riscatto individuale e di una visione unitaria del reale, frutto dell’assimilazione dei poli contrastanti che lo contraddistinguono: bene e male, fede e ragione, dolore e speranza sono rappresentazioni della complessità del mondo e del cuore dell’uomo, un impasto di ragioni e sentimenti difficilmente decifrabile.
Negli ultimi libri l’opposizione di idee diviene soprattutto una lotta di caratteri che vede confrontarsi protagonisti impegnati nelle stesse scelte radicali che, però, conducono a strade diverse con esiti paradossali. La libertà è il tema portante di romanzi come la trilogia Ai confini della terra (To the Ends of the World, 1980-1987) e Uomini di carta (The Paper Men, 1984), scritti che indagano l’opportunità per gli uomini di aderire a un bene di cui – con toni generalmente fideistici – si presuppone l’esistenza.
Golding ha investito la sua carriera in un percorso che, idealmente, è paragonabile a quello raccontato da Dante nella Divina commedia. Come il celebre poeta, anche lui ha attraversato l’Inferno dell’umanità per approdare al Paradiso o, quanto meno, una prima intuizione dello stesso.
Per il premio Nobel, infatti, la vita è fondamentalmente un «enigma […] irrisolto». Quel Dio a cui aveva dato la caccia per lunghi anni rimane ignoto, una definizione che significativamente appare nella riga conclusiva de La doppia voce (The Double Tongue, 1995 postumo), l’ultimo romanzo scritto. Eppure il suo lavoro è diventato un punto fermo nella letteratura contemporanea proprio per l’onestà con cui descrive il rapporto tra l’uomo e le sue aspirazioni più alte. Del resto la vertigine del vuoto – un rischio sovente denunciato – è una tentazione di cui il nichilistico mondo contemporaneo è ormai pericolosamente imbevuto. Il monito è ancora più prezioso se fatto da un autore che ha raggiunto questa certezza a costo di grandi sforzi e sacrifici, guadagnata riga dopo riga, frutto del costante mutamento di un punto di vista capace di narrare con pari sincerità santità e vizio.
Vi è una frase, rilasciata durante un’intervista, che ha il pregio di riassumere in poche parole la poetica di William Golding. Nell’ironia dell’affermazione si cela la serietà di una profonda ricerca esistenziale che, alla fine, assume quasi i connotati di una tenera invocazione alla Grazia divina, l’ultima speranza di salvezza: «Trovo difficile non credere in Dio, se è questo che vuol sapere. Ma non sta qui il nocciolo del problema. La mia preoccupazione è che Dio creda in me».
da: www.radiospada.org