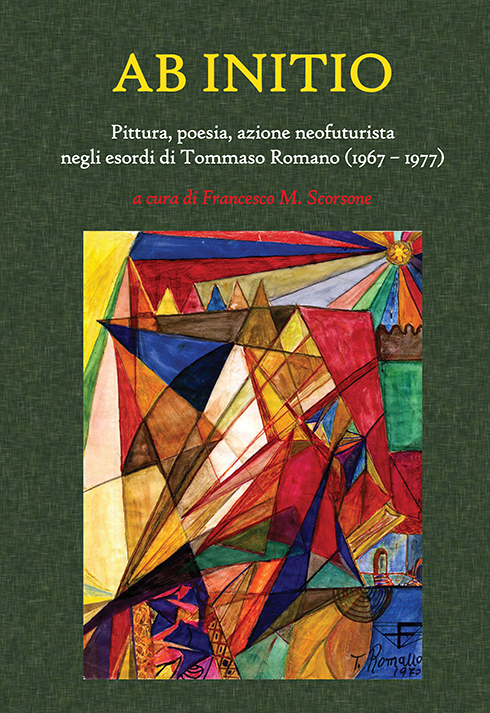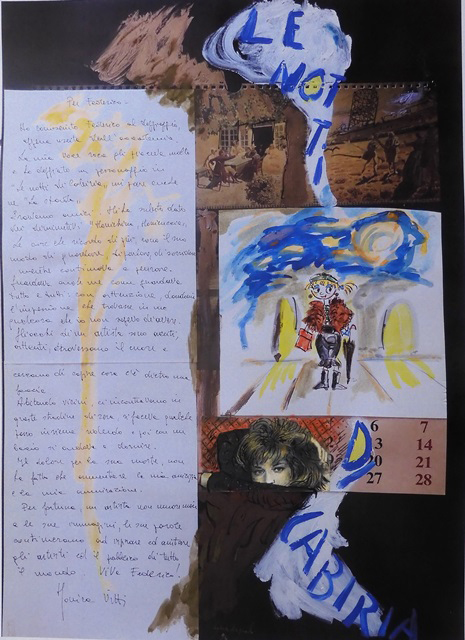“1516-1523: Tempo di ribellioni e di efferatezze” di Vittorio Riera
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 08 Settembre 2022
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1381
La ribellione contro il viceré Moncada
La morte di Ferdinando il Cattolico – 25 gennaio 1516 – innescò in Sicilia una serie di ribellioni con al centro il viceré Moncada, un viceré, tuttavia dalle mille risorse. Perfino dalla sua cacciata, come si vedrà, seppe trarre profitto.
Patrizi e plebei siciliani lo odiavano perché interpretava la carica in maniera spregiudicata, a suo uso e unico consumo. Non esitò a tenere segreta la morte del sovrano ben sapendo che doveva lasciare la carica dal momento che tutti gli atti del sovrano venivano azzerati e si doveva ricominciare da capo.
La notizia trapelò lo stesso grazie al conte di Collesano. Allora, ricostruisce Messina (p. 33), “si levarono le grida contro il tiranno e di consolazione per la fine della schiavitù”. Ma, come è stato detto sopra, anche da questa situazione, apparentemente insostenibile, il viceré seppe trarsi d’impaccio. Da un lato, fece capire di essere disposto a cedere, dall’altro lato, osservò che poteva incorrere nelle ire dei sovrani se lasciava la Sicilia in balia di se stessa. Il cavillo fu ben accolto soprattutto da quella fetta di nobiltà interessata a conservare i propri interessi e privilegi (Messina, Ib). Come spesso accade, tuttavia, a ogni azione può seguire una reazione. E se il viceré poteva gioire per essersela cavata, i nobili a lui ostili decisero di abbandonare Palermo e di trasferirsi a Termini. Ciò acuì gli animi dei cittadini che ritennero il Moncada responsabile di ogni cosa che non andasse per il verso giusto.
Vistosi circondato da tanta ostilità, il Moncada ne escogitò un’altra delle sue. Ma lasciamo la parola al Messina (p. 34): “Montò a cavallo il viceré ad affrontare i ribelli, seguito da molti consiglieri: Viva il re Carlo e la regina Giovanna, gridò”. L’escamotage non sortì l’effetto sperato. Tentò allora un’altra carta che toccava da vicino le tasche dei cittadini, l’abolizione della gabella sul macinato, una tassa mal sopportata dagli interessati. Anche questi tentativi si dimostrarono inutili. Gli fu detto chiaro e tondo che non era più nessuno e che doveva andarsene. Il viceré non demorde. Gioca un’ultima carta: diffonde una fake news, diremmo oggi, l’arrivo di un messo del re con la conferma della nomina a viceré. Ma è un messo dall’aspetto rozzo, da galeotto. Da qui le derisioni, gli insulti, le beffe. Il viceré non cede e afferma che le lettere sono del sovrano e per giunta autografe. Il tentativo sembra riuscito. In certe situazioni però c’è sempre un qualcosa che non va per il verso giusto. La parola a Messina (p. 35): “Accadde che mentre il Capitano della città, Vincenzo Corbera, si portava dalla sala del Senato al Palazzo Reale, lo fermò un popolano nella piazza della Marina pretendendo una copia di quelle lettere; s’indignò il capitano e gli rispose chiedendogli che diritto avesse di fargli una siffatta richiesta lui, un uomo da nulla, e vedendolo armato ordinò ai suoi sgherri che lo disarmassero e lo legassero, ma oppose resistenza il popolano e cominciò a gridare richiamando, diversi dei ribelli, che sguainarono le loro spade e costrinsero il barone Corbera e i suoi uomini a lasciare libero l’uomo che volevano trattenere, e a cercare scampo nella fuga”.
L’episodio narrato da Messina è significativo poiché infuse coraggio ai ribelli che capirono di averla vinta sul viceré aumentando con decisione le loro richieste. A nulla valsero i tentativi del viceré di guadagnare tempo e dovette cedere partendo segretamente per Messina.
Rinascita e decadenza del Moncada: ultimo atto
Anche questa volta il Moncada mostra di essere l’uomo dalle mille risorse tanto da potere trasformare una sconfitta se non una vera e propria vittoria certamente in qualcosa che temperava la sconfitta rendendola meno amara.
La fuga a Messina fu una decisione presa a ragion veduta. Il viceré era certo che i messinesi l’avrebbero accolto volentieri non foss’altro per fare un dispetto a Palermo di cui erano gli eterni rivali. Non si sbagliava il Moncada.
Ai messinesi non parve vero di ospitare un viceré che dunque poteva continuare nella sua spregiudicata politica fatta di cedimenti, solo apparenti, e di adulazioni più accattivanti.
Sua prima preoccupazione fu quella di inviare dispacci per informare i sovrani su quanto accadeva. Contemporaneamente ammoniva altre città del Regno a non unirsi ai ribelli indorando la pillola con la promessa che avrebbe abolito dazi e donativi. Ma solo Messina – e non poteva essere diversamente – rispose positivamente. Le altre città risposero che avrebbero fatto da sole, abolendo dazi, gabelle e donativi. Un danno piuttosto consistente per l’erario tanto che la Corte spagnola non esitò a censurare l’operato del viceré.
Messina, da parte sua, cercò di giustificare il viceré, che fu costretto a cedere per evitare danni maggiori.
La ribellione, tuttavia, assumeva maggiore consistenza con, “saccheggi, vendette, delitti di ogni sorta” (Messina, p. 37). Si sperava sull’iniziativa dei nobili avversi al viceré, ma inutilmente. Intervenne allora il Conte di Collesano ammonendo che non si poteva lasciare la città in balia dei rivoltosi e che gli interessi della corona prevalevano su ogni altra istanza.
L’intervento del Cardona convinse i nobili a tornare da Termini dove si erano rifugiati per non essere coinvolti nella rivolta. Fu deciso di inviare un messo al re Carlo con la proposta di affidare temporaneamente il governo dell’isola a due Presidenti del Regno nell’attesa delle decisioni del Re che arrivarono accogliendo la proposta.
Intanto, Moncada si vedeva confermata per un altro triennio la nomina a viceré. Ma i malumori continuavano. “Si chiedeva l’abolizione delle gabelle e che anche i cittadini facessero parte del Senato” (Messina, p. 38). I nobili non se la davano per intesa. La questione fu risolta dal Re in persona stabilendo che a Messina vi fossero quattro senatori in rappresentanza dei nobili e due in rappresentanza del popolo.
Rimaneva la questione più spinosa del governo della Sicilia. Questione che il Re decise dichiarando decaduta la nomina a viceré del Moncada valutando i rapporti avuti sulla situazione in Sicilia inviatigli da uomini di sua fiducia. Altre decisioni del re, la nomina del Conte di Caltabellotta a Presidente del Regno. Inoltre, erano da ritenersi nulli i provvedimenti presi contro il Moncada. Ciò probabilmente per rendere meno amara la decadenza della carica a viceré.
Sembrava tutto risolto, che le acque si fossero acquetate. Ma non fu così. I bivonesi non riconobbero il Conte di Caltabellotta. Volevano dipendere direttamente dal sovrano incorrendo così nell’ira del Presidente del Regno che non esitò a saccheggiare le terre, a uccidere i più facinorosi riconducendo a più miti consigli quanti l’avevano fatta franca. Ma molti di loro furono condannati a morte o esiliati.
Per la cronaca, Hugo de Moncada, nella qualità di viceré di Napoli, trovò la morte in battaglia colpito da un proiettile d’arma da fuoco il 28 maggio 1528 nelle acque di capo d’Orso, nel golfo salernitano. Una morte, come si vede, da eroe che annulla d’un sol colpo il suo discusso e nburrascoso passato.
1517: la rivolta di Gianluca Squarcialupo
Non è chiaro se Gianluca Squarcialupo abbia partecipato alla rivolta contro il viceré Moncada anche se fortemente sospettato. È certo invece che il nobile palermitano voleva sbarazzarsi definitivamente dei seguaci di Hugone Moncada. L’occasione gli fu data da una questione, diremmo oggi, d’onore. Lo Squarcialupo era giudice non togato e quindi in certe situazioni poteva far valere la sua carica. E proprio per una questione di precedenza non esitò a trare la spada contro il conte di Adernò congiunto del Moncada. Probabilmente lo Squarcialupo sapeva della parentela con viceré e quindi era inevitabile una reazione del viceré. Moncada infatti lo condanna all’esilio. Era ciò che lo Squarcialupo si aspettava anche perché il malcontento contro il Moncada era ancora vivo nei siciliani. A ciò si aggiunga che non v’era esercito che potesse contrastare eventuali rivolte e che ormai il Moncada non rappresentava più il re. Ritenne quindi lo Squarcialupo che era giunto il momento di agire.
Si circondò di alcuni nobili cui non parve vero di potere sfuggire ai creditori. Non mancarono individui reclutati fra il popolino. Inoltre, lo Squarcialupo fece credere che Guglielmo Ventimiglia barone di Ciminna era della partita. Ma il punto più alto della sua spregiudicatezza fu quello di aver fatto cedere che i conti di Collesano e di Cammarata erano stati condannati a morte su ingiunzione dei giudici palermitani. Infine, facendo leva sulla sua capacità di attrazione, dipinse a fosche tinte quella che riteneva una schiavitù per la Sicilia e concluse che bisognava prendersela contro quanti si erano schierati con Moncada e continuavano a parteggiare per il viceré.
Tutti si dichiararono d’accordo. Fu stabilito anche il giorno dell’insurrezione, il 24 di luglio, festa di Santa Cistina, giorno in cui il luogotenente e l’intero Senato dovevano recarsi al duomo per presenziare alle celebrazioni. Un luogo sacro era stato dunque scelto per trucidare i magistrati.
La notizia della congiura era trapelata egualmente, ma nessuno vi dette peso. Fu avvertito anche il Pignatelli il quale, per ignavia o per paura, ritenne opportuno rifugiarsi nel suo palazzo con i consiglieri. Anche il capitano della città, ritenendo che non c’era nulla da fare fuggì.
La città rimase del tutto indifesa e in balia dei rivoltosi. I quali si recarono al duomo. Ma una sorpresa li attendeva. Il duomo era completamente vuoto. Non una delle vittime designate era presente. Ne fece le spese l’archivista della città che venne trucidato mentre adorava la santa.
I rivoltosi, dicono le fonti, erano appena ventidue, uno sparuto gruppo, tuttavia, che non esitava a incitare inutilmente i palermitani a unirsi a loro. A questo punto, avviene un fatto strano, lo Squarcialupo sviene forse perché ritiene disperata l’impresa, ma fa presto a rinvenire e a recarsi al palazzo del luogotenente Pignatelli. Il dialogo tra i due sa di comico. Dal basso, Gianluca che urla al Pignatelli di consegnare i magistrati rei della morte di Collesano e Cammarata, dall’alto, il luogotenente che replica essere i conti vivi. Un dialogo fra sordi che non prometteva nulla di buono. Infatti, i ribelli, a un certo punto, decisero di invadere il palazzo dov’era asserragliato il luogotenente. Le nefandezze che ne seguirono furono di una crudeltà unica e inimmaginabile.
Due giudici della gran corte, raccontano le fonti, furono uccisi, denudati e gettati giù dalle finestre accolti probabilmente da grida di giubilo. La crudeltà dei ribelli fu incontenibile. Le teste degli uccisi furono infilzate nelle punte aguzze delle piche. Poi è la volta del maestro razionale che venne prima evirato e poi ucciso. Le nefandezze non si fermano qui. Un avvocato, che chissà quante ne aveva combinate ai danni della povera gente, venne scovato in casa di una donna di facili costumi nella cui casa si era nascosto, venne tratto fuori, trascinato per le strade della città, massacrato di botte e infine scannato. La sete di sangue dei rivoltosi era incontrollabile, da invasati. Ricordatisi di un amico di Moncada, corsero al convento di S. Domenico dove credevano si fosse nascosto. Non avendolo trovato, si impossessarono degli ori e argenti che Ugone Moncada aveva dato in custodia al superiore del convento.
Quanto stava accadendo a Palermo contagiò altre città, Catania, Trapani, Termini, Girgenti, dove i ribelli e i moncadiani si scontrarono provocando gravi disordini. Insomma, era l’anarchia completa cui soltanto un fatto nuovo poteva porre rimedio.
Il tradimento dei fratelli Imperatore: una strage infinita
E il fatto nuovo infatti si presentò sotto la veste dei fratelli Imperatore, Pompilio, Federico e Giovanni Vincenzo, parenti stretti di Gian Luca Squarcialupo. Era ipotizzabile quindi che avrebbero sostenuto la rivolta. Invece fu grazie al loro tradimento se la rivolta contro Gian Luca ebbe successo. Essi anzi furono il braccio armato di una congiura la cui mente era il barone di Ciminna.
Bisognava, secondo il barone, fingersi dalla parte dei congiurati, attirarli in una trappola e quindi agire al momento opportuno.
La trappola funzionò alla perfezione.
Le due fazioni si incontrarono nella chiesa dell’Annunziata, a Palermo, non a caso sita in via Squarcialupo. È l’8 settembre del 1517. Le due parti si accordano perché si celebri messa prima di cominciare a trattare. Ma un segnale convenuto, Nicolò Bologna, parente dello Squacialupo, uccide Cristofaro di Benedetto, la prima vittima dei congiurati. Contemporaneamente, Pompilio Imperatore conficca un pugnale nella gola dello Squarcialupo, uccidendolo. E fu la strage e il fuggi fuggi tra le navate di un luogo sacro.
Ma non finisce qui. Anche il Barone sembra assetato di sangue. Con un codazzo di sostenitori gira per le strade di Palermo gridando: ”Viva il re Carlo e la regina Giovanna! Muoiano i nemici della patria!” (Messina, p. 50) ripetendo quanto aveva gridato senza successo il viceré Hugo de Moncada (Messina, p. 34). Bisognava a ogni costo scovare e distruggere quanti dei rivoltosi erano riusciti a sfuggire all’eccidio. Non solo. Era assolutamente necessario perseguire anche chi potenzialmente potesse simpatizzare per i rivoltosi. Insomma, una vera e propria caccia alle streghe. La città è ora in mano al Barone e ai suoi seguaci. A questo punto, era opportuno informare il Pignatelli che la città era al sicuro e che poteva quindi tornare a Palermo. Ma è un ritorno che lascia dietro di sé una lunga scia di sangue.
Protetto da una nutrita scorta ottenuta dal viceré di Napoli, entra nelle città che avevano partecipato alla rivolta condannando a morte o all’esilio i rivoltosi e confiscando i loro beni.
Giunto a Palermo, condanna a morte il nobile Francesco Barresi, reo soltanto di avere presenziato ai preparativi della rivolta. Analoga condanna per l’esperto di diritto Bartolomeo Squarcialupo, fratello di Giovan Luca. Per un caso di omonimia, rimane vittima anche certo Giacomo Suarcialupo. Per i rivoltosi non c’è scampo. Si ricorre a una pratica che ricorda molto da vicino quella di Israele nei confronti dei palestinesi: la demolizione delle case dei rivoltosi e dei loro simpatizzanti, e “parecchi, racconta Messina (Ib., p. 50), furono i condannati fra i plebei, alla morte, alle galee, al perpetuo carcere”.
Tanto zelo e tanta crudeltà furono ben presto premiati da re Carlo con la nomina a viceré, ma fu, quella del Pignatelli, una vice reggenza oscurata da molte ombre e illuminata da pochissime luci.
Fonti
Calogero Messina, Sicilia 1492-1799 – Un campionario delle crudeltà umane – Con un discorso sulla storia, L’ORMA, Palermo 2022.
Niccolò Palmeri, Somma della storia di Sicilia, Stamperia Giuseppe Meli 1850. Consultato il cap. 42.