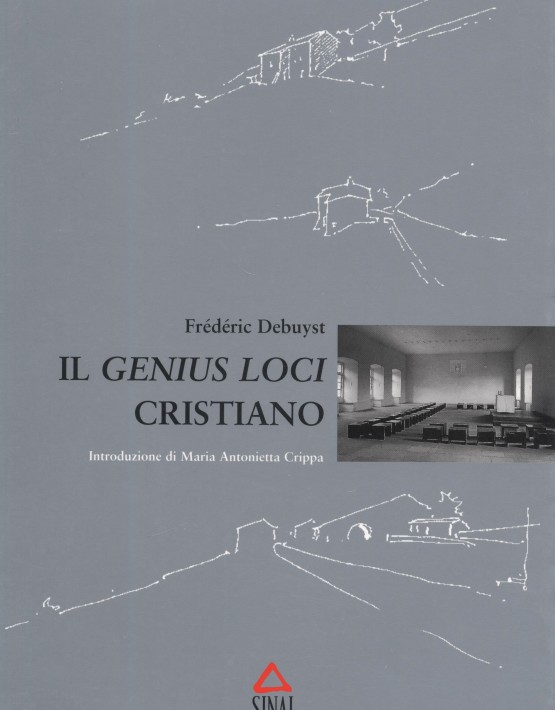Tra mitologia futurista e fedeltà degli archetipi: gli esordi di Tommaso Romano
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 09 Febbraio 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1998
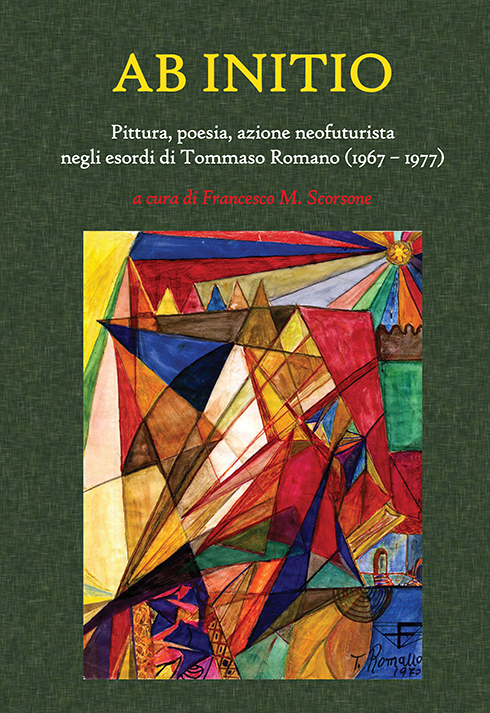 di Antonio Martorana
di Antonio MartoranaNella parcellizzazione tipologica dell’imponente produzione letteraria, filosofica, storica, artistica, esegetica ecc. di Tommaso Romano, i lacerti auto(bio)grafici verbali e figurativi risalenti al periodo adolescenziale e della prima giovinezza (per i quali si rimanda alla ricca documentazione riportata nel volume a cura di Francesco M. Scorsone, Ab Initio. Pittura, poesia, azione, neofuturista negli esordi di Tommaso Romano 1967-1997, con presentazione di Aldo Gerbino e testi di: Francesco Scorsone,
Vinny Scorsone, Giusi Lombardo, Palermo, Studio 71, 2017), evidenziano già la progettualità di un fare poetico che guarda alla prospettiva più vasta di arte interdisciplinare, aperta alla convergenza e all’interazione reciproca di codici non analoghi. Siamo in una fase di sperimentalismo eversivo, che vede l’Autore, come investito e soggiogato dal turbine del paroliberismo marinettiano, procedere alla demolizione delle prescrizioni retoriche della scrittura, del suo statuto e del suo codice linguistico, nonché delle sue consuete modalità di trasmissione e fruizione.
Insopprimibile infatti è in lui la volontà di liberarsi dall’ingabbiamento semantico e sintattico del discorso comune, connesso alle varie forme di assuefazione fruitiva, e quindi dai comuni significati, per muoversi in direzione dell’esaltazione del puro significante.
E questo è già indicativo della precoce frequentazione, nel segno della trasgressione, del topos della libertà, come uno dei cardini, insieme al topos della bellezza, dello statuto ontologico dell’opera di Romano.
L’aver noi eliso il “bio” dall’espressione sopra riportata. “Auto(bio)grafici”, ponendolo entro parentesi, ci consente di concentrare meglio l’attenzione sull’originalità (“auto”) dell’estrinsecazione “grafica” (“autografica”, appunto) nella quale si condensa la pura esperienza immaginativa. Qui è il “grafos”, cui è affidato il compito di orientare l’atto creativo, ad uscire dai confini prettamente verbali, per acquisire una polivalenza semantica, che ci ricorda la formulazione di Emilio Isgrò come «arte generale de segno».
Non è difficile ravvisare in quel fecondo decennio la pietra di fondazione dell’esemplare carriera mitopoietica che conosciamo, capace di coinvolgerci con un forte impatto estetico, come è avvenuto di recente, con la silloge L’airone celeste (San Cipirello, All’insegna dell’Ippogrifo, 2018).
È qui il momento di sottolineare l’estrema coerenza con la quale l’intellettuale palermitano, sin da quando indossava i pantaloncini corti, ha sempre creduto nell’utopia positiva dell’arte, ricavandone una nozione nobile: quella di un’arte che, com’è nell’auspicio di Achille Bonito Oliva, si riveli «capace di diffondere, come un profumo, un’atmosfera estetica nel caos produttivo del mondo».
Ancora imberbe, egli aveva intercettato in essa un varco provvidenziale da cui sfuggire ad un mondo irrimediabilmente condannato all’entropia, e riparare in una zona ecologica di energia creativa, dove poter recuperare la propria vera identità.
La fiducia nella possibilità di costruire un modello in grado di trasformare la realtà, lo ha spinto ad interagire con le correnti artistiche più vitali del nostro tempo, dalle quali non ha esitato a catturare tesori di bellezza formale, per trasferirli e rielaborarli nel proprio atelier di progettualità, dove tutto trova oggettivazione ed equilibrio, forma ed esistenza, arte e vita.
Da qui quella dialetticità immanente alla sua parabola, che, individuando un punto di sutura tra prossimità agli archetipi e seduzioni avanguardistiche, sembra inverare il fatto che l’uomo ha «fondato tutta la sua esistenza su una serie di modelli binari» (Alighiero Boetti). All’indiscutibile rapporto interattivo tra i citati estremi si correla, nella circolarità inesauribile del divenire, quello tra visibile ed invisibile. Così, il modello binario visibile-invisibile, ossia la lucidità critica nel gettare lo scandaglio nelle problematiche e nelle criticità del presente (il visibile), e la tensione spirituale verso l’Oltranza (l’invisibile), si può considerare l’asse portante del suo impegno di studioso e di artista. Se volessimo giudicare tale impegno con le parole di Rilke, potremmo definire Tommaso Romano una delle «api dell’invisibile», use a suggere «il miele del visibile, per accumularlo nell’arnia d’oro dell’invisibile».
In relazione alla sua posizione baricentrica tra tradizione ed innovazione, potrebbe valere per lui la considerazione che Vittorio Vettori esprime per il grande scultore Ernesto Galeffi, nella monumentale monografia a lui dedicata: «l’origine come meta. Ossia il punto d’arrivo come recupero del punto di partenza, il traguardo come ritorno (o nostos)» (V. Vettori, Un inventore di miti. Galeffi, Palermo, Ila Palma, 1987).
Nel ripercorrere la parabola di Romano, troviamo la conferma che la dialetticità nell’arte è speculare alla dialetticità della vita stessa, nelle cui calde viscere è un fluire ininterrotto di slanci ed inciampamenti, di cadute e di ripartenze, di eroici furori e di castigazione degli eccessi.
Per questa sua identità bifronte il Nostro ci ricorda l’Eletto (Der Erwählte, 1951), il protagonista del romanzo breve di Thomas Mann, dove, come avverte E. Catalani, nell’Introduzione all’edizione italiana (T. Mann, Romanzi brevi, Milano, Mondadori, 1955, p. XXXIV), «i mondi apparentemente inconciliabili della modernità (Faustus) e del mito (Giuseppe)» - potremmo dire, nel nostro caso, avanguardismo futurista e tradizione - «vengono a convergere in un’opera fuori della storia».
La dialetticità viene allora a materializzarsi, in interiore homine, nella presenza dei «due Io» di cui parla Miguel de Unamuno, nel confidarsi con un amico: «Ah, amico mio, eccoci in presenza di due grandi ansie: l’ansia di azione e l’ansia di riposo. Io porto dentro di me, e credo che lo stesso succederà a lei, due io ben distinti, uno attivo, l’altro contemplativo, uno guerriero, l’altro pacifico, uno innamorato del movimento, dell’azione, l’altro della quiete, del riposo».
Chi ha familiarità con Tommaso, sa dell’assenza dal suo vocabolario di termini come “quiete” e “riposo”, e del ricorrere nello stesso, invece, di quelli di “movimento” e di “azione”. Non si stupirà allora per il fatto che ben presto, nello sviluppo della sua personalità, a prendere il sopravvento sia stato l’io guerriero, nemico irriducibile di quella che Miguel de Unamuno definisce come la «ragione sillogizzante». Si spiega, così, l’adesione al futurismo, ossia, come fa notare Corrado Maltese, alla «più violenta rivolta che l’Europa abbia conosciuto» contro le idealità illusorie che artisti quali Pellizza, Segantini, Previati e Medardo Rosso si erano «adoperati a inserire nel “vero”» (C. Maltese, Storia dell’Arte in Italia. 1785-1943, Torino, Einaudi, 1992).
Negli anni acerbi della formazione Romano sarà incorso, forse, nell’ingenuità di guardare con simpatia alla violenza fisica e verbale, allo sprezzante cinismo e al sarcasmo polemico, che i futuristi, rileva ancora Maltese, consideravano le «condizioni morali uniche e necessarie dell’uomo nuovo». Per questo la sua opzione era per il “vero” primordiale e barbarico dei futuristi, antitetico al «verismo corrente, pallido riflesso accademico e commercialistico di quello che un tempo era stato il verismo e il realismo risorgimentale».
La sensibilità del Nostro doveva avere un sussulto nell’impatto con le due parole d’ordine del movimento: dinamismo-attivismo, che spiegano la profluvie, nei relativi manifesti, dei verbi di moto: “marciare”, “salire”, “scendere”, “correre”, ecc. sono i verbi che si confanno all’uomo dinamico cantato dalla poesia futurista, non a caso brulicante di soldati, alpinisti, esploratori, corridori automobilisti, aviatori, sportivi e amanti di una vita spericolata.
Dalla propaganda di Filippo Tommaso Marinetti recepiva la formula dell’«arte-creazione», ribadente la priorità dell’atto creativo rispetto all’opera finita e l’altra formula delle «parole in libertà», le sole ritenute idonee a tradurre per analogia i meccanismi psichici ed i ritmi convulsi della vita moderna.
Era il paroliberismo, appunto, ad aprire sterminate praterie al «desiderio irrefrenabile», alla «gioia convulsa» e ai «pensieri folli» dell’irrequieto neofita, ormai sospinto nel gorgo emozionale di esaltanti vibrazioni vitalistiche. È quanto lascia intendere il narcisismo dei seguenti versi: «voi non sapete / com’è bello / coniugare / Marinetti-Evola / sentirsi Cavaliere Graal / sopra rossa / Ferrari / contro infedeli / a forza di raggi x, / pulire l’anima / con il candore / sola igiene del mondo / di Dash…» (Tradizione x Futurismo).
A percorrere questi versi è un’ebbrezza che fa rivivere quella degli «uomini vivi della terra», destinatari del Manifesto marinettiano apparso sulla prima pagina del Figaro il 20 febbraio 1909. Nella vorticosa sequela delle immagini notiamo una miscela esplosiva di epica (“Cavaliere Graal”), di tecnologia (“rossa Ferrari”) e di riciclaggio, con l’occhio alla Pop Art, del prodotto consumistico (Dash, permaflex) in una rifunzionalizzazione in termini di contemplazione estetica.
Ma, al momento, di immergersi nel «sogno smagliante» di Viaggio tonale l’esuberante esistenzialità di Romano sembra volersi scrollare di dosso l’iniziale veemente irrazionalismo, per andare alla ricerca di un equilibrio stabile. Vediamo allora come i moduli ritmici, ormai al riparo dai cortocircuiti sperimentalistici dall’effetto deflagrante sull’iconicità del linguaggio, planano verso la «tonalità». Serenante di «sagome di coste sarde / che si stagliano nivee di rugiada / sui capitelli dorici».
L’evidente conquista di un equilibrio interiore, che il giovane autore sembra qui indirettamente confessare, prelude alla sua intercettazione, nell’avanguardismo futurista, di un interstizio dove la vocazione alla differenzialità, tipica degli avanguardismi («l’arte è una continua processione di differenze» ha scritto Tristan Tzara), e la carica di intensità («ogni intensità è differenziale» ha scritto Gilles Delenze), non escludono la possibilità di un confronto con la tradizione, e anzi quella di un reciproco rapporto interattivo. Si tratta dei «compromessi» cui l’ideologia futurista ha dovuto ricorrere, come fa notare Giorgio Barberi Squarotti, con la conseguenziale caduta di certi suoi presidi culturali sotto l’onda d’urto di riemergenti segni archetipici.
Lo stesso Romano si fa interprete della necessità di una rivisitazione della specificità semantica del Futurismo datane da Marinetti, non rimanendo insensibile al fascinoso riverbero dei tempi andati, che anzi egli intende rilanciare, come forze positive, cariche di potenzialità attualissime.
Secondo quanto afferma Luigi Tallarico, Romano avverte il bisogno di guardare al “nuovo” «per stabilire se la tradizione sia già futuro, nel senso che agisce come un catalizzatore in grado di accelerare e stimolare l’attività creativa dell’uomo moderno nella storia». L’apertura di Romano al futuro, con un occhio al passato, ci ricorda le parole usate dalla scultrice scozzese Kate Whiteford nel presentare le proprie opere alla quarantaquattresima esplosione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, nel 1990: «Diamo strattoni al presente per farlo progredire e scoprire che è radicato nel passato, ma ciò non fa che rafforzare la nostra fiducia nel futuro».
A ben vedere, è nei fermenti spiritualistici che agitano la coiné culturale rivoluzionaria d’inizio del secolo scorso che Romano coglie il trait d’union tra avanguardismo e tradizione. Ci va di pensare al polimaterismo prampoliniano, inteso come «spiritualizzazione della materia», alle ricerche di Giacomo Balla sul movimento, finalizzata a risalire all’essenza spirituale della realtà, e dell’arte stessa, al trionfo dello «spirituale nell’arte» nella prima mostra del Cavaliere Azzurro, organizzata a Monaco nel 1911 da Wassily Kandisky e Franz Marc, al misticismo che permea il colore “lirico” di Delaunay, ecc… Romano si sarà reso conto che, prima di andare avanti, bisogna fare un percorso a ritroso, quel «cammino regressivo per cogliere nello svolgimento storico il senso teologico perduto», secondo quanto scrive Aldo Rovatti, riferendosi al linguaggio speculativo di Edmund Husserl. Questi, con sereno spirito ironico, rivendica il diritto alla vita del «mondo della vita» (Lebenswelt). Lo avrà rafforzato certo, in tale convinzione, la grande lezione di Heidegger, quale si coglie nel passo: «i sentieri del pensiero nascondono in sé un aspetto di mistero: noi possiamo percorrerli in un senso o nell’altro; anzi proprio il percorrerli e ritroso consente di avanzare».
Così la prossimità agli archetipi da parte del Nostro, quella prossimità che gli fa sentire vivo il respiro dell’uomo abitatore del tempo, anche di quello arcaico, non viene meno anche quando i suoi occhi si illuminano nel contemplare gli universi plastici in movimento dell’arte futurista. La sua parabola artistica resta allora in perfetto bilanciamento tra memoria e presente, tra pesantezza e leggerezza, tra presenza e assenza.
PASSATO-PRESENTE. «Solo un momento del passato? Molto di più, forse: qualcosa che comune sia al passato sia al presente, è molto più essenziale di entrambi» (Marcel Proust).
PESANTEZZA-LEGGEREZZA. «Ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza meravigliosa? Cosa dobbiamo scegliere allora? La pesantezza o la leggerezza? Questa domanda se l’era posta Parmenide nel sesto secolo avanti Cristo. Egli vedeva l’intero universo diviso in coppie di opposizioni: luce-buoi, spesso-sottile, caldo-freddo, essere-non essere… Questa suddivisione può apparirci di una semplicità puerile. Salvo in un caso: che cos’è positivo, la pesantezza o la leggerezza? Parmenide rispose: il leggero è positivo il pesante è negativo. Aveva ragione? Questo è il problema. Una sola cosa è certa: l’opposizione pesante-leggero è la più misteriosa e la più ambigua tra tutte le opposizioni» (Milan Kundera).
PRESENZA-ASSENZA. «Questa presenza assenza / immobilizza / trascende ed esalta / misticamente / come un buon detto gentile / e senza sotterfugi / se non la sorte / che si volle dare / all’unità primigenia in maestosa sinfonia / ora anima negante e inquieta / dissemina / sempre più insonne nostalgia…» (Tommaso Romano).
Le ragioni dell’opzione futurista del precoce artista non si manifestano in un momento di effimera infatuazione adolescenziale, cosa che non è mai avvenuta. Esse vanno contestualizzate, per vedere come siano da collegare all’insofferenza di uno spirito inquieto per l’altissimo tasso di inquinamento morale che connotava la vita politico-sociale dell’Italia del tempo. Romano era consapevole della propria inappartenenza a quella realtà, dove, a dominare la scena era il cosiddetto «partito degli italiani», la Democrazia Cristiana, che, ad ogni competizione elettorale registrava una valanga di voti. Tale successo trova una spiegazione poco nobile, nel senso che era dovuto notoriamente, alle vergognose procedure clientelari con le quali si dava la garanzia del posto sicuro alla miriade di questuanti che aspiravano a trovare sistemazione nella pubblica amministrazione. Come osserva Giordano Bruno Guerri, il partito si reggeva sulla «paura» di una generazione frustrata: la «paura di perdere i privilegi fondati sulle clientele, sull’impiego pubblico ereditario, sulle “amicizie”: vizi che chiunque in pubblico depreca e a cui nessuno rinuncia». Si viveva in un clima di oscure convivenze con ambienti malavitosi, di corruzione e di scandali, sicché non ebbe ad esagerare, nel 1974, Pier Paolo Pasolini, quando affermò che il partito della Democrazia Cristiana era da mandare alla sbarra.
A rendere ancor più opaco il quadro politico era l’immobilismo dei governi succedutisi che si rivelavano privi di qualsiasi credibilità nel promettere notevoli modifiche economiche senza mai riuscire a tradurle nella realtà. È significativa in proposito la considerazione di Deni Mack Smith in merito alla passività-cronica della citata legislatura: «ogni anno era stato di volta in volta salutato come quello che avrebbe visto dispiegarsi una eccezionale attività legislativa, ma non si fece mai nulla di importante».
Il Nostro era tredicenne quando l’Occidente sembrò scricchiolare sotto l’urto del movimento del Sessantotto, teso ad abbattere il sistema borghese con tutte le sue “sovrastrutture” per sostituirlo con un nuovo modello rispondente alla nuova “etica”, semplicemente aberrante, di cui era portatore. A connotare quella “rivoluzione” fu la cieca violenza con la quale vennero danneggiati, con una furia bestiale che ricordava quella di alcuni decenni prima, locali pubblici e negozi. Ecco perché Jurgen Habermas non esitò a condannare quegli eccessi, definendo il movimento come il tentativo mancato di un «fascismo di sinistra».
A fronte della corretta lettura del fenomeno del citato filosofo, non mancò, sul fronte dell’intellighenzia, lo sciagurato tentativo da parte di qualcuno di giustificare atti di piromania tesi a distruggere capolavori d’arte di straordinaria bellezza. Pensiamo a Jean-Paul Sartre, che, intervistato da Pierre Benichon, ebbe la tracotanza di dichiarare: «la Gioconda la lascerei bruciare senza alcun rimorso» (intervista apparsa su «L’Espresso» dell’11 settembre 1973).
In questo clima di imbarbarimento che voleva colpire il topos della bellezza, allo stesso modo con cui hanno voluto attentare ad essa le belve dell’ISIS, Romano visse un momento cruciale della storia italiana ed occidentale. E come condannava la violenza, così prendeva le distanze dall’”etica” dei sessantottini. Questa nel porre i giovani dinanzi ad una radicale ridefinizione della loro identità, investiva la sfera dei “bisogni” collegati alla sessualità (con la cosiddetta “liberazione” sessuale, destinata a sforare nelle battaglie “laiche” per il divorzio e l’aborto).
È da ritenere probabile che risalissero ad allora i primi segnali della posizione polemica che Romano, attestandosi in posizioni di rigoroso tradizionalismo, avrebbe assunto nei confronti del cosiddetto «nuovo corso» della Chiesa, a seguito del Concilio Vaticano II. Certo non avrà visto di buon grado quella svolta epocale culminante nel potenziamento delle prerogative dell’episcopato in senso collegiale, a scapito della curia romana, e nella valorizzazione della funzione dei laici nella vita della Chiesa. Avrà fatto sua la preoccupazione manifestata dal successore di Papa Roncalli, Paolo VI, nel dichiarare che con il citato Concilio era penetrato nel mondo della Chiesa, insieme «all’aria fresca, il fumo di Satana».
Fu allora che, sotto la spinta di un’istintiva idiosincrasia per tutto ciò che lo circondava, il daimon segreto di Tommaso scopriva una straordinaria affinità elettiva assumendola come paradigma, con la rivoluzione futurista, che aveva scritto un capitolo esaltante nella vita civile e culturale del Paese all’inizio del secolo scorso. Il fattore che accomunava Romano e il Futurismo era la condanna di ogni immobilismo, e quindi l’”ansia” di costruire un futuro innalzato, attraverso il primato dell’azione, alla dignità di mito. Ha scritto Corrado Maltese: «I futuristi avevano detto di avvertire un’”ansia” che li “sparava” nel futuro e avevano dato la rappresentazione di quell’ansia» (C. Maltese, Storia dell’arte in Italia. 1785-1943, Torino, Einaudi, 1992).
Accadeva a Romano quello che era accaduto a loro: anche lui avrà provato l’”ansia” di sentirsi “sparato” nel futuro, per non incorrere nell’oppiacea assuefazione ai conformismi e alle mode imposte dal consumismo. Era consapevole del prezzo da pagare per quella adesione: si trattava di mettere in gioco il proprio destino. Perciò si sarà posto una domanda molto simile a quella che si pone Cesare Pavese: «Che cos’è questo destino? Che anche i gesti, le parole, la vita umana siano veduti come simbolo, come mito, significa che si configurano come esistenti fuori del tempo e insieme ogni volta scoperti come unici, come per la prima volta rivelati».
È dunque la simbologia connessa alla mitologia futurista a dare a Romano una nuova chiave di lettura della realtà, nel segno di un pandinamismo rigeneratore.
Romano era affascinato dal modo con cui i pittori futuristi riescono a dematerializzare le forme sensibili e, nel contempo, a immaginalizzare le forme intellegibili, alle quali dare figura e dimensione.
Sentiva, che anche per lui era venuto il momento di misurarsi con la matita ed il pennello, in modo da poter affermare orgogliosamente: «pingo, ergo sum». Ad un certo punto sarà maturata in lui la convinzione dell’«immensa differenza» esistente, a detta di Paul Valèry, tra «il vedere una cosa senza matita in mano e il vederla mentre si disegna». Ed è lo stesso poeta francese ad attribuire valore ermeneutico allo strumento prensile della mano, nel trasmettere le proprie vibrazioni sulla superficie cartacea o telata: «non posso precisare la mia percezione d’una cosa senza disegnarla virtualmente, e non posso disegnare questa cosa senza un’attenzione volontaria che trasforma notevolmente quello che prima avevo creduto di percepire e di non conoscere. Mi accorgo che non conoscevo affatto quello che conoscevo: il naso della mia migliore amica».
Una volta constatato come il disegno fosse la più immediata verifica del tradurre la manualità in forma, niente più tratteneva il neofita a misurarsi sul versante dell’«arte-creazione», come suona la formula ispirata al dinamismo futurista sotto la diretta influenza di Bergson.
Saremmo tentati di definire eraclitea l’accesa produzione coloristica del biennio 1969-1970, vista la fedeltà al principio di amplificazione senza fine, eternandola appunto, la sensazione dinamica del movimento, che i futuristi traggono dal loro antico Maestro Eraclito, la cui famosa formula “panta rei” (“tutto si muove, tutto corre”) viene riportata non a caso sul Manifesto tecnico della pittura futurista. Si comprende come le esecuzioni risalenti a quel biennio, dove prevale la tendenza a scomporre le forme per riorganizzarle in fluidi ritmi geometrici, uno a sconfinare nell’astrattismo, risentano principalmente della lezione di Giacomo Balla, l’Autore «che più accredita l’ipotesi di un’influenza futurista sull’astrattismo» (Sandra Reberschak Furlotti). Possiamo provare ad immaginare quale tensione emotiva quel neofita abbia provato dinanzi alla suggestiva descrizione di linee in movimento che è il Dinamismo di un cane al guinzaglio (oggi a New York, Collezione Conger Goodyear) e dinanzi ai successivi diagrammi cosmografici, vere sintesi astratte che anticipano Kandinsky: Volo di rondini (New York, Museum of Modern Art) del 1913, Spessori di atmosfera, velocità astratta, Penetrazioni dinamiche d’automobile, ecc. A colpire Romano devono essere state dunque le analisi ottico-geometriche di Balla, vicine al fotodinamismo di Bragaglia; a sua volta desunte dalle ricerche cronofotografiche di Marey.
Evidente risulta, accanto a quella di Balla, l’influenza di Fortunato Depero, l’altro «astrattista-futurista» firmatario, nel 1915, del manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo, espressione della confluenza del Futurismo con il filone Jugendstil. Tale documento, fondativo dell’habitat e della percezione, nel segno di un particolare interesse per l’ambiente antropico e per le situazioni reali della quotidianità, va visto come una vera renovatio futurista, che, nel sottolineare un nesso indissolubile tra arte e vita, mostra una straordinaria apertura a tutti i possibili sviluppi. Uno di questi è lo spiritualismo che permea le Compenetrazioni iridescenti di Giacomo Balla, degli anni 1912-13, le prime espressioni di arte astratta in Europa, in stretta connessione con la pittura spirituale di Kandinskij. Né si può ignorare l’influenza esercitata su di lui dalla ricerca di Prampolini sul terreno del polimaterismo, inteso come «spiritualizzazione della materia».
La renovatio futurista è decisiva nell’orientare il percorso formativo di Romano, come si era rivelata determinante nella formazione di tre giganti della cultura e dell’arte del Novecento: Pound, Joyce ed Eliot.
Prendiamo in esame alcune opere datate tutte 1970: Spirali (olio su cartone telato), Teorema (tecnica mista su carta), Civiltà delle macchine (olio su cartone telato), Futurismo (pennarello su carta), Firenze passato futuro (olio su legno). L’aspetto che le accomuna è la tensione dinamica derivante dal rapporto dialettico tra le varie forme, rese prevalentemente da moduli geometrici (triangoli, cerchi, quadrati), che si muovono nello spazio in un vorticoso movimento trasformativo. Nella strutturazione compositiva dei citati dipinti Romano applica la regola per cui l’opera d’arte non deve essere concepita come prodotto statico e circoscritto nella propria bidimensionalità, bensì come fattore mobile compartecipe del dinamismo della tridimensionalità dell’ambiente.
Al nostro occhio i citati dipinti, poi, sembrano approdare ad esiti che anticipano la “metarazionalità” (il movimento nato nel 1982), nel fissare la coesistenza e l’interazione tra il razionale (reso dalle forme geometriche) e l’irrazionale (reso dalle accese macchie coloristiche). Sono così adombrate qui le antinomie ordine / disordine, regola / casualità, simmetrico / asimmetrico, in un continuo confliggere tra la bellezza e l’informe, come in una visione anticipatrice della soluzione delle antinomie con il trionfo della bellezza, dell’ordine e della regola, in quello che sarà il Mosaicosmo.
Il dipinto Firenze passato futuro ci sembra abbia una matrice bergsoniana, nel senso che qui la percezione del tempo concretamente vissuto dalla coscienza dell’artista, nell’atto di contemplare Firenze, trascende quella del «tempo spazializzato» della fisica, configurandosi come «durata», senza soluzione di continuità tra passato e futuro. È l’opera che meglio si collega allo spirito della renovatio futurista, nel segno di un equilibrio raggiunto, nel rapportare l’habitat antropico (reso dalla sagoma umana in primo piano) con il quadrato (espressione geometrica della razionalità estrema), entro cui è rappresentata la cupola brunelleschiana. Il quadro è dunque un omaggio alla bellezza senza tempo di Firenze, che si proietta nel futuro (il cerchio sulla destra).
Ciò che maggiormente ci ha colpito dell’adolescenziale lascito pittorico di Romano è l’olio su cartone telato del 1967 raffigurante la Crocifissione. Mosso dal desiderio di misurarsi su un tema al centro di un’immensa tradizione iconografica, il dodicenne artista lo fa attraverso l’estrema radicalizzazione dell’impianto compositivo, dovuta certamente ai limiti tecnici di esecuzione, essendo egli ignaro di proporzioni anatomiche e di regole prospettiche. Eppure, quella semplificazione primitivistica delle forme diventa inaspettatamente un echeggiamento inconsapevole di sollecitazioni espressionistiche. L’occhio di Romano può ridurre il racconto ad una essenziale concisione drammatica, rappresentando una scena priva di qualsiasi individuazione topografica, con la figura del Cristo, che, pur nella quasi totale cancellazione dei tratti somatici, e nella destrutturazione degli arti, ridotti quasi ad espressioni filiformi, conserva una sua leggibilità. La Croce è immersa in un magma cromatico che assume una valenza simbolica nell’effetto fortemente contrastivo tra la luce spirituale irradiata dal punto focale del corpo scarnificato di Gesù morente, circondata dal rosso sangue del sacrificio, ed il nero delle sagome delle donne che, dando le spalle allo spettatore, si stagliano ai piedi della stessa nel raccoglimento della preghiera.
L’impatto emotivo suscitato da quella semplice schematizzazione è dovuto al senso di mistero che la pervade e a quel «respiro spirituale», che, per Kandinskij deve connotare la creazione artistica. Questa, egli avverte, «staccandosi» dal creatore «assume una sua personalità e diviene un soggetto indipendente con un suo respiro spirituale e una sua vita concreta. Diventa un soggetto dell’essere. Non è dunque un fenomeno casuale, una presenza anche spiritualmente indifferente, ma ha, come ogni essere, energie creative, attive. Vive agisce e collabora alla creazione della vita spirituale».
Guardando questa Crocifissione, si comprende già come il piccolo autore abbia trovato nella fede l’«unguento cromatico» con cui curare le ferite che la vita non gli risparmierà, e sia già pronto a “dilivrarsi” dal temporale, nella postulazione dell’Oltranza, sino alle cime invisibili dell’arcano.
CONCLUSIONE
“Se la Verità è qualcosa di pubblico,
ciò deve significare che ogni persona,
chiunque essa sia, finirà in ultima analisi
con l'accettarla come fondamento della sua condotta,
se condurrà abbastanza lontano la sua ricerca”.
Charles S. Pieirce,
Lettera a Lady Welby
23 Dicembre 1908
Se ci è consentita una breve precisazione di carattere metodologico, a conclusione della presente nota, diciamo che ci siamo attenuti alla triplice modalità di approccio letturale proposta da Gèrard Deledalle in Teoria e pratica del segno (tr.i; Palermo, Ila Palma, 1983), cui corrispondono tre tipi di "lettanti": il "lettante spontaneo" o presemiotico, come primo impatto emozionale, il " lettante assiomatico" o semiotico, basato sull'analisi dei fondamenti semiotici della struttura testuale, e il " lettante erudito" o postsemiotico, teso ad incanalare i risultati delle prime due letture nell'alveo del contesto storico, sociale, psicologico della citata struttura, cogliendovi il riverbero di una situazione generale.
Nell'adeguarci a tale procedimento, conforme alla mentalità triadica del Maestro di Deledalle, Charles S. Pieirce, abbiamo proceduto, nella veste di "lettante assiomatico", ad analizzare i fondamenti semiotici della produzione letteraria ed iconica del giovane Romano, riconducibili al rivoluzionarismo futurista, per poi correlarli strettamente, nella veste di "lettante erudito", con il clima ammorbato del periodo che, con evidente forzatura, ci si ostina a definire "Prima Repubblica", cosa che farebbe pensare ad una demarcazione, di fatto inesistente, rispetto ad una presunta seconda Repubblica. È stato evidenziato in proposito come le strutture dello Stato e le forze al potere rimanessero, senza soluzione di continuità, sostanzialmente quelle che si erano affermate alla fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo parlato di clima ammorbato, pensando al degrado etico conseguente, alla «conquista democristiana dello Stato» con il «ritorno ai clientes». Né l'opposizione comunista si rivelava più affidabile, avendo fatto propria la prassi della menzogna politica impostasi già ai tempi della terza internazionale, quando «Stalin e i suoi seguaci si erano distinti per la loro abitudine a ricorrere a sfacciate menzogne e falsificazioni storiche pur di giustificare le improvvise svolte nella loro linea politica, o per legittimare la liquidazione degli oppositori» (Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi).
È proprio tale ricognizione, così oggettivamente desolante, tanto che si è parlato di «disfatta della Costituzione» (Giordano Bruno Guerri), in relazione al contrasto stridente tra Stato sociale, cui essa guarda, è stato reale in cui viene sistematicamente calpestata, ad avere orientato il nostro approccio ermeneutico, facendoci intercettare, nel lascito segnico di Romano, la testimonianza di una salutare reattività creativa, in nome del Bello e del Vero.
Si è visto come quella reattività sia ascrivibile ad una rivalutazione dello spirituale nell'ambito del post-moderno, recuperando quella che fu una spiccata tendenza dell'esperienza futurista. Proprio quella rivalutazione vedeva la convergenza di gran parte degli eredi dello spiritualismo cattolico, accomunati dall'inesausta ricerca della Verità, quella, come afferma Michele Federico Sciacca, del «tempo salvato e recuperato all'eterno».