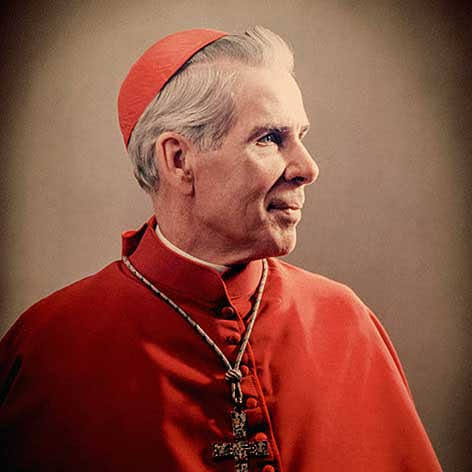“Tra crisi occupazionale e crisi etica. Che fine ha fatto la centralità del lavoro?” di Mario Bozzi Sentieri
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 30 Giugno 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1549
L’allarme arriva da Giovanni Belardelli, docente di Storia delle Dottrine politiche ed editorialista del “Corriere della sera”: l’Italia sta perdendo la centralità del lavoro. Non è una denuncia da poco per un Paese che si dice “fondato sul lavoro”, idea mitica a misura della fase della ricostruzione postbellica, tanto indeterminata – come notò subito Piero Calamandrei – da potere abbracciare le aspettative di un popolo, che si rimboccò le maniche, realizzando il boom economico e facendo dell’Italia una potenza industriale di prima grandezza.
“Ma da allora – scrive Belardelli sul “Corriere della sera” – qualcosa sembra essersi inceppato, perché la centralità del lavoro, se è rimasta inalterata nel primo articolo della nostra Carta, si è appannata nella concreta realtà del Paese”.
Dati alla mano si può dire che c’è una tendenza generale ad una contrazione della durata della vita lavorativa (32 anni contro una media europea di quasi 36) e ad un aumento, anche a causa del lockdown, dei cosiddetti “inattivi” (oltre che dei disoccupati) cioè di quanti rinunciano a cercare un’occupazione. Lo smottamento in corso ha però anche ragioni di fondo, che riguardano un cambiamento di mentalità, rispetto al consolidato orientamento della centralità del lavoro, e ad un’idea del reddito scisso dal lavoro, fatto questo che inverte l’ordine sociale e produttivo, spogliando – aggiungiamo noi – il lavoro di quella componente etica e partecipativa, che ne ha connotato l’essenza.
Da lì bisogna partire per ritrovare la centralità del lavoro e quindi la necessità di ridare valore e senso ad un’idea del fare che va ben oltre le ragioni della produzione e dell’economia. E che deve essere dunque ritrovato nella sua essenza spirituale e culturale.
C’è stato un tempo in cui – nota Charles Péguy, nella sua opera Il denaro (1913) - per i lavoratori “nel lavoro stava la loro gioia, e la radice profonda del loro essere. E la ragione stessa della loro vita. Vi era un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori, il più cristiano, il solo forse che possa rimanere in piedi”. Certamente non è sempre stato così.
Con la rivoluzione industriale e borghese il lavoro perde di senso, è scisso dalla vita e dalla comunità, riducendosi a semplice mezzo di sostentamento. Ma è proprio dalla “presa di coscienza” rispetto a questa condizione sociale ed esistenziale che nasce la volontà da parte del lavoratore di andare oltre la realtà del lavoro-merce e del suo sfruttamento.
Tra Ottocento e Novecento si può dire che la concezione del lavoro trasmuta, assumendo, a livello filosofico, un valore superiore e sul piano politico diventando un elemento essenziale della mobilitazione-nazionalizzazione delle masse.
Tra i filosofi che hanno posto al centro della loro riflessione il tema del lavoro, un nome di grande rilievo è quello di Adriano Tilgher che, nel 1929, scrive Homo faber, una storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale, attraverso la quale il lavoro diventa il centro di una nuova visione del mondo e della vita, capace di estendere all’universo e proiettare nel cosmo l’attività delle officine.
Per Ernst Jünger (L’Operaio, 1932) il lavoro non è un mezzo per acquisire vantaggi economici, ma l’espressione della vita: “Il lavoro non è, puramente e semplicemente, attività, ma l’espressione di un’essenza particolare che cerca di riempire il suo spazio, il suo tempo e di adempiere alle sue leggi”.
Sul piano politico, il lavoro incontra, nella campagna interventista del 1915, la Nazione. Il sindacalista rivoluzionario Filippo Corridoni, passato dall’antimilitarismo militante alla mobilitazione bellicista (fino a morire all’assalto di una trincea) diventa il simbolo di un percorso ideale e politico che sposta la prospettiva sindacale dall’utopia internazionalista (“lavoratori di tutto il mondo unitevi”) alla visione patriottica (“la Patria non si nega si conquista”), inverando quanto apparteneva storicamente all’originaria esperienza di classe.
Durante gli Anni Venti e Trenta del ‘900, il lavoro diventa un valore sociale, di “partecipazione alla vita comune per l’affermazione di una realtà che deve essere, che dobbiamo costruire, perché viene imposta dalla nostra coscienza. La solidarietà con quelli dei quali sentiamo l’identità di origine; il nostro sacrificio in vista della fortuna dei nostri figli e della Patria” - scrive Giuseppe Bottai (Esperienza corporativa, 1929).
E’ anche partendo da questa storia, complessa ed articolata, che il lavoro può ritrovare una sua nuova centralità. Per farlo però occorre ritrovare quell’idea di partecipazione alla vita comune, d’identità d’origine, di Nazione, di espressione della vita e della creatività dell’Uomo, di universalità, che ne hanno, per secoli, costituito l’essenza.
Meno retorica perciò sulla Repubblica “fondata sul lavoro” e più volontà di costruire proprio intorno al lavoro e grazie ai lavoratori una stagione partecipativa e di rinascita nazionale. Il rischio, al contrario, è il tramonto dell’idea stessa di coesione sociale e di benessere collettivo. Con buona pace per l’auspicata “centralità del lavoro”.