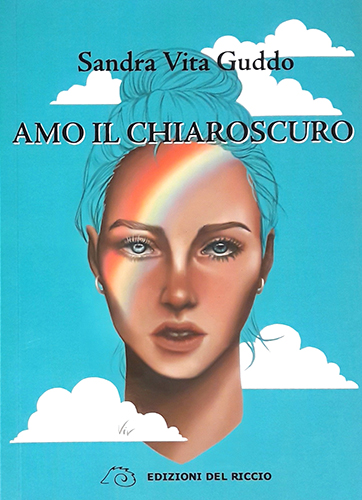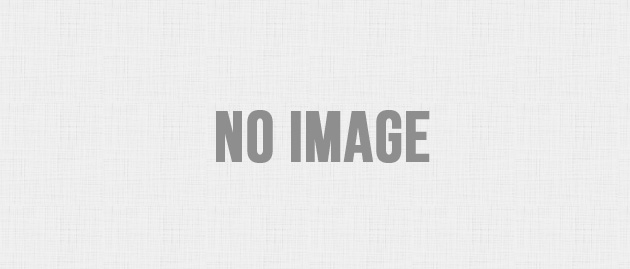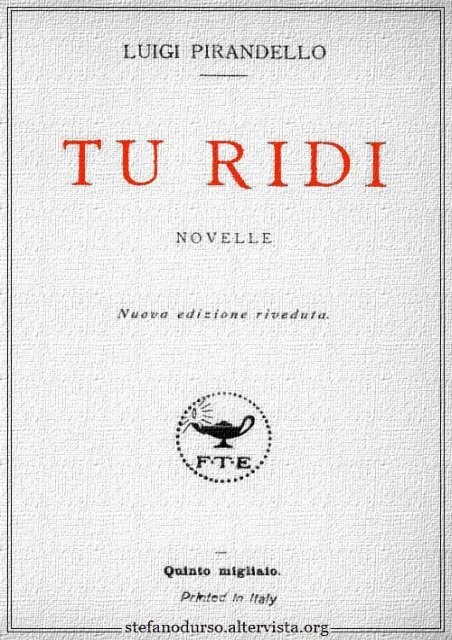“Ritorno al Greco e al Latino con Andrea Marcolongo e Nicola Gardini” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 04 Aprile 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2542
Unire in una riflessione per così dire “complementare” due libri che richiamano l’attenzione sul greco, quello di Andrea Marcolongo, La lingua geniale - 9 Ragioni per amare il greco, e sul latino, quello di Nicola Gardini, Viva il latino- Storie e bellezza di una lingua inutile, oggetto entrambi di una recente riedizione, mi sembra quasi scontato, e per la parentela storica fra le due lingue e le due letterature, greca e latina, e per la loro incontrovertibile presenza nelle nostre radici e nelle nostre secolari vicende culturali, sia come italiani, che come europei. In quel lontano passato è inscritta la nostra “identità”, anche se la memoria storica tende oggi a illanguidirsi (come mostrano le tante spaccature nazionalistiche nella UE, anche nella terribile presente emergenza del corona-virus), e anche se superficialità consumistica, pressapochismo linguistico e un pericoloso disumanizzante imperio tecnologico con i luccicori associati di facili benesseri materiali tendono a relegare il greco e il latino fra le lingue “morte” e “inutili”. I due libri citati, che vedremo separatamente, ne mostrano invece i grandi meriti storici e di perenne civiltà e civilizzazione se fruiti, il greco e il latino, in una storicizzazione scevra di distorsioni e strumentalizzazioni ideologico-politiche, e quale specchio immortale dell’umana condizione.
Quella lunga eredità del greco antico
Diceva Marguerite Yourcenar di avere amato il greco per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del vocabolario, nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà…[e] perché quasi tutto quel che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. Questa pregnante citazione arricchisce l’argomentato excursus che del greco antico attua nel su citato libro La lingua geniale -9 Ragioni per amare il greco (2018) la scrittrice Andrea Marcolongo, che se ne dice innamorata sin da ragazza: l’amore più lungo della mia vita. Notizie storiche, osservazioni linguistiche, ricordi autobiografici, sommari di varia erudizione, consigli pratici di traduzione, compongono di pagina in pagina quello che l’autrice definisce non una grammatica convenzionale descrittivo-normativa, ma un racconto letterario di alcune particolarità di una lingua magnifica ed elegante, del cui modo di esprimersi fulmineo, sintetico, ironico, aperto le pare si possa provare nostalgia soprattutto oggi in cui le “parole” cedono rimpiazzate da emoji e moderni pittogrammi. Il greco -aggiunge l’autrice- sapeva dire cose complesse con parole semplici, vere, oneste. Sua ambiziosa “sfida” è pertanto fare innamorare o re-innamorare chi tale lingua non ha conosciuto e non conosce, o chi ne ha fatto esperienza impropria fra i banchi del liceo classico fra paure, frustrazioni, odio e fretta solo di lasciarsela alle spalle per quelle decine e decine di tabelle di declinazioni di nomi e coniugazioni di verbi e molteplicità di regole apprese a memoria o male senza penetrarne il senso profondo di “relazione” consapevole, libera, soggettiva con il mondo, la vita, gli altri, se stessi. Il punto è infatti proprio questo: una lingua, ogni lingua, serve a dare “forma” al mondo, a “un mondo”, da qui l’invito ai lettori a giocare a pensare in greco antico. Dal punto di vista storico la Marcolongo viene ricordando che il protogreco o greco comune, cioè la lingua greca unitaria che stava alla base di tutti i successivi dialetti greci, sviluppatasi intorno al II° millennio a. C., e poi in età storica il greco antico (o classico), articolato nei 5 gruppi dialettali: dorico, eolico, ionico-attico, arcadico-cipriota, dialetti del Nord-Ovest (Delfi, Epiro, Argo, Tebe), hanno conservato per secoli, nonostante le innovazioni dovute agli inevitabili mutamenti sociali, finezze espressive e preziose sfumature di senso accumulatesi nei pregressi granai linguistici e intellettuali dell’indoeuropeo. Indoeuropeo che, da originari territori -pare- a Nord del Mar Caspio e del mar Nero, diffusosi e differenziatosi sin dal IV millennio a.C. attraverso lunghi processi migratori di popoli in varie zone del continente euroasiatico, troviamo all’origine di molti ceppi linguistici dell’Europa (i gruppi neolatino, germanico, celtico, baltico-slavo) e dell’Asia (armeno e gruppo indo-iranico con sanscrito, vedico, persiano, urdu, gli idiomi di minoranze linguistiche presenti dall’Oman all’Afghanistan al Pakistan, l’avestico degli scritti zoroastriani). Dalla lingua indoeuropea, di cui non è rimasta nessuna traccia ma solo ipotesi su studi comparati, e tuttavia espressione nei suoi remoti tempi -sottolinea la Marcolongo- di una civiltà/cultura unitaria, condivisa, distintiva e dominante, sono derivati al greco antico la distinzione fondamentale tra sistema nominale e verbale, tra genere animato (maschile e femminile) e genere inanimato, donde l’uso del neutro, tuttora riscontrabile nel greco moderno; i tre numeri singolare, plurale, duale, quest’ultimo -dice- numero molto umano, e non “matematico”, perché utilizzato assai liberamente e se il parlante o lo scrittore “sentivano” fra due persone o cose un’intima connessione/relazione. Inoltre, il complesso sistema dei casi, che il greco classico riduce da 8 a 5, fondendo l’ablativo indoeuropeo con il genitivo, e il locativo e lo strumentale indoeuropei con il dativo; il carattere stesso ritmico e musicale della lingua greca, per la natura melodica, e non intensiva, dell’accento, e per l’alternanza di sillabe lunghe e brevi. Tutte caratteristiche analizzate con passione dalla Marcolongo che evidenzia quanto ai verbi il prevalere, per il parlante greco, del valore “aspettuale” dell’azione (cioè il come, la qualità dell’azione), altra gloriosa eredità dell’indoeuropeo, rispetto al suo valore “temporale” e marginale (il quando), donde i tre indipendenti temi verbali, nel greco antico, del presente per dire l’azione in via di svolgimento, dell’aoristo per l’azione puntuale, astratta da ogni tempo, del perfetto per l’azione passata i cui effetti permangono nel presente. La peculiarità esistenziale della categoria dell’Aspetto risalta anche dal fatto che, secondo il loro specifico significato, non tutti i verbi avevano i tre temi. Ad esempio i verbi <<abitare>>, <<regnare>> -precisa l’autrice- avevano quasi sempre solo il tema del presente perché o abiti da qualche parte o sei senza tetto; o sei re o non lo sei. Invece <<morire>>, <<vivere>>, solo il tema dell’aoristo, perché lo spirare è azione puntuale come l’essere grati alla vita per il solo fatto di essere vivi; senza perfetto infine <<sperare>>, <<ridere>>, <suonare la tromba>> (di guerra) perché esprimono azioni senza conseguenze (sto sperando, sto ridendo, sto suonando la tromba...). In questo scavo del “pensare in greco“ e quindi del “dire e scrivere in greco”, che -confessa- le hanno insegnato negli anni a dire molte cose in più a se stessa e agli altri, la Marcolongo sottolinea la ricchezza portatrice di senso (logico) della “flessione” delle parole greche e del sistema dei casi che consentivano una ordinata anarchia delle parole, lasciavano cioè allo scrittore assoluta libertà espressiva e di personale, originale, resa stilistica nella collocazione delle parole all’interno della frase, consentendo alla letteratura greca quell’agilità -dice- e quella drammaticità -nel senso di vita, di sincerità- che tanto ci seducono nella lettura di quegli antichi testi. Definisce infine, con una punta di rammarico per la sua perdita (come prima per il duale), l’ottativo, che era il modo verbale del desiderio e del rimpianto e anch’esso scheggia elegante, per citare Antoine Meillet, dell’indoeuropeo, come il più personale e il più intimo tra i modi verbali, dei quali l’individuo greco si serviva per rappresentare a sé e agli altri la vita, e per darne una misura. Se il modo dell’obiettività era l’indicativo, della volontà/eventualità il congiuntivo, quello della possibilità era l’ottativo, una sorta di “misura” tutta soggettiva e sospesa del fatto che il desiderio (nella vita) da possibilità diventi eventualità (cioè concreta possibilità di realizzazione) e poi realtà, oppure scivoli via per sempre nell’irrealtà. Un misto come si vede di intenzionalità, paura, desiderio tutti soggettivi… Ma osserva la Marcolongo troppo sottile e allo stesso tempo troppo densa era la linea di senso che tracciava il confine tra eventualità e possibilità, tra congiuntivo e ottativo, per potere resistere l’ottativo al prorompente bisogno che si avvertì nel periodo ellenistico di semplificare la lingua per avvicinare il greco classico ai popoli non greci unificati dall’impero di Alessandro Magno. Nella nuova lingua comune dell’Ellenismo, la Koinè, nata dalle ceneri del dialetto ionico-attico (precedente strumento di espressione degli autori del periodo più glorioso della storia di Atene: Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Platone, Tucidide, Isocrate…) e diffusa dall’epoca di Alessandro Magno al crollo dell’impero bizantino nel 1453, scompaiono i caratteri fondamentali che il greco classico aveva ereditato dall’indoeuropeo: l’accento quantitativo, il duale, l’ottativo confluito nel congiuntivo, la categoria aspettuale del verbo vinta da quella temporale. Il presente sopravvive ma senza più il valore durativo; sopravvive pure l’aoristo, ma scomparso il perfetto, l’aoristo ne assume il significato, divenendo simile, fino al greco moderno (nato dalla Koinè ellenistica di base attica, fissatasi nella scrittura e conservata nei secoli dalla Chiesa), ai nostri passato remoto e passato prossimo. Un greco moderno, in cui scomparso il dativo, resiste ancora la declinazione delle parole nei 4 casi del nominativo, accusativo, vocativo, genitivo, quasi a ribadire al mondo -riflette la Marcolongo- accanto ad altri residui del passato, quale la fonetica ancora di tipo ellenistico, l’identità di un popolo che ha il passato culturale più imponente del mondo occidentale, da Omero fino a Polibio, Plutarco, Luciano… Nel libro l’autrice ha anche inserito alcune schede riassuntive che forniscono informazioni sulla coltivazione del vino nell’antica Grecia e sulla consuetudine dei simposi, momento ludico ma anche di confronto su argomenti civili, politici, culturali; o sulla “percezione” dei colori da parte dei Greci che li definivano e “nominavano” in rapporto alla gradazione di ombra o di luce in essi presenti (vedi <<glauco>> cioè traboccante di luce, come il mare che appunto sfrigola di luce o gli occhi di Minerva chiari come quelli della civetta, di colore cioè ceruleo). Altre schede discutono dei dizionari greci e delle grammatiche greche in uso ieri e oggi. O riguardano: la poesia monodica e corale e la fortuna di Pindaro; la singolarità di alcune onomatopee e etimologie, con riferimento anche alle medievali Etimologie o origini di Isidoro di Siviglia, grande dottore della Chiesa e dal 2002 patrono di internet per designazione di Giovanni Paolo II; la funzione nei testi dell’alfa privativo e delle antiche particelle equivalenti a segni di interpunzione; la storia della scrittura (dalla micenea lineare A e cretese lineare B all’introduzione dell’alfabeto fenicio adattato dalle popolazioni greche ai loro bisogni, e trasmesso agli italici delle varie colonie greche, e molti secoli dopo, nell’850 d. C. dai bizantini, con Cirillo e Metodio, ai popoli slavi). Le schede infine troviamo sui tabù linguistici di varie civiltà, e sui diversi tipi di lingue del mondo fra le 4500 tuttora esistenti e residue (distinte in flessive, agglutinanti, isolanti, incorporanti). E poiché il pregio e la forza di una “lingua” stanno nella sua capacità di aprire prospettive complesse, e non facili e banali sul mondo, la dettagliata carrellata storico-linguistica della Marcolongo sugli antichi “tesori di senso” del greco antico, che ci fanno felicemente risalire indietro fino alle prime, originarie, interpretazioni/significazioni del mondo e dell’intensità/complessità della vita umana, rende ragione della attrazione di intere generazioni di intellettuali per il “Greco”, lingua a cui -scriveva Virginia Woolf, citata proprio ad apertura di libro- torniamo quando siamo stanchi della vaghezza, della confusione; e della nostra epoca. Nulla di più attuale dunque che un “risveglio” del greco antico e dei suoi autori quale “specchio” e pungolo per il nostro disorientato oggi (ancor più “disorientato” per la tempesta di precarietà scatenata dal covid-19), umilmente richiamando alla mente anche l’ammirazione di Montaigne per i classici:<< Quando vedo -scriveva- queste vigorose forme di esprimersi, così vive, così profonde, non dico che è un parlar bene, dico che è un pensar bene>>. E il “pensar bene” è fondamento (e dovrebbe esserlo ancor più in questo tremendo 2020) di ogni ben vivere civile ed equo, a livello locale e planetario.
Lo spazio sempre vitale del latino
Scriveva Giovanni di Salisbury nel Policratico, con occhi e mente rivolti al mondo antico e precorrendo Poggio Bracciolini e il movimento dell’Umanesimo, che le lettere in molte cose ci recano frutti dolcissimi, ma il più dolce frutto esse ci danno abbattendo le barriere del tempo e dello spazio, e realizzando una comunità di amici in cui vive perenne tutto ciò che è degno di vivere. E in tempi molto più vicini a noi, a ulteriore integrazione di segno anch’esso marcatamente umanistico, risulta illuminante l’affermazione di Marguerite Yourcenar che, quando si parla del passato, occorre fare attenzione: è dell’amore della vita che si tratta; la vita è molto di più al passato che al presente. In tale ottica, che invita a rivitalizzare la tradizione classica, si muove anche l’elogio del latino letterario sviluppato da Nicola Gardini nel libro Viva il latino- Storie e bellezza di una lingua inutile (2018), libro nel quale l’autore ha immesso molto di personale, anzi di autobiografico, oltre che di squisitamente tecnico. Professore oggi di letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford, ma appassionato al latino fin da bambino, Gardini attraverso ricordi di scuola, letture liceali e universitarie, e predilezioni soggettive (riletture e rimeditazioni precisa) svolge una articolata riflessione sulla lingua latina e gli autori che più ne hanno segnato la storia, rapportando il suo intenso excursus linguistico-letterario alla sua ferma convinzione che anche fuori dalla latinità i singoli scrittori incarnino solo le condizioni empiriche attraverso cui alle lingue è consentito di tentare nuove strade e di trasformarsi. Donde l’attenzione ai diversi stili dei diversi autori essendo lo “stile” solo un’occasione nella vita di una lingua. Suo proposito -come già visto per la Marcolongo- è quello di provare a trasmettere l’amore del latino al di qua del cumulo di regole astratte necessarie per il suo apprendimento, ma tuttora troppo sganciate -dice- nella prassi scolastica dalla lettura diretta dei testi originali, sui quali converge invece il suo primario richiamo, perché il latino di quei testi ha formato le società e i sentimenti in cui tutti viviamo (sic!). Senza il latino il nostro mondo non sarebbe quello che è. Agli assertori della inutilità della lingua latina obietta che la conoscenza non può ridursi a traduzione immediata del sapere in qualche servizio pratico, a soddisfacimento di bisogni solo immediati e materiali, negandosi il soggetto il piacere del capire interpretando, che è ciò che rende veramente liberi e non-schiavi del mercato, dei politici, di pseudobisogni creati da interessi e logiche estranei alle necessità autentiche delle “nostre persone”. Agli utilisti che dicono che per la complessità morfologica e sintattica il latino insegna a ragionare e dà una disciplina mentale applicabile dovunque, ricorda che non si può confinarlo a puro “addestramento” perché ha meriti propri di civiltà e di bellezza, e non riconoscerli è un attentato alla ricchezza del mondo e alla grandezza dell’intelletto umano. Aggiunge inoltre Gardini che il latino non è una lingua morta, non solo perché è parlato ancora nella Chiesa e in certi convegni internazionali, ma soprattutto perché consegnato a una letteratura la cui voce ha avuto una plurisecolare forza modellizzante per profondità di contenuti e magistero formale, sin dall’intenso laboratorio cristiano e nuova topografia dello spirito affermatisi con san Gerolamo e sant’Agostino, e protrattasi tale ”forza” fino a Dante, al picco del Rinascimento e oltre, per arrivare al ‘900 con Pascoli e Ferdinando Bandini, continuando a dirci cose importanti sul senso della vita e della società. Morto e moribondo -sottolinea- è chi non ascolta, non chi parla. Il boicottaggio oggi del latino e della missione in genere della letteratura a caratura umanistica si risolvono per lui in autolesionismo e autodistruzione: perché, se non ascolto, io mi svuoto, mi appiattisco, mi assottiglio, scompaio. E a dimostrazione, nella sua appassionata ottica, che il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana e alla fede nelle possibilità del linguaggio, analizza trasformazioni della lingua e peculiarità stilistiche che hanno fatto la Latinitas, cominciando dal De agri cultura di Catone il Censore. Se l’alfabeto latino nacque tra l’VIII e il VII sec. modellato su quello greco, ma reso latino secondo la leggenda da Carmenta, madre di Evandro (Igino, Virgilio, Ovidio, Boccaccio); se il latino arcaico, anch’esso di derivazione indoeuropea, che della sua antica matrice ha conservato il sistema dei casi ridotti a 6, è testimoniato da centinaia di epigrafi, per trovare un primo sentore di scrittura “artistica” bisogna aspettare il III sec. a. C, il De agri cultura appunto catoniano con la sua prosa prescrittiva e formulare, giocata su poche strutture sintattiche e tuttavia efficacemente concisa. Ma è con Cicerone -scrive Gardini- che il latino comincia a pensare se stesso, a stabilire un metodo per essere, diventando classico nell’ultima fase della Repubblica. Teorizzatore e incarnazione del latino “alto”, Cicerone portò all’eccellenza il trattato retorico, l’orazione politica e giudiziaria, la lettera privata, il saggio linguistico, il saggio filosofico. Attraverso la sua attività politica e civile e il suo impegno speculativo, consegnati ai suoi scritti, precisi nel lessico e dai periodi chiari, ordinati, complessi, melodici, la perfezione linguistica si fa cifra di eccellenza spirituale per il sistema di valori civili e di modelli etici e spirituali di cui diventa strumento e mediazione, ergendosi a paradigma plurisecolare da Quintiliano all’Umanesimo-Rinascimento alle diverse e successive letterature nazionali. La versatilità/duttilità del latino, avvicinatosi all’estetica greca già con Ennio e il suo ideale di uomo facundus (Annales) si è misurata in ogni campo della creatività e della conoscenza. Il latino dell’Eros ad esempio, nelle sue variegate sfaccettature in relazione alle diverse manifestazioni fisiche e sentimentali dell’eros stesso, è seguito da Gardini in Catullo Lucrezio Virgilio Ovidio Properzio Apuleio. Nella poesia fresca e individualistica di Catullo si compiace, fra l’altro, di isolare i momenti del turpiloquio, mostrandone la valenza politica di protesta sociale, non nel senso del carnevalesco e della sovversione, ma della conservazione. Il rispetto dei ruoli sessuali era per il giovane poeta (innamorato e tradito da Lesbia) rispetto dell’ordine sociale, come si evince anche dai carmi 61 e 63, e l’amore una forma di corrispondenza da consacrare con il vincolo del matrimonio. In Lucrezio (De rerum natura, l. IV) l’amore, vulnus e voluptas, si rivela nell’incontro sessuale ricerca di una completezza impossibile, e sorgente solo di fantasmi inafferrabili (simulacra tenuia). In Properzio troviamo dolcezze e sofferenze: l’amore è furor, morbus, toxicum; omnia vertuntur: -dice- certe vertuntur amores, o ancora omnis… timetur amor donde l’esperienza conseguente della solitudine: cogor ad argutas dicere solus aves. Il latino della “critica sociale” emerge attraverso il sorridente quadro di costume di Orazio, lo stigma caricaturale di Petronio, che non rifugge da forme plebee, neologismi, colloquialismi, complice il genere romanzo (come d’altronde in Apuleio), e attraverso l’indignazione concitata e il dettagliato realismo di Giovenale, cui erano cari i termini paupertas, simplicitas, mensura. E non tralascia Gardini di ricordare la geometrica ratio della prosa di Cesare, riflesso del lucido pragmatismo dello stratega; la narratività distesa, idealizzante e “romanzesca” del ciceroniano Tito Livio; gli acri, scorciati, chiaroscuri di Tacito, che condanna e riassume, e che è -confessa- il suo prosatore latino preferito, perché rappresenta l’essenza stessa del latino, l’estremizzazione più consapevole e superba delle sue caratteristiche più originali: condensazione, efficacia, pienezza, chiaroscuro (anche come mistero ed elusività). Ma lo studioso indugia pure sul Lucrezio filosofo, il cui lessico nel De rerum natura giudica aspetto fondamentale del suo modernismo per la capacità del poeta di circoscrivere e definire i significati, e per le estensioni semantiche e metaforiche realizzate. E ne cita la ridefinizione concettuale dei termini res, religio, pietas, la quale ultima suona come rifiuto sempre attuale di ogni forma di integralismo fanatico/superstizioso: nec pietas ullast velatum saepe videri/ vertier ad lapidem…nec procumberi humi prostratum… nec aras sanguine multo spargere quadrupedum (oggi di uomini!)… sed mage placata posse omnia mente tueri (sic!)! O ancora, quanto agli “atomi”, l’uso di semen, corpus, primordium, o il neologismo clinamen, e le potenti immagini: moenia mundi, materiae pelagus, tutti suggestivi e indaganti scandagli nell’infinito quanto i coinvolgenti Somnium Scipionis di Cicerone e Consolatio ad Marciam di Seneca. E piace ricordare l’affermazione/tesi di Montaigne:<<E’ il vigore dell’immaginazione che innalza e gonfia (in senso positivo) le parole. Della Consolatio evidenzia Gardini anche il pensiero della umana finitudine, utile e spendibilissimo correttivo oggi per tanti arroganti eccessi e storture della cosiddetta modernità tecnologica (e l’esperienza e gli effetti attuali del corona-virus ci stanno mettendo faccia a faccia a livello planetario proprio con i nostri limiti e costituzionale fragilità biologica). Non nasconde poi il linguista la sua predilezione per Virgilio, la cui fortuna -scrive- sta prima di tutto nella bellezza della lingua. Rifondò infatti il mantovano la lingua della poesia ristrutturandone la sintassi, soprattutto nell’ordine della frase e nel rapporto frase/verso, puntando su ossimori, chiasmi, enallage, e sugli enjambement altamente funzionali al tessuto narrativo dell’Eneide e alla emotività delle vicende rappresentate. Delle opere di Virgilio, comprese Bucoliche e Georgiche, sono evidenziati anche il tema della perdita e del distacco, l’ambiguità poetica e esistenziale del termine umbra (rifugio/riparo dalla calura ma anche mistero e presentimento di un al di là), e “l’utopia bucolica” come archetipica nostalgia delle origini e sogno sempre risorgente di rinnovamento. E per finire, torniamo a Seneca che -ammette Gardini- è l’intellettuale che più lo ha aiutato a vivere, dandogli lezioni di felicità nel presente. Felice è per Seneca chi sa vedere con chiarezza, oggi, ora, la sua realtà interiore… chi evita l’insoddisfazione, l’inconcludenza, l’incostanza, lo spreco, il vuoto, la noia… La lineare simplicitas della sua “scrittura morale”, che è l’opposto della concinnitas ciceroniana, e il suo distacco dalla folla/massa (argumentum pessimi turba est) nel chiaro discrimine fra ciò che è essenziale e ciò che è vano, consuonano, in un moderno alone di attualità, con la sapiente arte di vivere di Orazio ugualmente distante (Odi profanum vulnus et arceo), nello spazio indipendente dell’io, da volgarità e succube idiozia. Anche quelle, si intende e soprattutto, di oggi o di domani!
Non stupisce pertanto -e non si può non concordare con entrambi- la convergenza sostanziale della Mastrolongo e di Gardini nel pensare, dire, suggerire che chi ha avuto e/o ha dimestichezza con la cultura “classica” greco-romana non solo si riconosce, nel parlare e nello scrivere, dalla ricchezza del lessico e dalla familiarità con l’ipotassi, ma è anche, nella sua strutturale pretesa di coerenza logica, una preda assai difficile e pochissimo vulnerabile da manipolazioni giornalistiche, politici arroganti e ignoranti, onde divenute sempre più anomale dei social. Indicativo inoltre di una urgenza/emergenza storica è che il messaggio dell’una (Mastrolongo) e dell’altro (Gardini) guardi soprattutto ai giovani, ragazze e ragazzi, i quali sono in cerca di senso e di punti di riferimento (come tanti squallidi fatti di cronaca mostrano), ma sono rimasti a tutt’oggi purtroppo miseramente orfani di serie politiche culturali e “formative”. Chissà che la tempesta del covid-19 con la clausura forzata di tutti in casa, con “pause” riscoperte di lettura dei nostri classici, antichi e moderni, e con la conseguente stringente opportunità di riflessione, soggettiva e collettiva, sul destino comune, non aiuti tale auspicata svolta!