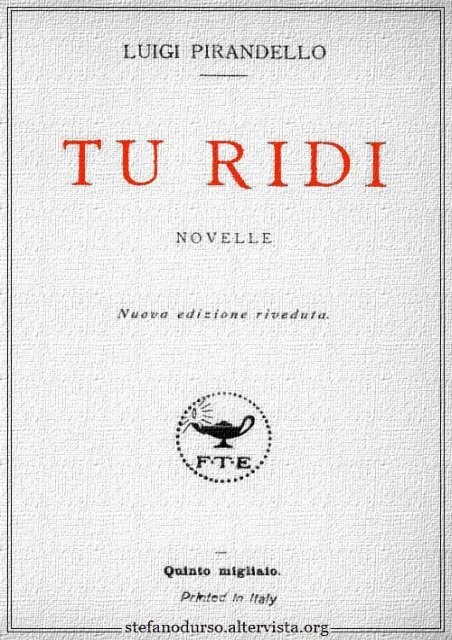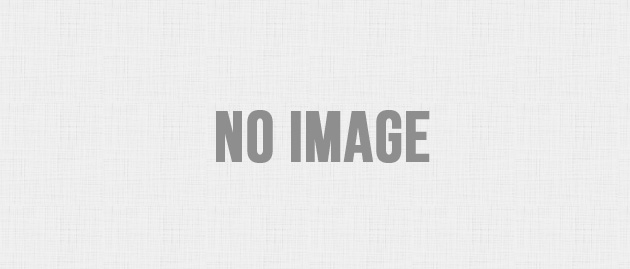Prefazione di Andrea Scarabelli a “Imprescindibili” di Tommaso Romano (Ed. Ex Libris)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 06 Maggio 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 604
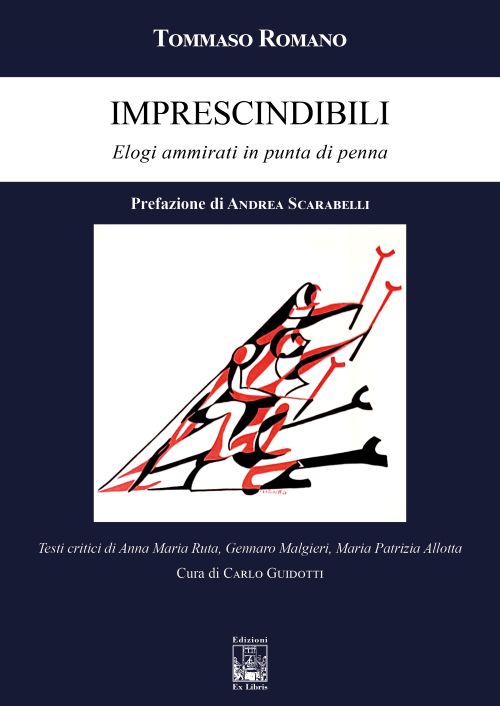 In punta di penna
In punta di penna
Se tracciare una biografia non è mai semplice, farlo nella for
ma di un ritratto fulmineo, che acquerella in tre o quattro cartelle il senso di un’esistenza intera, lo è ancora meno. E non c’entrano il numero di battute, la scelta delle immagini e delle parole, il bilanciamento tra generale e particolare nonché le ingenuità stilistiche, sempre in agguato, che sovente – ma non è questo il caso – trasformano il tutto in agiografia o celebrazione intimistica. Creare “ritratti letterari” implica rimettere in moto «in punta di penna», come dice Tommaso Romano, esistenze risolte, restituire il passato al presente, sciogliere il divenuto nel divenire, trasfigurare le individualità: una volta ritratto, un autore diviene irrimediabilmente altro da sé. Non sfuggono alla norma i profili antologizzati in questo volume aureo.
Sfogliandolo, la memoria torna a Esercizi d’ammirazione di Emil Cioran, uscito nel 1986 e ora ospitato dal prestigioso catalogo di Adelphi. Lo ebbe tra le mani Mircea Eliade, presente nell’antologia cioraniana (ma anche in Imprescindibili), e con ogni probabilità fu l’ultima cosa che lesse prima di passare oltre. Il vedersi immortalato dall’illustre amico e connazionale, divenendo appunto altro – altro da sé, altro dalla vita – grazie all’alchimia letteraria del “folle dei Carpazi”, fu forse l’obolo pagato al guardiano della soglia che a lui dovette manifestarsi a Chicago quel 22 aprile del 1986, quando, sprofondato nella sua poltrona, reclinò la testa tenendo gli Esercizi tra le mani.
Il fatto che tutto questo sia avvenuto grazie a un libro non è casuale.
Ciò che consente la forma-libro è un doppio rispecchiamento: l’autore si racconta attraverso altri, ed è inevitabile sia così. La pratica di biografare qualcuno non è d’altronde innocente, ma implica una sorta di “travaso animico”. Da un lato, l’estensore dissemina parti di sé nelle vite che racconta, dall’altro le accoglie nel proprio foro interiore. Da un certo punto di vista, diventa come loro.
Compie un sacrificio del “reale” (ammesso che questo termine significhi alcunché), il quale muore al mondo per poi risorgere simbolicamente nei labirinti della parola – anzi, della parola scritta. È una delle ragioni per cui agli albori della filosofia, in un’epoca che vide in λόγος e μῦϑος i termini di un’endiadi ancora illibata, non mancarono attacchi contro la parola scritta in nome della parola parlata, di cui quello platonico del Fedro è solo il più celebre. Fu una delle svolte più radicali della nostra civiltà, come ricostruito da studiosi di ogni latitudine e longitudine, dal Walter J. Ong di Oralità e scrittura a Giorgio Colli, fino al fenomenologo Carlo Sini. Frapponendosi tra noi e il mondo, il linguaggio ne prende il posto, e l’uomo finisce per incontrare ovunque sé stesso e le proprie trame simboliche (Cassirer). Il mondo come fenomeno linguistico, inveramento della dottrina del Verbo creatore… Qui la semiotica e la magia rinascimentale si danno la mano, ma è un discorso che ci porterebbe molto lontano.
Tornando al tema principale, come già detto, tale meccanismo emerge nella forma-libro, e nell’antologia di ritratti al sommo grado. Basta dare una rapida occhiata a Imprescindibili per rendersene conto.
Sondando una galassia di “biografie uniche”, Tommaso Romano traccia la propria. I personaggi raccontati estrinsecano molti dei caratteri e delle attività da lui compiute: le incursioni metapolitiche nella politica e l’insegnamento, la letteratura e la poesia, la filosofia, il “mosaicosmo”, l’attività editoriale… la fede cristiana unita a quella monarchica, ma anche gli interessi esoterici e artistici. Su tutto, la voce di un potente Genius Loci insulare, «l’humus magico-sacrale della Sicilia primordiale eterna» evocato nel ritratto di Giuseppe Rovella, la «Sicilia “inedita”» di Guglielmo Lo Curzio, asse del Mediterraneo solare. Anche in questo caso, è una geografia interiore, che invera le parole del Borges de L’artefice: «Un uomo si propone di disegnare il mondo. Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Dopodiché scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto».
Una somma di rimandi esterni, dunque, ma non solo. Il prudente ordine alfabetico dei ritratti ne sottende un altro, circolare e irradiante: la fitta rete di affinità elettive di un mondo culturale parallelo, spesso ignorato ai “piani alti” e vivace come pochi altri nello stabilire quella che l’autore definisce «convergente comunicazione». Una galassia “non conformista” di nomi e iniziative culturali, riviste e periodici, alcuni longevi e altri limitati a introvabili numeri unici, cui si aggiungono i Centri Studi, ognuno dei quali dotato di un bollettino, e decine di conferenze in giro per l’Italia, che raccolgono e riassumono il nord e il sud, le anime regionali, di fatto strutturando una generazione in cui Tommaso Romano si muove con disinvoltura, facendo da “agente di collegamento”. Tra le righe di Imprescindibili emerge infatti un’azione trasversale, che lega ambienti e gruppi spesso conflittuali, autoreferenziali e chiusi in sé stessi, dove la presunta impersonalità dell’idea non di rado annega in una teoria di personalismi. Isole incapaci di divenire arcipelago, dice spesso il «poeta autentico» Sandro Giovannini, anche lui citato nel volume, e a giusto titolo.
È una generazione che non teme di confrontarsi con il passato, sia prossimo sia remoto. E non è solo la percepita necessità di fare i conti con i primi decenni del Novecento italiano ed europeo, vilipesi e sbugiardati dal conformismo imperante. C’è di più. Il pensiero delle origini che anima l’intreccio di storia delle religioni, antropologia e tradizionalismo presente in molti di quegli ambienti è un tentativo di giungere al cuore della temporalità stessa, percependone l’ampio respiro e di fatto operando una “rigenerazione del tempo”, trasformando tramonti in aurore, le tracce del declino nelle premesse di un Nuovo Inizio. Non c’è migliore antidoto al presentismo iconoclasta oggi dilagante, che nel passato vede un fardello di cui disfarsi, identificando nelle identità e tradizioni dei popoli (il plurale è d’obbligo) un ostacolo al livellamento che del mondo contemporaneo è la madrelingua. Da questo punto di vista, il libro che avete tra le mani, oltre a testimoniare l’esistenza di un altro volto del XX secolo, è anche un manualetto per affrontare il XXI.
Le esistenze raccontate da Romano incarnano diversi modi di abitare la temporalità (che, stando alla lezione heideggeriana, è e rimane la cifra ultima dell’Essere). Alcuni sono contemporanei del passato, altri del futuro. Difficile trovarne qualcuno che lo sia del presente. È una inattualità agita e non subita, rivendicata e non lamentata, la stessa che da un secolo e mezzo – da Nietzsche in poi, per capirci – marca le migliori intelligenze della cultura continentale, allergiche alle mode del momento, «aliene dai clamori e dalle lusinghe del tempo», come si legge di Antonio Billeci. In Imprescindibili non troverete muse arruolate alla volgarità imperante, ma intelletti ansiosi di formulare una visione del mondo dagli orizzonti più ampi. Una Weltanschauung spesso ereditata e trasmessa, approfondita e rimodulata: se dietro a Giacinto Auriti si stagliano le dottrine di quella «formica solitaria» tra «le rovine d’Europa» che risponde al nome di Ezra Pound, è invece il magistero goethiano a illuminare il profilo di Ernst Jünger, immortalato mentre ascolta la Seconda di Mahler nel Duomo di Monreale o intrattiene silenziosi conciliabili con un gatto nel chiostro.
È un crocevia spazio-temporale che non comporta fughe indietro o avanti (l’Où fuyez-vous en avant, imbéciles? di Bernanos), ma ha per presupposto la nozione di illud tempus tematizzata dal già citato Eliade, che taglia verticalmente le epoche. Al cospetto dello jüngeriano “muro del tempo”, il ricorso al passato rivela tutta la propria raison d’être, e al contempo la propria insufficienza: basta non ipostatizzarlo. Se il passato può essere un modo per sfuggire alla tirannia di un presente opprimente, chi vi si rifugia non fa che ripetere il medesimo errore, abbandonando l’hic et nunc solo per riconfermare la potenza necessitante del tempo stesso. Al contrario, colui che nel passato non vede un feticcio da venerare ma una riserva di paradigmi capaci di orientare un presente alternativo, allora esce dalla stessa temporalità, entrando nell’Eterno. Giunge così alla «radice, la primordialità, intesa come fondamento di presente e futuro», come può leggersi nel ritratto di Roberto Incardona.
Crocevia di questi orizzonti temporali (Heidegger) è, per l’ennesima volta, la forma-libro, che estrae dal qui e ora la continuità, sublimandola nell’avvenire. Ne era ben conscio il già citato Borges, uno che di biblioteche se ne intendeva, quando scrisse che «ogni libro pubblicato è un trionfo sull’oscurità». Credo sia anche per questo che i ritratti collezionati da Romano sono affidati alle pagine di un volume. Sono libri che parlano di altri libri, in una semiosi infinita, che ci invita a vedere nell’universo un libro infinito, dotato di rimandi interni ed esterni, indici dei nomi e note a piè di pagina. Una “vigna del testo”, come la definì Ivan Illich.
Non credo sia una lettura forzata, dal momento che alla carta stampata l’estensore di questi ritratti ha tributato un vero e proprio culto. E non solo come lettore e autore. Tommaso Romano è infatti anche editore e, a distanza di decenni dalla sua fondazione, Thule continua a dare alle stampe raffinati volumetti, oasi nel deserto della cachistocrazia imperante.
Solo chi pubblica libri sa cosa significa tutto ciò. Solo chi vede nascere un testo conosce il sottile nesso che lo lega al suo autore. Imprescindibili nasce anche da tale consapevolezza, da cui scaturisce un catalogo di individualità ieratiche e assolute (sciolte cioè dal loro contesto), «paragonabili solo a sé stesse», come scrive di Francesco Carbone. Potremmo considerarlo un inventario di stili, un’antologia che per vie traverse rivela il miracolo che si verifica quando l’uomo si lega al proprio stile, imprimendolo a un verso, un’opera, una serata o un secolo.
Esperienze esistenziali monadiche, che attraversano i decenni come le figure di un caleidoscopio. Con raffinata ars combinatoria mescolano e rimescolano forme e sostanze, inverando la dottrina goethiana della metamorfosi. E non è un caso che il padre del Faust ne abbia individuata la chiave di volta, la pianta originaria (Urpflantze), a passeggio per l’orto botanico di Palermo, di fronte alla potenza proteiforme della Sicilia eterna.