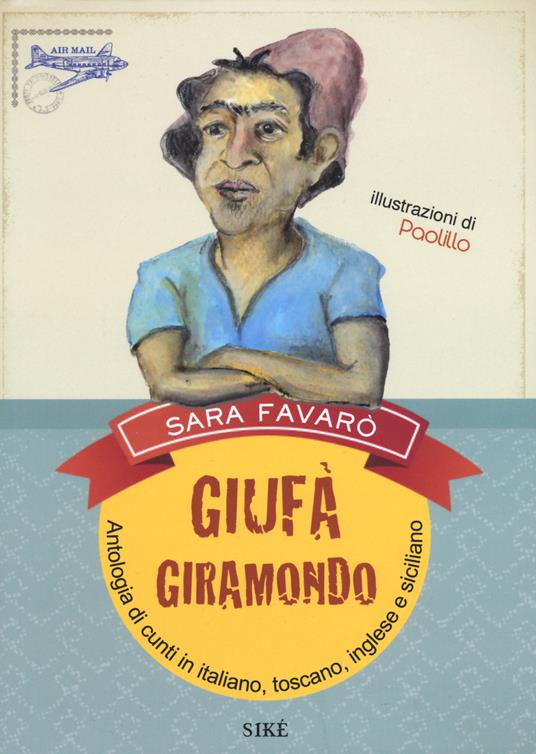“Montagna e società nella narrativa di Mauro Corona” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 13 Dicembre 2022
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1021
 Personaggio eccentrico, ma anima schietta, presente da qualche anno con scadenze regolari in Tv, Mauro Corona ha come temi conduttori di molte sue opere la Natura e la Montagna. Orchestrati secondo toni differenti, tali temi non smentiscono la sua biografia di ex ragazzo cresciuto fra i monti, di esperto e noto alpinista, di apprezzato intagliatore e scultore ligneo. L’autobiografismo, ora dissimulato, ora più esplicito, fa in genere da base o da filtro alla materia narrativa, che si misura con i problemi dell’attuale società capitalistica, consumistica, tecnologica, invasiva e divisiva, dialetticamente e polemicamente relazionata al mondo contadino e montanaro. Una materia che bene risponde agli umori della penna disinvolta e sempre acuta dello scrittore e che, nel persistere dell’orientamento ideologico, con il variare dei timbri ora fiabesco-evocativi, ora ironici e ferocemente satirici, ora ironico-divertiti pur nella icasticità delle punte satiriche, ora contemplativo-descrittivi o distaccato-riflessivi, marca di volta in volta l’originalità e l’anima “eversiva” della fabula. Polemica, estro inventivo, ammirate descrizioni paesaggistiche, nostalgici excursus etnografici (la festa del miele, il ninnanante, l’arte dei liutai e degli artigiani del legno) non mancano nel romanzo La voce degli uomini freddi (2013) che va letto come un apologo dolente sulle storture di uno sviluppo economico-tecnologico che arrogante e dispotico umilia la terra e gli individui, finché la terra stessa non si ribella: l’acqua torna sempre -dirà un vecchio dopo il “furto” del loro torrente- sfonda muri e montagne e passa, e il riferimento concreto è al disastro del Vajont del 1963. Opponendo al candido paradiso delle nevi (Era un paese di neve. Nevicava anche d’estate… nevicava sempre) e delle rocce calcaree friulane, simili nell’alba a spose novelle [uscite] fresche fresche dalla grande chiesa del creato, l’inferno delle pianure e delle città fumanti, dove ristagna una nebbia acre e grigia come aria di cenere, l’autore non fa che evocare, fra elegia e ammonimento, altre possibili ombre di morte e distruzione (quei fumi lenti e grassi…che ci mettevano anche un mese ad arrivare lassù, ma quando arrivavano gli abitanti delle terre estreme sentivano l’odore delle bolge/formicai), quale quella siglata dalla chiusa del libro: Eppure la neve cade ancora lassù, dove non c’è più nulla. Tra le pieghe di un narrare epico-fiabesco reso dal distanziamento temporale, dal computo ciclico degli anni, dall’iterazione di eventi, gesti, espressioni formulari e dalla schematicità stessa emblematica degli anonimi personaggi (la ragazza dagli occhi nocciola e i capelli autunnali, il giovane cercatore di cristalli, l’uomo a tre facce e la bella dagli occhi parlanti…), scorre nelle pagine la vicenda millenaria, dura e appartata, di una piccola comunità di montagna, “gli uomini freddi” appunto, modellati dalla fatica, dal dolore, dall’inclemenza degli elementi, dal silenzio (L’esistenza svuotava gli uomini dei monti pallidi rendendoli essenziali e pazienti nel loro quieto vivere), i quali saranno risucchiati inermi verso la catastrofe finale da uomini “rapaci” (alias imprenditori e politici spudorati) saliti dalle moderne meccanizzate “città fumanti” con un ex paesano che, trasferitosi giovanissimo nella città, ha tradito la sua terra, la sua gente, per arricchirsi, avere fama, e comandare sulle vite degli altri cinicamente e sanguinosamente. Tutti genia di “arraffatori” dalla cui mandibola (che è “la” mandibola umana) nessun luogo appare sicuro e rosicchia, rosicchia quella divora e distrugge la mela della bellezza e della pace, torsolo compreso. Dopo 10 secoli di tenace, quotidiana, lotta per la sopravvivenza in un territorio inospitale, ma reso produttivo, amabile e amato, dalla loro operosità (erano allenati e ciascuno sapeva cosa fare) e dal “lavorare in gruppo” come le api per il bene comune e la vita di quell’alveare sospeso sul mondo che era il villaggio, in tranquilla simbiosi con la Natura e paziente rassegnazione ai cicli di vita e di morte, quei miti montanari, umiliati come straccioni da “ladri di acqua e delinquenti”, defraudati del torrente deviato dalla diga, nella notte di un 9 ottobre, saranno cancellati con boschi, case, mulini, segherie da una immensa valanga di terra e di acqua (una montagna intera era scivolata dentro al lago artificiale…), un colossale lampo liquido che strappa la polpa della terra fino a lasciare solo ossa levigate e fango. Invece il nativo torrente era sempre stato il loro campo liquido, da loro custodito in ogni ansa, bonificato in ogni rampa perché era vita, come tutta l’acqua del mondo… Era lavoro, bellezza, pace. Scivolava via cantando… Quanto più Corona indugia sulla magia terribile e tenera del paesaggio montano, dalle bufere che grattano le porte con unghie d’acciaio al ghigno/artiglio delle valanghe, dai bagliori dei cristalli nelle grotte ai tepori del disgelo con i ruscelli arpe d’acqua che vibrano gracidano ridono frullano gonfiando pascoli, erbe, frutti; quanto più rimarca i canti della memoria intonati la sera dai vecchi e trasmessi ai giovani, e il loro prendere dalla terra e dalla selvaggina solo quello che serviva per campare, non un filo in più, tanto più risalta la violenza della spoliazione/saccheggio dell’ex paesano/uomo contemporaneo corrottosi in città a padrone temuto e spietato per il quale tutto è cinicamente comprabile, acqua fuoco terra neve e lo sarà pure l’aria -dice- che respirate. Andati a protestare con asce e coltelli contro scagnozzi armati di fucili e pistole, i montanari invano rivendicano che l’acqua è di tutti, non proprietà privata. Tutto ha un padrone prima o dopo- replica quello nella sua cecità e ferocia- non solo i cani. E nell’epilogo sarà solo il torrente (alias la Natura) che torna a cantare, mandando in giro la voce perduta degli uomini freddi che invece non esistono più. Allegoria fiabesca della condizione umana universale (Lassù viveva gente mite e essenziale che arrivava, durava e spariva in silenzio come la neve… uomini cioè consapevoli che campavano improvvisi e fragili come i fiocchi di neve che sempre li avvolgeva) e pamphlet “storico” sulla aberrante modernità (gli alveari del caos con le loro strabilianti invenzioni spesso non necessarie, dominio del superfluo e di “ladri” di acqua e di vite umane) questo romanzo trova i suoi naturali corollari nel precedente: La fine del mondo storto (2010) e nel successivo: La via del sole (2016). Il primo si impone ancora oggi con l’attualità di una riflessione radicale circa le fonti di approvvigionamento energetico. Riflessione rinforzata, fra provocazione e paradosso, dal piglio narrativo tipico dell’autore che insaporisce la scrittura qui con minori increspature di fiabesco “attualizzato” e maggiore invece umorosa espressività pregna di sferzante ironia e satira irosa. Le “punte” sono specificamente dirette ai politici, astutamente buoni a nulla e azzerati di spocchia dalla “morte bianca e nera”, loro che ai tempi delle vacche obese stavano saldamente “piazzati” fra i ricchi e in Tv, e a una umanità ostinata per imbecillità ad autoestinguersi (Adesso che sono all’estremo per propria colpa si pentono e si danno dei cretini). Trivelle gas petrolio mari Terra sono oggi questione globale di sviluppo e di civiltà, e Corona con fantasia apocalittica configura un punto limite per ricordare che il tesoro/Terra (alias agricoltura) nutre l’uomo, non l’industria (alias i soldi). Immagina perciò che per l’esaurirsi delle riserve terrestri di combustibili in una mattina d’inverno il mondo si sveglia senza petrolio, gas, carbone energia elettrica. E’ il panico planetario per la minaccia della morte totale data l’assenza irreversibile di tutto ciò che tiene in vita i motori e di conseguenza la gente che dipende dai motori. A secco di gasolio benzina gas erogazione elettrica, con auto camion treni aerei navi fabbriche macchinari vari fermi, e tv computer cellulari spenti, e con il vuotarsi progressivo di negozi supermarket magazzini, l’umanità tecnologica e civilizzata (leggi le società sviluppate e obese) cade nell’angoscia. Se molti si uccidono disperati, tutti gli altri fanno i conti con il freddo e la fame, costretti a buttare nel fuoco, per scaldarsi, ogni arredo libro quadro e a mangiare, per sfamarsi, l’immondizia e i morti. I tre quarti della popolazione mondiale muoiono e i sopravvissuti scoprono, specie quelli di città e i ricchi, l’inutilità del “superfluo” e dell’oro a soddisfare bisogni estremi e primari quali appunto scaldarsi e mangiare. Nel ribaltamento beffardo e vendicativo messo in atto dall’autore i ricchi precipitano a poveri senza soldi: le mazzette di banconote servono solo ad accendere il fuoco, ma è un “calore” fiacco e breve, i caveau delle banche diventano latrine (sic!) e vale più nella necessità un escremento di vacca per concimare la terra o produrre fuoco che cataste di oro. Sul pianeta maltrattato, avvelenato e svuotato per cavarvi più soldi e fra le macerie del “mondo storto” delle macchine, dello stress, del superlavoro, superimpegni, supersoldi, superchili, non resta per scampare alla morte collettiva che tornare all’uso delle mani, al maneggio dei vecchi attrezzi di lavoro (zappe vanghe falci) e al ri-apprendimento dei “saperi salvavita” di artigiani, montanari, contadini che insegnano ai “cittadini” a fare legna, impiantare un orto, andare a caccia, seminare i campi, allevare gli animali. La fine del mondo storto ridà valore e senso alle cose -rimarca Corona- che davvero hanno valore e senso, “essenziali” (termine chiave dell’autore) per campare: un fuoco, un pasto al giorno, un po’ di acqua, una coperta. Ora -insiste sferzante lo scrittore- sono tutti poveri e tutti barboni… prima avevano gola non fame (vedi ex sagre feste inaugurazioni banchetti pranzi di nozze cene di classe pranzi di fabbrica abbuffate pantagrueliche, o peggio, le tonnellate di arance al Sud e di pere e mele al Nord distrutte per non sfalsare le leggi del mercato. Perciò ai primi tepori primaverili si ritrovano tutti, contadini e ex magnati, professionisti, prelati, politici, in solidale pacifica concordia (ora se si vuole campare niente risse né colpi bassi) e senza capi e gerarchie inginocchiati (sic!) sulla terra a pulirla con le mani, aprirla, seminarla. E se pungenti ed esilaranti sono le sequenze dell’ex ministro dell’Agricoltura, che non sa come impugnare la vanga (prova sul fianco destro, poi sul sinistro) mentre il contadino gli “spiega” che il badile non è un politico, non si sposta da destra a sinistra, o viceversa, senza vergogna, o quella simile circa gli ex politici “del Lavoro” che non sanno fare niente di niente, incapaci nell’uso del più semplice attrezzo, mentre il contadino-insegnante li mette a infilare sementi nei buchi, profeticamente “liberatoria” appare la costrizione che l’angosciosa pressione della morte “bianca e nera” (formula ossessiva del libro) esercita nel fare mettere a coltura tutti i terreni abbandonati e ogni metro buono reperibile in città (aiuole terrazze giardini argini di fiumi campi sportivi scarpate di ferrovie, campi da golf…) per garantirsi tutti, il prossimo inverno e su scala ridotta al necessario (sic!), il bendidio semplice e naturale di verzure spighe, pannocchie che la Terra offre con dolcezza, finalmente riconciliatosi l’uomo naturale (libero dall’uomo artificiale) con acqua vento fuoco sole animali come ai primordi della creazione. E l’autore si attarda nella proiezione utopica a registrare che i cieli ormai sono diventati limpidi (liberi dalle tonnellate di veleni pompati dall’uomo), le stelle si vedono bene nelle notti senza luci e senza smog. Piovono stelle (dice fra scherzo e tenerezza) come mirtilli sulle città tranquille, gli uomini hanno imparato a vivere in pace, a collaborare, a stare uniti… Tutti padroni del mondo senza spartizioni di fette a uno o all’altro… Ma passata la paura della “tragedia planetaria” che, per tornaconto reciproco, ha costretto gli scampati alla amicizia e alla solidarietà, appena nei depositi comuni cominciano ad ammassarsi provviste e beni, rinasce il cruento furbesco egoismo del genere benpensante bipede (liti, risse, morti, fazioni, squadre armate, signorotti e relativi leccaculo) e l’uomo -conclude Corona- torna ad essere il coglione di sempre, avviando l’inizio di una nuova fine: finché non sparirà dal pianeta…ce la metterà tutta per farsi male e per star male. Pure La via del sole conferma la tipica affabulazione morale dello scrittore, che mischia ironia fantasia attualità in un ammiccante, compiaciuto, “gioco” narrativo, in cui sconforto civile e rabbia intellettuale alimentano la satira, aprendo talora la strada, come in questo libro nel passaggio dalle situazioni corali viste prima al protagonista unico (l’ingegnere che smantella montagne), a una più “diretta” confessione del cuore. Corona infatti si nasconde e si rivela nei suoi testi e qui più che altrove, complice al solito la montagna, paradiso-rifugio dell’anima e del corpo, quale doveva essere la radura a 1800 metri di altezza scelta dal protagonista ventinovenne in fuga dal mondo (Se mi ritiro in alta quota incontrerò meno cretini), circondata da punte di montagne belle e aguzze come mandorle intorno alla torta. Una montagna tuttavia anche moderno inferno di sfruttamento economico e abbruttimento, quale diventerà nel romanzo sotto i colpi della follia spazzamontagne e megalomane dell’ingegnere, ricco bello prestante, perno di una cordata di affaristi ghiotti quanto e più di lui. Il protagonista anonimo, più tipo che carattere, con le sue contraddizioni (sensibile e cinico, calcolatore ma anche problematico e riflessivo) simboleggia sia l’uomo “distorto” di oggi, distorto dal vincere, ottenere/possedere, che la “natura mortale” dell’essere umano, suo insuperabile limite Perciò la singolarità della fabula, con sviluppo lineare dai 29 anni iniziali del giovane alla sua morte a 69 per tumore (tumore proprio di minatori, cavatori di pietra, fumatori), ma tutta contenuta già nel cruccio del bimbo villeggiante sui monti circa la montagna che al tramonto gli rubava l’amico sole e nel desiderio/proposito sin da allora fanciullescamente concepito di tirarla via. Proposito che l’adulto, isolatosi come sopra detto in una baita-reggia-chalet per noia e nausea del mondo frenetico e feroce (nauseato e annoiato perché aveva tutto), concretizzerà con l’eliminazione progressiva anno dopo anno dei picchi dolomitici rompiscatole che cingono la radura della “sua” baita, incontentabile nel volere avere sempre più sole, luce, calore. Trascorso infatti il primo anno nell’isolamento, vivendo magici incredibili momenti diurni e notturni di contatto con la Natura, il maggio successivo l’ingegnere decide di eliminare il picco guastafeste che gli toglie un’ora di sole. Seguirà l’eliminazione di un secondo picco a oriente, ma le due ore di sole in più non lo “accontentano”: voleva di più. Voleva più sole sempre più. Il prolungato scempio distruttivo per “spianare la via del sole” sarà possibile per i soldi del padre e per la complicità prezzolata di politici corrotti e dei preposti proprio alla tutela dell’ambiente, prodighi di permessi (Gli uomini sono acquistabili. E’ solo questione di cifra… Il denaro compra tutto), e per la massa di interessi affari guadagni messi in moto dalle demolizioni e “sbudellamento” di boschi pascoli prati: vendita di ghiaia, piste da sci e impianti di risalita, alberghi-ristorante, commercio illegale di fossili… fino al successo turistico planetario come porta dell’inferno di una abissale mefitica foiba aperta casualmente dalle mine, dalla quale esalano nebbie giallognole dal forte odore di bruciato come fosse zolfo. Il noto inesorabile meccanismo denuncia lo scrittore per cui l’acqua pubblica oggi diventa “privata”, e si trivella il mare come il fondo di un secchio pieno d’acqua, e prosperano multinazionali, petrolieri, imprenditori di legname, guerrafondai… Da cosa nasceva cosa -sottolinea Corona- da misfatti crescevano soldi, quelli del padre e del figlio uniti nella malattia dei soldi, e il tutto nel silenzio della stampa, messa a tacere fra minacce, legnate, danaro, code di paglia al punto da presentare talora, seppur timidamente, gli smantellamenti come interventi essenziali, a beneficio dei popoli montanari o come opere nuove di grande valore tecnico-scientifico. Il protagonista (vedi i dialoghi con la vecchia guida alpina dell’infanzia, con l’omino rubizzo con binocolo e quaderni presente per anni nei luoghi dei misfatti, e con il vecchio scrittore cileno Francisco (sic!) suoi alter-ego positivi) sa bene di essere un “farabutto” che ha silenziato la coscienza e fa uso privato e scempio per soldi di beni comuni della Terra, ma si reputa (autoassolvendosi) un “dilettante” rispetto ai tanti sfrontati politici “acquistabili”, cinici e incapaci, o a chi “rosicchia” e avvelena nell’ombra la Natura, mentre lui è un demolitore “visibile” e un farabutto che confessa di esserlo. Un “dilettante” -sottolinea- anche rispetto a chi stermina con guerre genocidi lager odi razziali montagne di esseri umani. La via spianata del sole nasce dunque da tragiche radici storiche e esistenziali, ed è sostanzialmente una inquieta ricerca d libertà da tutto il negativo or ora elencato e dall’angoscia quotidiana di morte, che tutti ci portiamo dentro, ingegnere compreso. Da molti anni -dice- ormai viaggiamo verso il nulla. E proprio la morte con l’inestirpabile “montagna“ della malattia terminale riconduce il protagonista alla sua condizione mortale e alla vanità del vorace predare cose e persone. Tutti prima o poi roviniamo a terra gli aveva detto Francisco invitandolo alla umiltà, e nella clinica svizzera il “demolitore” riconosce di essere infine scivolato ai piedi della morte, lui che orgogliosamente aveva proclamato di non essere uomo da scendere, ma da salire, e confessa di avere, nella frenesia quotidiana della sua megalomane, egoistica, follia distruttrice, buttato la vita alle ortiche, non avendo goduto il sole che già aveva: troppo impegnato a volere di più, non ho avuto nulla. Donde il lascito dell’immenso patrimonio, quale estrema possibilità di riscatto, alla fondazione per malattie infantili guidata dall’omino pediatra, e l’accettazione/discesa finale nella propria (e collettiva) foiba della Morte, nella quale si inabissa volontariamente. In Quattro stagioni per vivere (2022) gli elementi autobiografici sottesi o utilizzati in ordine sparso nei romanzi già visti, vengono volutamente riorganizzati e volutamente “esibiti”: nella scelta del narrare in prima persona e in modo colloquiale, nella descrizione/nominazione puntuale di luoghi naturali e comunità cittadine del Friuli e del Trentino, nei riferimenti a suoi amici e/o famosi alpinisti, fondisti e olimpionici, nel rimando più diretto a ricordi ”privati” (il padre, il nonno) anche se trasposti nelle vicende del protagonista Osvaldo, nel quale però Corona scolpisce un parziale ritratto di sé, nei propri amori (alpinismo scultura scrittura), tendenziale selvatichezza e soprattutto nell’attuale “addomesticamento” del proprio sguardo, non più fustigatore e vendicativo, ma senile/commiserativo di errori e cecità sociali. Fra “riso” e “pietà” verso gli umani qui l’ago punta sulla pietà. Dei gemelli Legnole Osvaldo, qualificandoli, dirà: zero cervello per diventare migliori. La vicenda inventata in Quattro stagioni, pur nella pretesa di “realtà”, non è del tutto verosimile nel suo lungo protrarsi e quasi estenuarsi, perché soprattutto funzionale all’affabulazione naturalistica dell’autore, e l’idillio stesso d’amore finale fra scontate baruffe e riconciliazioni con l’energica e indipendente Consalba detta Furia rientra in facili topoi narrativi. Tuttavia la “storia” regge e non stanca il lettore, perché bene segnala quei significati “altri” che fanno del racconto un apologo morale e civile nel contrasto fra iI “negativo” incarnato nei gemelli Legnole, cacciatori e bevitori, che sono solo “istinto” senza logica, e la verità etica e esistenziale di Osvaldo per il quale per essere buoni bisogna essere intelligenti. Osvaldo, per soddisfare più presto il desiderio di brodo di camoscio della madre malata (che poi muore), ruba il camoscio appena ucciso e nascosto nella neve dai due gemelli che, respingendo ogni sua successiva offerta di scuse e risarcimento e richiesta di perdono e pacificazione, gli oppongono per mesi solo vendetta e minacce di morte, giocando con lui come il gatto col topo, spingendolo a fuggire nei boschi e di grotta in grotta. Le pagine del libro seguono questo “calvario”, che si protrae da un novembre all’altro novembre, e che vede da parte dei Legnole, brutti d’anima e d’aspetto (teste piccole, nasi grossi e schiacciati, labbro inferiore più sporgente di quello superiore, forza da tori e soprattutto teste/ciocco di legno) come azioni “d’offesa”, oltre a spari ripetuti, un tentativo di avvelenamento del cane di Osvaldo, Papo, l’esplosione di un sentiero di montagna, due valanghe provocate per assassinare il nemico restando “puliti”, l’incendio della casa dell’amico di Osvaldo, Guido, che muore soffocato dal fumo, e da parte del protagonista, che pur avendone l’abilità si rifiuta di ammazzarli per un camoscio, solo azioni “difensive” di fronteggiamento intimidatorio e due beffe (il furto di un altro camoscio e di due fucili, e l’esplosione della latrina di quelli che smerda tutta la loro casa e le loro facce). La ferocia insensata dei Legnole (erano loro “padroni” l’alcol, l’ignoranza, l’analfabetismo idiota) fa da occasione/pretesto per lo scrittore alla rappresentazione di un ritrovato e più sano rapporto con la Natura che ora il protagonista ha il tempo si studiare a fondo: Dovevo ai Legnole -dice Osvaldo in fuga- alla loro ottusa ferocia, alla brutale ignoranza la scoperta di una vita nuova. Vivevo la dolcezza bellezza e durezza di esistere in mezzo alla natura come un camoscio, un larice nel vento, una lepre sotto la neve”. Scopre il fuggitivo che le montagne lo proteggono: Ho dormito accanto al fuoco in compagnia della nebbia, di una ragnatela e del silenzio profondo della montagna. La pace della Natura familiarizzata lo fascia come un vestito nuovo, la spelonca lo accoglie come un ventre materno, la bellezza naturale lo incanta anche nei mesi invernali: la moneta d’oro della luna, le stelle gocce di rugiada congelate, il fievole brusio dei fiocchi di neve, il puff come un “respiro” della neve che cade dai rami carichi, le braccia ibernate degli alberi che paiono vibrare sotto l’arco di un misterioso violinista, lo stiracchiarsi possente delle membra della Natura nel rombo delle slavine, i monti innevati e i pendii che ardono di luce nei tramonti come lenzuola andate a fuoco, il vento che raspa le cime, la coperta di inchiostro nero della notte punteggiata di stelle, la candela azzurra di una cima ghiacciata che pare un cero colossale con la fiamma di luna. Osvaldo è braccato dai gemelli Legnole ma si sente l’uomo più libero del mondo imprigionato nella cella più aperta pulita vasta splendida che si possa immaginare. Perciò osserva ogni particolare, ascolta battere il cuore segreto della terra e capisce che nella vita non è importante fare grandi cose, ma godere delle cose belle che sono semplici e a portata di mano. Comprende cosa [sono] un albero, la neve, gli animali, i suoni, gli odori, le erbe e l’acqua… Tutto regalato dalla natura che non chiede nulla, soltanto un po’ di rispetto e di protezione. Muovendosi tra tecniche necessarie di sopravvivenza (fuoco sapientemente alimentato, selvaggina procurata con meno avidità, solo il giusto, lo stretto necessario, resina di larice per le contusioni, pietre particolari di fiume e torrenti per affilare il coltello, scorze commestibili di mughi abeti bianchi aceri pecci per ricavarne un liquido oleoso buono e energetico, acqua buona che salta fuori dal ghiaccio spaccato…) e contemplazione grata e ammirata della bellezza e generosità della Natura (uno scrigno che avevo [prima] solo sfruttato, dal quale avevo solo preteso sottratto rubato) nel mutare delle stagioni (il canto del disgelo, le tiepide notti estive, il pennello malinconico dell’autunno), sperimenta Osvaldo nella solitudine e nel silenzio anche la compagnia amica dei versi degli animali selvatici (corvi imperiali, gufi reali, ciuffolotti, picchio, civette, barbagianni, camosci, cervi, caprioli, volpi, martore, galli forcelli, cedroni…). E torna a riflettere che grazie alla spietatezza dei Legnole ha aperto gli occhi sulla vera vita che non è noi di qua, le bestie di là, la natura intorno e l’uomo padrone. No. La vita è, o dovrebbe essere tutt’uno con animali, boschi, montagne, nell’armonia delle stagioni e con il prossimo. Una armonia vitale duplice dunque, e emozioni positive, nelle quali alla fine Osvaldo si reintegra lasciando l’acido e sinistro paese natale, dove metà degli abitanti non parlava con l’altra metà per antiche ruggini, andando ad abitare fra Misurina e Sappada, dove nel suo peregrinare estivo ha trovato, dopo mesi di isolamento, calore e “voci” di amici nuovi veri leali affidabili, case/nidi di legno che fungevano da vasi per fiori di ogni sorta, prati curati come vasi di fiori, e soprattutto gente pulita levigata dall’aria [montana] che tornisce corpi e anime rendendoli essenziali (sic!) e la donna “alba” della sua nuova vita, alba tardiva ma limpida e raggiante. I Legnole invece, rimasti cervelli primitivi senza speranza di sviluppo, e vite sbagliate, barbare, ottuse sprecate nella rabbia e nell’odio, si autodistruggeranno da soli: Gildo paralizzato dalla fucilata del fratello, che lo ha colto in amore con la sua donna, si suiciderà, e Gianco si impiccherà in carcere, liberi finalmente entrambi -suggerisce l’autore compassionandoli- da se stessi!
Personaggio eccentrico, ma anima schietta, presente da qualche anno con scadenze regolari in Tv, Mauro Corona ha come temi conduttori di molte sue opere la Natura e la Montagna. Orchestrati secondo toni differenti, tali temi non smentiscono la sua biografia di ex ragazzo cresciuto fra i monti, di esperto e noto alpinista, di apprezzato intagliatore e scultore ligneo. L’autobiografismo, ora dissimulato, ora più esplicito, fa in genere da base o da filtro alla materia narrativa, che si misura con i problemi dell’attuale società capitalistica, consumistica, tecnologica, invasiva e divisiva, dialetticamente e polemicamente relazionata al mondo contadino e montanaro. Una materia che bene risponde agli umori della penna disinvolta e sempre acuta dello scrittore e che, nel persistere dell’orientamento ideologico, con il variare dei timbri ora fiabesco-evocativi, ora ironici e ferocemente satirici, ora ironico-divertiti pur nella icasticità delle punte satiriche, ora contemplativo-descrittivi o distaccato-riflessivi, marca di volta in volta l’originalità e l’anima “eversiva” della fabula. Polemica, estro inventivo, ammirate descrizioni paesaggistiche, nostalgici excursus etnografici (la festa del miele, il ninnanante, l’arte dei liutai e degli artigiani del legno) non mancano nel romanzo La voce degli uomini freddi (2013) che va letto come un apologo dolente sulle storture di uno sviluppo economico-tecnologico che arrogante e dispotico umilia la terra e gli individui, finché la terra stessa non si ribella: l’acqua torna sempre -dirà un vecchio dopo il “furto” del loro torrente- sfonda muri e montagne e passa, e il riferimento concreto è al disastro del Vajont del 1963. Opponendo al candido paradiso delle nevi (Era un paese di neve. Nevicava anche d’estate… nevicava sempre) e delle rocce calcaree friulane, simili nell’alba a spose novelle [uscite] fresche fresche dalla grande chiesa del creato, l’inferno delle pianure e delle città fumanti, dove ristagna una nebbia acre e grigia come aria di cenere, l’autore non fa che evocare, fra elegia e ammonimento, altre possibili ombre di morte e distruzione (quei fumi lenti e grassi…che ci mettevano anche un mese ad arrivare lassù, ma quando arrivavano gli abitanti delle terre estreme sentivano l’odore delle bolge/formicai), quale quella siglata dalla chiusa del libro: Eppure la neve cade ancora lassù, dove non c’è più nulla. Tra le pieghe di un narrare epico-fiabesco reso dal distanziamento temporale, dal computo ciclico degli anni, dall’iterazione di eventi, gesti, espressioni formulari e dalla schematicità stessa emblematica degli anonimi personaggi (la ragazza dagli occhi nocciola e i capelli autunnali, il giovane cercatore di cristalli, l’uomo a tre facce e la bella dagli occhi parlanti…), scorre nelle pagine la vicenda millenaria, dura e appartata, di una piccola comunità di montagna, “gli uomini freddi” appunto, modellati dalla fatica, dal dolore, dall’inclemenza degli elementi, dal silenzio (L’esistenza svuotava gli uomini dei monti pallidi rendendoli essenziali e pazienti nel loro quieto vivere), i quali saranno risucchiati inermi verso la catastrofe finale da uomini “rapaci” (alias imprenditori e politici spudorati) saliti dalle moderne meccanizzate “città fumanti” con un ex paesano che, trasferitosi giovanissimo nella città, ha tradito la sua terra, la sua gente, per arricchirsi, avere fama, e comandare sulle vite degli altri cinicamente e sanguinosamente. Tutti genia di “arraffatori” dalla cui mandibola (che è “la” mandibola umana) nessun luogo appare sicuro e rosicchia, rosicchia quella divora e distrugge la mela della bellezza e della pace, torsolo compreso. Dopo 10 secoli di tenace, quotidiana, lotta per la sopravvivenza in un territorio inospitale, ma reso produttivo, amabile e amato, dalla loro operosità (erano allenati e ciascuno sapeva cosa fare) e dal “lavorare in gruppo” come le api per il bene comune e la vita di quell’alveare sospeso sul mondo che era il villaggio, in tranquilla simbiosi con la Natura e paziente rassegnazione ai cicli di vita e di morte, quei miti montanari, umiliati come straccioni da “ladri di acqua e delinquenti”, defraudati del torrente deviato dalla diga, nella notte di un 9 ottobre, saranno cancellati con boschi, case, mulini, segherie da una immensa valanga di terra e di acqua (una montagna intera era scivolata dentro al lago artificiale…), un colossale lampo liquido che strappa la polpa della terra fino a lasciare solo ossa levigate e fango. Invece il nativo torrente era sempre stato il loro campo liquido, da loro custodito in ogni ansa, bonificato in ogni rampa perché era vita, come tutta l’acqua del mondo… Era lavoro, bellezza, pace. Scivolava via cantando… Quanto più Corona indugia sulla magia terribile e tenera del paesaggio montano, dalle bufere che grattano le porte con unghie d’acciaio al ghigno/artiglio delle valanghe, dai bagliori dei cristalli nelle grotte ai tepori del disgelo con i ruscelli arpe d’acqua che vibrano gracidano ridono frullano gonfiando pascoli, erbe, frutti; quanto più rimarca i canti della memoria intonati la sera dai vecchi e trasmessi ai giovani, e il loro prendere dalla terra e dalla selvaggina solo quello che serviva per campare, non un filo in più, tanto più risalta la violenza della spoliazione/saccheggio dell’ex paesano/uomo contemporaneo corrottosi in città a padrone temuto e spietato per il quale tutto è cinicamente comprabile, acqua fuoco terra neve e lo sarà pure l’aria -dice- che respirate. Andati a protestare con asce e coltelli contro scagnozzi armati di fucili e pistole, i montanari invano rivendicano che l’acqua è di tutti, non proprietà privata. Tutto ha un padrone prima o dopo- replica quello nella sua cecità e ferocia- non solo i cani. E nell’epilogo sarà solo il torrente (alias la Natura) che torna a cantare, mandando in giro la voce perduta degli uomini freddi che invece non esistono più. Allegoria fiabesca della condizione umana universale (Lassù viveva gente mite e essenziale che arrivava, durava e spariva in silenzio come la neve… uomini cioè consapevoli che campavano improvvisi e fragili come i fiocchi di neve che sempre li avvolgeva) e pamphlet “storico” sulla aberrante modernità (gli alveari del caos con le loro strabilianti invenzioni spesso non necessarie, dominio del superfluo e di “ladri” di acqua e di vite umane) questo romanzo trova i suoi naturali corollari nel precedente: La fine del mondo storto (2010) e nel successivo: La via del sole (2016). Il primo si impone ancora oggi con l’attualità di una riflessione radicale circa le fonti di approvvigionamento energetico. Riflessione rinforzata, fra provocazione e paradosso, dal piglio narrativo tipico dell’autore che insaporisce la scrittura qui con minori increspature di fiabesco “attualizzato” e maggiore invece umorosa espressività pregna di sferzante ironia e satira irosa. Le “punte” sono specificamente dirette ai politici, astutamente buoni a nulla e azzerati di spocchia dalla “morte bianca e nera”, loro che ai tempi delle vacche obese stavano saldamente “piazzati” fra i ricchi e in Tv, e a una umanità ostinata per imbecillità ad autoestinguersi (Adesso che sono all’estremo per propria colpa si pentono e si danno dei cretini). Trivelle gas petrolio mari Terra sono oggi questione globale di sviluppo e di civiltà, e Corona con fantasia apocalittica configura un punto limite per ricordare che il tesoro/Terra (alias agricoltura) nutre l’uomo, non l’industria (alias i soldi). Immagina perciò che per l’esaurirsi delle riserve terrestri di combustibili in una mattina d’inverno il mondo si sveglia senza petrolio, gas, carbone energia elettrica. E’ il panico planetario per la minaccia della morte totale data l’assenza irreversibile di tutto ciò che tiene in vita i motori e di conseguenza la gente che dipende dai motori. A secco di gasolio benzina gas erogazione elettrica, con auto camion treni aerei navi fabbriche macchinari vari fermi, e tv computer cellulari spenti, e con il vuotarsi progressivo di negozi supermarket magazzini, l’umanità tecnologica e civilizzata (leggi le società sviluppate e obese) cade nell’angoscia. Se molti si uccidono disperati, tutti gli altri fanno i conti con il freddo e la fame, costretti a buttare nel fuoco, per scaldarsi, ogni arredo libro quadro e a mangiare, per sfamarsi, l’immondizia e i morti. I tre quarti della popolazione mondiale muoiono e i sopravvissuti scoprono, specie quelli di città e i ricchi, l’inutilità del “superfluo” e dell’oro a soddisfare bisogni estremi e primari quali appunto scaldarsi e mangiare. Nel ribaltamento beffardo e vendicativo messo in atto dall’autore i ricchi precipitano a poveri senza soldi: le mazzette di banconote servono solo ad accendere il fuoco, ma è un “calore” fiacco e breve, i caveau delle banche diventano latrine (sic!) e vale più nella necessità un escremento di vacca per concimare la terra o produrre fuoco che cataste di oro. Sul pianeta maltrattato, avvelenato e svuotato per cavarvi più soldi e fra le macerie del “mondo storto” delle macchine, dello stress, del superlavoro, superimpegni, supersoldi, superchili, non resta per scampare alla morte collettiva che tornare all’uso delle mani, al maneggio dei vecchi attrezzi di lavoro (zappe vanghe falci) e al ri-apprendimento dei “saperi salvavita” di artigiani, montanari, contadini che insegnano ai “cittadini” a fare legna, impiantare un orto, andare a caccia, seminare i campi, allevare gli animali. La fine del mondo storto ridà valore e senso alle cose -rimarca Corona- che davvero hanno valore e senso, “essenziali” (termine chiave dell’autore) per campare: un fuoco, un pasto al giorno, un po’ di acqua, una coperta. Ora -insiste sferzante lo scrittore- sono tutti poveri e tutti barboni… prima avevano gola non fame (vedi ex sagre feste inaugurazioni banchetti pranzi di nozze cene di classe pranzi di fabbrica abbuffate pantagrueliche, o peggio, le tonnellate di arance al Sud e di pere e mele al Nord distrutte per non sfalsare le leggi del mercato. Perciò ai primi tepori primaverili si ritrovano tutti, contadini e ex magnati, professionisti, prelati, politici, in solidale pacifica concordia (ora se si vuole campare niente risse né colpi bassi) e senza capi e gerarchie inginocchiati (sic!) sulla terra a pulirla con le mani, aprirla, seminarla. E se pungenti ed esilaranti sono le sequenze dell’ex ministro dell’Agricoltura, che non sa come impugnare la vanga (prova sul fianco destro, poi sul sinistro) mentre il contadino gli “spiega” che il badile non è un politico, non si sposta da destra a sinistra, o viceversa, senza vergogna, o quella simile circa gli ex politici “del Lavoro” che non sanno fare niente di niente, incapaci nell’uso del più semplice attrezzo, mentre il contadino-insegnante li mette a infilare sementi nei buchi, profeticamente “liberatoria” appare la costrizione che l’angosciosa pressione della morte “bianca e nera” (formula ossessiva del libro) esercita nel fare mettere a coltura tutti i terreni abbandonati e ogni metro buono reperibile in città (aiuole terrazze giardini argini di fiumi campi sportivi scarpate di ferrovie, campi da golf…) per garantirsi tutti, il prossimo inverno e su scala ridotta al necessario (sic!), il bendidio semplice e naturale di verzure spighe, pannocchie che la Terra offre con dolcezza, finalmente riconciliatosi l’uomo naturale (libero dall’uomo artificiale) con acqua vento fuoco sole animali come ai primordi della creazione. E l’autore si attarda nella proiezione utopica a registrare che i cieli ormai sono diventati limpidi (liberi dalle tonnellate di veleni pompati dall’uomo), le stelle si vedono bene nelle notti senza luci e senza smog. Piovono stelle (dice fra scherzo e tenerezza) come mirtilli sulle città tranquille, gli uomini hanno imparato a vivere in pace, a collaborare, a stare uniti… Tutti padroni del mondo senza spartizioni di fette a uno o all’altro… Ma passata la paura della “tragedia planetaria” che, per tornaconto reciproco, ha costretto gli scampati alla amicizia e alla solidarietà, appena nei depositi comuni cominciano ad ammassarsi provviste e beni, rinasce il cruento furbesco egoismo del genere benpensante bipede (liti, risse, morti, fazioni, squadre armate, signorotti e relativi leccaculo) e l’uomo -conclude Corona- torna ad essere il coglione di sempre, avviando l’inizio di una nuova fine: finché non sparirà dal pianeta…ce la metterà tutta per farsi male e per star male. Pure La via del sole conferma la tipica affabulazione morale dello scrittore, che mischia ironia fantasia attualità in un ammiccante, compiaciuto, “gioco” narrativo, in cui sconforto civile e rabbia intellettuale alimentano la satira, aprendo talora la strada, come in questo libro nel passaggio dalle situazioni corali viste prima al protagonista unico (l’ingegnere che smantella montagne), a una più “diretta” confessione del cuore. Corona infatti si nasconde e si rivela nei suoi testi e qui più che altrove, complice al solito la montagna, paradiso-rifugio dell’anima e del corpo, quale doveva essere la radura a 1800 metri di altezza scelta dal protagonista ventinovenne in fuga dal mondo (Se mi ritiro in alta quota incontrerò meno cretini), circondata da punte di montagne belle e aguzze come mandorle intorno alla torta. Una montagna tuttavia anche moderno inferno di sfruttamento economico e abbruttimento, quale diventerà nel romanzo sotto i colpi della follia spazzamontagne e megalomane dell’ingegnere, ricco bello prestante, perno di una cordata di affaristi ghiotti quanto e più di lui. Il protagonista anonimo, più tipo che carattere, con le sue contraddizioni (sensibile e cinico, calcolatore ma anche problematico e riflessivo) simboleggia sia l’uomo “distorto” di oggi, distorto dal vincere, ottenere/possedere, che la “natura mortale” dell’essere umano, suo insuperabile limite Perciò la singolarità della fabula, con sviluppo lineare dai 29 anni iniziali del giovane alla sua morte a 69 per tumore (tumore proprio di minatori, cavatori di pietra, fumatori), ma tutta contenuta già nel cruccio del bimbo villeggiante sui monti circa la montagna che al tramonto gli rubava l’amico sole e nel desiderio/proposito sin da allora fanciullescamente concepito di tirarla via. Proposito che l’adulto, isolatosi come sopra detto in una baita-reggia-chalet per noia e nausea del mondo frenetico e feroce (nauseato e annoiato perché aveva tutto), concretizzerà con l’eliminazione progressiva anno dopo anno dei picchi dolomitici rompiscatole che cingono la radura della “sua” baita, incontentabile nel volere avere sempre più sole, luce, calore. Trascorso infatti il primo anno nell’isolamento, vivendo magici incredibili momenti diurni e notturni di contatto con la Natura, il maggio successivo l’ingegnere decide di eliminare il picco guastafeste che gli toglie un’ora di sole. Seguirà l’eliminazione di un secondo picco a oriente, ma le due ore di sole in più non lo “accontentano”: voleva di più. Voleva più sole sempre più. Il prolungato scempio distruttivo per “spianare la via del sole” sarà possibile per i soldi del padre e per la complicità prezzolata di politici corrotti e dei preposti proprio alla tutela dell’ambiente, prodighi di permessi (Gli uomini sono acquistabili. E’ solo questione di cifra… Il denaro compra tutto), e per la massa di interessi affari guadagni messi in moto dalle demolizioni e “sbudellamento” di boschi pascoli prati: vendita di ghiaia, piste da sci e impianti di risalita, alberghi-ristorante, commercio illegale di fossili… fino al successo turistico planetario come porta dell’inferno di una abissale mefitica foiba aperta casualmente dalle mine, dalla quale esalano nebbie giallognole dal forte odore di bruciato come fosse zolfo. Il noto inesorabile meccanismo denuncia lo scrittore per cui l’acqua pubblica oggi diventa “privata”, e si trivella il mare come il fondo di un secchio pieno d’acqua, e prosperano multinazionali, petrolieri, imprenditori di legname, guerrafondai… Da cosa nasceva cosa -sottolinea Corona- da misfatti crescevano soldi, quelli del padre e del figlio uniti nella malattia dei soldi, e il tutto nel silenzio della stampa, messa a tacere fra minacce, legnate, danaro, code di paglia al punto da presentare talora, seppur timidamente, gli smantellamenti come interventi essenziali, a beneficio dei popoli montanari o come opere nuove di grande valore tecnico-scientifico. Il protagonista (vedi i dialoghi con la vecchia guida alpina dell’infanzia, con l’omino rubizzo con binocolo e quaderni presente per anni nei luoghi dei misfatti, e con il vecchio scrittore cileno Francisco (sic!) suoi alter-ego positivi) sa bene di essere un “farabutto” che ha silenziato la coscienza e fa uso privato e scempio per soldi di beni comuni della Terra, ma si reputa (autoassolvendosi) un “dilettante” rispetto ai tanti sfrontati politici “acquistabili”, cinici e incapaci, o a chi “rosicchia” e avvelena nell’ombra la Natura, mentre lui è un demolitore “visibile” e un farabutto che confessa di esserlo. Un “dilettante” -sottolinea- anche rispetto a chi stermina con guerre genocidi lager odi razziali montagne di esseri umani. La via spianata del sole nasce dunque da tragiche radici storiche e esistenziali, ed è sostanzialmente una inquieta ricerca d libertà da tutto il negativo or ora elencato e dall’angoscia quotidiana di morte, che tutti ci portiamo dentro, ingegnere compreso. Da molti anni -dice- ormai viaggiamo verso il nulla. E proprio la morte con l’inestirpabile “montagna“ della malattia terminale riconduce il protagonista alla sua condizione mortale e alla vanità del vorace predare cose e persone. Tutti prima o poi roviniamo a terra gli aveva detto Francisco invitandolo alla umiltà, e nella clinica svizzera il “demolitore” riconosce di essere infine scivolato ai piedi della morte, lui che orgogliosamente aveva proclamato di non essere uomo da scendere, ma da salire, e confessa di avere, nella frenesia quotidiana della sua megalomane, egoistica, follia distruttrice, buttato la vita alle ortiche, non avendo goduto il sole che già aveva: troppo impegnato a volere di più, non ho avuto nulla. Donde il lascito dell’immenso patrimonio, quale estrema possibilità di riscatto, alla fondazione per malattie infantili guidata dall’omino pediatra, e l’accettazione/discesa finale nella propria (e collettiva) foiba della Morte, nella quale si inabissa volontariamente. In Quattro stagioni per vivere (2022) gli elementi autobiografici sottesi o utilizzati in ordine sparso nei romanzi già visti, vengono volutamente riorganizzati e volutamente “esibiti”: nella scelta del narrare in prima persona e in modo colloquiale, nella descrizione/nominazione puntuale di luoghi naturali e comunità cittadine del Friuli e del Trentino, nei riferimenti a suoi amici e/o famosi alpinisti, fondisti e olimpionici, nel rimando più diretto a ricordi ”privati” (il padre, il nonno) anche se trasposti nelle vicende del protagonista Osvaldo, nel quale però Corona scolpisce un parziale ritratto di sé, nei propri amori (alpinismo scultura scrittura), tendenziale selvatichezza e soprattutto nell’attuale “addomesticamento” del proprio sguardo, non più fustigatore e vendicativo, ma senile/commiserativo di errori e cecità sociali. Fra “riso” e “pietà” verso gli umani qui l’ago punta sulla pietà. Dei gemelli Legnole Osvaldo, qualificandoli, dirà: zero cervello per diventare migliori. La vicenda inventata in Quattro stagioni, pur nella pretesa di “realtà”, non è del tutto verosimile nel suo lungo protrarsi e quasi estenuarsi, perché soprattutto funzionale all’affabulazione naturalistica dell’autore, e l’idillio stesso d’amore finale fra scontate baruffe e riconciliazioni con l’energica e indipendente Consalba detta Furia rientra in facili topoi narrativi. Tuttavia la “storia” regge e non stanca il lettore, perché bene segnala quei significati “altri” che fanno del racconto un apologo morale e civile nel contrasto fra iI “negativo” incarnato nei gemelli Legnole, cacciatori e bevitori, che sono solo “istinto” senza logica, e la verità etica e esistenziale di Osvaldo per il quale per essere buoni bisogna essere intelligenti. Osvaldo, per soddisfare più presto il desiderio di brodo di camoscio della madre malata (che poi muore), ruba il camoscio appena ucciso e nascosto nella neve dai due gemelli che, respingendo ogni sua successiva offerta di scuse e risarcimento e richiesta di perdono e pacificazione, gli oppongono per mesi solo vendetta e minacce di morte, giocando con lui come il gatto col topo, spingendolo a fuggire nei boschi e di grotta in grotta. Le pagine del libro seguono questo “calvario”, che si protrae da un novembre all’altro novembre, e che vede da parte dei Legnole, brutti d’anima e d’aspetto (teste piccole, nasi grossi e schiacciati, labbro inferiore più sporgente di quello superiore, forza da tori e soprattutto teste/ciocco di legno) come azioni “d’offesa”, oltre a spari ripetuti, un tentativo di avvelenamento del cane di Osvaldo, Papo, l’esplosione di un sentiero di montagna, due valanghe provocate per assassinare il nemico restando “puliti”, l’incendio della casa dell’amico di Osvaldo, Guido, che muore soffocato dal fumo, e da parte del protagonista, che pur avendone l’abilità si rifiuta di ammazzarli per un camoscio, solo azioni “difensive” di fronteggiamento intimidatorio e due beffe (il furto di un altro camoscio e di due fucili, e l’esplosione della latrina di quelli che smerda tutta la loro casa e le loro facce). La ferocia insensata dei Legnole (erano loro “padroni” l’alcol, l’ignoranza, l’analfabetismo idiota) fa da occasione/pretesto per lo scrittore alla rappresentazione di un ritrovato e più sano rapporto con la Natura che ora il protagonista ha il tempo si studiare a fondo: Dovevo ai Legnole -dice Osvaldo in fuga- alla loro ottusa ferocia, alla brutale ignoranza la scoperta di una vita nuova. Vivevo la dolcezza bellezza e durezza di esistere in mezzo alla natura come un camoscio, un larice nel vento, una lepre sotto la neve”. Scopre il fuggitivo che le montagne lo proteggono: Ho dormito accanto al fuoco in compagnia della nebbia, di una ragnatela e del silenzio profondo della montagna. La pace della Natura familiarizzata lo fascia come un vestito nuovo, la spelonca lo accoglie come un ventre materno, la bellezza naturale lo incanta anche nei mesi invernali: la moneta d’oro della luna, le stelle gocce di rugiada congelate, il fievole brusio dei fiocchi di neve, il puff come un “respiro” della neve che cade dai rami carichi, le braccia ibernate degli alberi che paiono vibrare sotto l’arco di un misterioso violinista, lo stiracchiarsi possente delle membra della Natura nel rombo delle slavine, i monti innevati e i pendii che ardono di luce nei tramonti come lenzuola andate a fuoco, il vento che raspa le cime, la coperta di inchiostro nero della notte punteggiata di stelle, la candela azzurra di una cima ghiacciata che pare un cero colossale con la fiamma di luna. Osvaldo è braccato dai gemelli Legnole ma si sente l’uomo più libero del mondo imprigionato nella cella più aperta pulita vasta splendida che si possa immaginare. Perciò osserva ogni particolare, ascolta battere il cuore segreto della terra e capisce che nella vita non è importante fare grandi cose, ma godere delle cose belle che sono semplici e a portata di mano. Comprende cosa [sono] un albero, la neve, gli animali, i suoni, gli odori, le erbe e l’acqua… Tutto regalato dalla natura che non chiede nulla, soltanto un po’ di rispetto e di protezione. Muovendosi tra tecniche necessarie di sopravvivenza (fuoco sapientemente alimentato, selvaggina procurata con meno avidità, solo il giusto, lo stretto necessario, resina di larice per le contusioni, pietre particolari di fiume e torrenti per affilare il coltello, scorze commestibili di mughi abeti bianchi aceri pecci per ricavarne un liquido oleoso buono e energetico, acqua buona che salta fuori dal ghiaccio spaccato…) e contemplazione grata e ammirata della bellezza e generosità della Natura (uno scrigno che avevo [prima] solo sfruttato, dal quale avevo solo preteso sottratto rubato) nel mutare delle stagioni (il canto del disgelo, le tiepide notti estive, il pennello malinconico dell’autunno), sperimenta Osvaldo nella solitudine e nel silenzio anche la compagnia amica dei versi degli animali selvatici (corvi imperiali, gufi reali, ciuffolotti, picchio, civette, barbagianni, camosci, cervi, caprioli, volpi, martore, galli forcelli, cedroni…). E torna a riflettere che grazie alla spietatezza dei Legnole ha aperto gli occhi sulla vera vita che non è noi di qua, le bestie di là, la natura intorno e l’uomo padrone. No. La vita è, o dovrebbe essere tutt’uno con animali, boschi, montagne, nell’armonia delle stagioni e con il prossimo. Una armonia vitale duplice dunque, e emozioni positive, nelle quali alla fine Osvaldo si reintegra lasciando l’acido e sinistro paese natale, dove metà degli abitanti non parlava con l’altra metà per antiche ruggini, andando ad abitare fra Misurina e Sappada, dove nel suo peregrinare estivo ha trovato, dopo mesi di isolamento, calore e “voci” di amici nuovi veri leali affidabili, case/nidi di legno che fungevano da vasi per fiori di ogni sorta, prati curati come vasi di fiori, e soprattutto gente pulita levigata dall’aria [montana] che tornisce corpi e anime rendendoli essenziali (sic!) e la donna “alba” della sua nuova vita, alba tardiva ma limpida e raggiante. I Legnole invece, rimasti cervelli primitivi senza speranza di sviluppo, e vite sbagliate, barbare, ottuse sprecate nella rabbia e nell’odio, si autodistruggeranno da soli: Gildo paralizzato dalla fucilata del fratello, che lo ha colto in amore con la sua donna, si suiciderà, e Gianco si impiccherà in carcere, liberi finalmente entrambi -suggerisce l’autore compassionandoli- da se stessi!