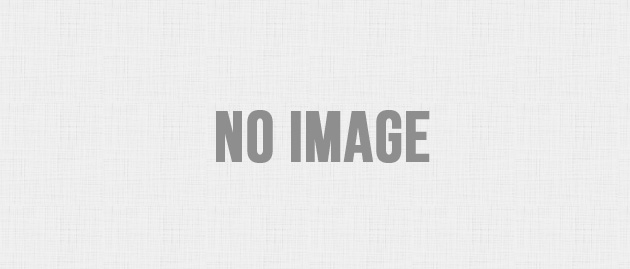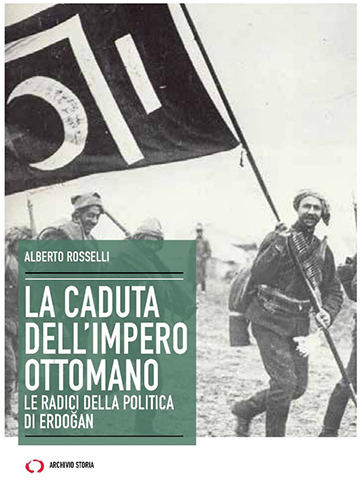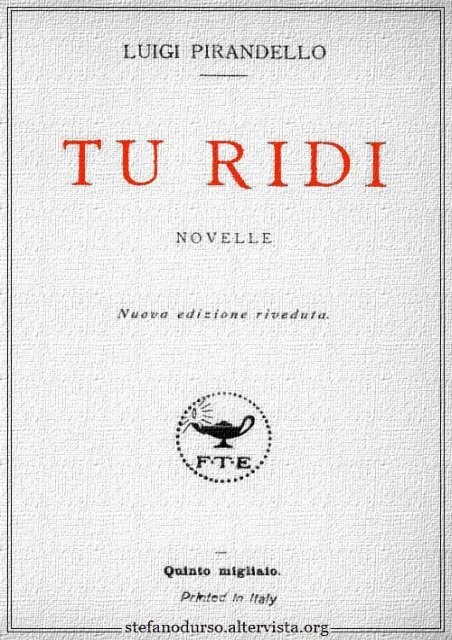Massimo Recalcati e “la legge del desiderio” – di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 15 Aprile 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 855
 Nei libri di Massimo Recalcati torna con particolare insistenza l’attenzione al “processo di soggettivazione” che, vincolando -secondo il pensiero di J. Lacan- il divenire del soggetto all’istanza irriducibile del suo desiderio inteso come vocazione/dovere, lo “costituisce” nella sua irripetibile singolarità e ne fa “l’incarnazione” della Legge del desiderio. Tale tematica appare un tratto “compulsivo” della personalità e della scrittura dell’autore, una sorta di “coazione a ripetere”, che affonda le radici nel tormentato percorso esistenziale e di formazione di Recalcati stesso, come emerge dai volumi A libro aperto e La luce delle stelle morte. Usata quale sfondo teorico e strumento di interpretazione, tale tematica è originalmente presente pure in La legge della parola, dove la psicoanalisi “dialoga” con episodi e figure dell’Antico Testamento, e nel più recente La legge del desiderio fa da filo conduttore alla rilettura laica e in chiave umana della figura di Gesù (più “uomo” appunto che “il figlio di Dio”) in acrobatico equilibrismo fra sponda dei credenti, sponda lacaniana-recalcatiana e risvolti esperenziali della quotidianità. Scrive Recalcati che per Gesù, che desidera e ama la vita, e non condivide di Qohelet l’idea che il giorno della morte sia preferibile a quello del nascere, il desiderio non è -come per Qohelet- solo “vanità, vacuità”, aspirazione sempre frustrata, ma anche potenza affermativa, capacità generativa… fattore di apertura della vita e di moltiplicazione dei suoi talenti, espressione radicale della sua potenza espansiva. E’ intrinseco insomma alla generatività della vita in atto. Perciò la necessità di passare dalla “degradazione” della Legge mosaica a pratica solo formalistico-rituale, rigidamente moralistico-normativa e idolatrico-sacrificale (quella di scribi, farisei, dottori della legge), tesa a penalizzare il desiderio quale peccato e spinta libertina alla trasgressione, a una visione invece “rinnovata“ della Legge stessa, iscritta nella carne del cuore dell’uomo (nel desiderio del soggetto) in modo tale da non reprimerne lo slancio vitale, minacciandogli solo pena e castigo e usando la mentalità penitenziale/espiatoria della rinuncia/sacrificio e il ritualismo religioso passivo e ipocrita (il “dire e non fare”) utilitaristicamente, per riscuotere il credito/rimborso nell’aldilà. Gesù -sottolinea Recalcati- ripete spesso ai discepoli “Non abbiate paura”, per farli uscire all’aperto delle acque ingovernabili e turbolente della vita, e mettervi in gioco i “talenti” del loro desiderio singolare a differenza del servo pauroso che, seppellendo l’unico talento avuto dal padrone, rintana sottoterra la sua vita rendendola sterile, o di quel discepolo che, invece di seguirlo subito, chiede di andare a seppellire prima il padre, metafora tale rinvio/dilazione di una nostalgia che blocca l’individuo sul passato, mentre la spinta vitale del desiderio porta verso il nuovo, l’inedito, verso “un altrove”. Perciò l’antiutopico e l’antireligioso (alias non conformisticamente alienato) Gesù maledice il fico che non dà i frutti “oggi”, mostrando che la realizzazione del Regno non è in un tempo sempre da venire o in un aldilà oltre questo mondo (attesa utopica e frustrante per Recalcati e Lacan, fuga allucinatoria per Freud), ma è già qui tra noi, in noi… nell’ora che è adesso, cioè nell’azione testimoniale attraverso la quale Gesù stesso (e chi allora sceglieva o continua a scegliere per lui) lo dispiega e lo realizza nell’attualità della vita in atto. E’ quaggiù -scrive Recalcati allievo di Sartre- che la vita eterna come immagine radicale della vita viva si realizza portando se stessa al compimento. La sua trascendenza è la sua immanenza e la sua immanenza è la sua trascendenza.
Nei libri di Massimo Recalcati torna con particolare insistenza l’attenzione al “processo di soggettivazione” che, vincolando -secondo il pensiero di J. Lacan- il divenire del soggetto all’istanza irriducibile del suo desiderio inteso come vocazione/dovere, lo “costituisce” nella sua irripetibile singolarità e ne fa “l’incarnazione” della Legge del desiderio. Tale tematica appare un tratto “compulsivo” della personalità e della scrittura dell’autore, una sorta di “coazione a ripetere”, che affonda le radici nel tormentato percorso esistenziale e di formazione di Recalcati stesso, come emerge dai volumi A libro aperto e La luce delle stelle morte. Usata quale sfondo teorico e strumento di interpretazione, tale tematica è originalmente presente pure in La legge della parola, dove la psicoanalisi “dialoga” con episodi e figure dell’Antico Testamento, e nel più recente La legge del desiderio fa da filo conduttore alla rilettura laica e in chiave umana della figura di Gesù (più “uomo” appunto che “il figlio di Dio”) in acrobatico equilibrismo fra sponda dei credenti, sponda lacaniana-recalcatiana e risvolti esperenziali della quotidianità. Scrive Recalcati che per Gesù, che desidera e ama la vita, e non condivide di Qohelet l’idea che il giorno della morte sia preferibile a quello del nascere, il desiderio non è -come per Qohelet- solo “vanità, vacuità”, aspirazione sempre frustrata, ma anche potenza affermativa, capacità generativa… fattore di apertura della vita e di moltiplicazione dei suoi talenti, espressione radicale della sua potenza espansiva. E’ intrinseco insomma alla generatività della vita in atto. Perciò la necessità di passare dalla “degradazione” della Legge mosaica a pratica solo formalistico-rituale, rigidamente moralistico-normativa e idolatrico-sacrificale (quella di scribi, farisei, dottori della legge), tesa a penalizzare il desiderio quale peccato e spinta libertina alla trasgressione, a una visione invece “rinnovata“ della Legge stessa, iscritta nella carne del cuore dell’uomo (nel desiderio del soggetto) in modo tale da non reprimerne lo slancio vitale, minacciandogli solo pena e castigo e usando la mentalità penitenziale/espiatoria della rinuncia/sacrificio e il ritualismo religioso passivo e ipocrita (il “dire e non fare”) utilitaristicamente, per riscuotere il credito/rimborso nell’aldilà. Gesù -sottolinea Recalcati- ripete spesso ai discepoli “Non abbiate paura”, per farli uscire all’aperto delle acque ingovernabili e turbolente della vita, e mettervi in gioco i “talenti” del loro desiderio singolare a differenza del servo pauroso che, seppellendo l’unico talento avuto dal padrone, rintana sottoterra la sua vita rendendola sterile, o di quel discepolo che, invece di seguirlo subito, chiede di andare a seppellire prima il padre, metafora tale rinvio/dilazione di una nostalgia che blocca l’individuo sul passato, mentre la spinta vitale del desiderio porta verso il nuovo, l’inedito, verso “un altrove”. Perciò l’antiutopico e l’antireligioso (alias non conformisticamente alienato) Gesù maledice il fico che non dà i frutti “oggi”, mostrando che la realizzazione del Regno non è in un tempo sempre da venire o in un aldilà oltre questo mondo (attesa utopica e frustrante per Recalcati e Lacan, fuga allucinatoria per Freud), ma è già qui tra noi, in noi… nell’ora che è adesso, cioè nell’azione testimoniale attraverso la quale Gesù stesso (e chi allora sceglieva o continua a scegliere per lui) lo dispiega e lo realizza nell’attualità della vita in atto. E’ quaggiù -scrive Recalcati allievo di Sartre- che la vita eterna come immagine radicale della vita viva si realizza portando se stessa al compimento. La sua trascendenza è la sua immanenza e la sua immanenza è la sua trascendenza.
Anche la trascendenza cristiana (il Dio che si fa uomo) “accade” -puntualizza l’autore- nel mondo. E piegando a una interpretazione laica il concetto paolino della grazia dono gratuito di Dio che salva, precisa che la “grazia” dell’evento-incontro dei discepoli con Gesù, uomo di desiderio che la sua vocazione/missione vive e testimonia dal primo intervento a 12 anni fra i dottori del Tempio fino alla notte del Getsemani quando sceglie di donare per amore senza riserve la sua vita, si configura per essi, cioè i discepoli, ma anche per tutti i miracolati delle guarigioni, i convertiti, i risorti (il figlio della vedova di Nain, la figlia del capo della sinagoga, Lazzaro), come ogni incontro esistenziale con il “reale” che rappresenti per il Soggetto uno strappo improvviso, un taglio, una frattura, il rivelarsi di un “senso nuovo” nello scorrere ripetitivo, monotono e conformato dei giorni. Il che rimanda ancora una volta a Lacan, alla sua distinzione fra tyche e automaton: “tyche” è l’evento contingente dell’incontro destinato a rompere la ripetizione anonima e necessaria dello Stesso, l’“automaton” appunto! Un “risvegliarsi” imprevedibile dunque del soggetto alla verità del “proprio” desiderio e quindi alla assunzione “decisa” del proprio “singolare” destino, liberato ciascuno di noi (ieri e oggi, cristiani e non), per questa improvvisa visitazione, da sedimentate, insospettate talora, coartanti prigioni psicologiche di identificazioni, proiezioni, rimozioni, e/o securitarie chiusure nei propri confini identitari e beni, ricchezze, certezze, privilegi, potere…, tutte cose che ottundono, spengono la “vita”. Saul, fariseo zelante e fanatico persecutore dei cristiani, che cade da cavallo accecato sulla via per Damasco, sperimenta la caduta rovinosa dell’Io, la perdita della precedente falsa certezza di se stesso, e si ritrova nella conversione con un nome nuovo, Paolo, (etimologicamente “piccolo”, “minimo”) e apostolo ardente della parola di Cristo. E Recalcati spiega che la vita umana è fatta innanzitutto degli incontri che l’hanno fatta… [e] di ciò che essa ha fatto degli incontri che l’hanno fatta. Ma quale è il cuore della nuova Legge di Gesù venuto, come giusto erede, non per abolire la Legge, ma per portarla a compimento, liberandola dal formalismo sterile e dallo schiacciante perfettismo ipermoralistico, che vedeva negativamente il soggetto solo come portatore senza appello di colpe e votato perciò alla rinuncia espiatorio-sacrificale della “propria” vita? Suo “cuore” sono le nuove strade, aperte e “eversive”, del Perdono (l’episodio dell’adultera, la parabola del figliol prodigo) che fa “risorgere” la vita, e dell’Amore per il prossimo (la parabola del Samaritano). “Prossimo”, che non è il simile (la proiezione narcisistica del proprio sé nell’altro), ma l’estraneo, lo sconosciuto (l’alterità irriducibile dell’Altro), e che fattivamente si realizza nel farsi prossimi, cioè lo stare accanto a chi soffre, a chi cade nel bisogno. Chi ha agito come il prossimo? -chiede infatti Gesù. Non certo il levita o il sacerdote passati oltre, ma lo “straniero”, il Samaritano, che si è sentito commosso alle viscere dalle ferite dell’aggredito e, senza conoscere la Legge, ha “incarnato” il vero spirito della Legge, rendendosi e “sperimentandosi” reciprocamente, samaritano e aggredito, prossimo l’uno dell’altro. Emerge un amare “disinteressato”, senza calcolo, senza tornaconto, che si fa atto (c’è più gioia e beatitudine -dirà Paolo riferendo agli efesini le parole di Gesù- nel dare che nel ricevere), “atto” che il Vangelo spinge fino al limite estremo dell’amore per i nemici. Nella relazione all’altro, “nell’esodo all’altro” si esalta al massimo per Gesù la forza espansiva “desiderante” della vita, e i “salvati”, i “benedetti” nel giorno del giudizio universale saranno quelli dalle vite più vive, vite capaci di amare: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete coperto, malato e carcerato e mi avete visitato… “I maledetti” invece -scrive Recalcati- saranno quelli che si sono negati all’uomo, e quindi si sono negati a Dio, perché non hanno visto, secondo le parole del Maestro, Dio nell’uomo. E cita opportunamente il pensiero del teologo tedesco e partigiano D. Bonhoeffer per il quale essere “cristiani” non significa essere religiosi (nel senso riduttivo/negativo prima visto)… ma essere uomini.
Sul processo di soggettivazione l’autore torna in diversi capitoli. Nel quinto, Il segreto di Maria, riflette sulla maternità, la genitorialità, e i rapporti di filiazione dove ciò che fa la differenza non è il legame naturale, biologico, ma la legge dell’Amore. E viene spiegando che -come evidenzia l’esperienza psicoanalitica- a rendere genitore “un genitore” non è il generare un figlio, quanto il suo costituirsi come un Altro affidabile in grado di amare il “figlio” nella sua singolarità/unicità. Riprende pertanto dall’Antico Testamento il noto episodio delle due madri che si contendono un bimbo, rivendicandolo ognuna come il proprio figlio. Rappresentano -dice- entrambe le due anime della maternità: quella “cannibalica”, che sentendo il figlio come sua “proprietà”, gli resta attaccata fino a “soffocarlo”, e quella invece “giusta”, la vera madre della ”cura” e “dell’amore” che, quando Salomone minaccia di tagliare in due il bimbo, accetta di perderlo per sempre, purché il figlio viva. Recalcati conclude che il dono in atto della genitorialità si vede davvero in Maria e Giuseppe: in loro ci sono il “padre”, la “madre” e il legame familiare, non per continuità di sangue, ma perché riscontriamo che nelle loro figure c’è dono in atto, amore per l’eteros del figlio, assunzione di responsabilità illimitata, esperienza incondizionata dell’accoglienza (accoglienza -vuole dire- della radicale alterità/mistero/libertà del figlio). Per loro il figlio è stato “Gesù”, il Figlio di Dio, ma ogni figlio pur essendo carne e sangue di sua madre, è tuttavia anche ciò che cresce differente, e in virtù proprio di quelle viscere, sangue e carne; resta cioè il figlio inappropriabile, e Maria incarna la maternità giusta perché “accoglie” (il suo Sì consapevole, attivo, nel momento dell’Annunciazione), “dona” generosamente amore, e lascia poi andare il figlio Gesù per la sua strada, avendo “fede” nel desiderio (vocazione) di lui. Questo principio importante della libertà/separazione nell’ambito dei rapporti familiari, equivalente per Lacan a quello fondativo della Creazione stessa del mondo (ogni creatura dipende sì dal Creatore -afferma- ma è abbandonata alla sua radicale libertà nella molteplicità del creato), principio che non cancella il debito simbolico verso i genitori, torna nel capitolo sesto, Il figlio giusto, dove attorno alla vicenda del figliol prodigo non si sviluppa soltanto la riflessione sull’esperienza già vista del perdono, ma anche quella sul conflitto tra le generazioni. Appartenenza e erranza sono -afferma Recalcati- i due poli dell’umanizzazione della vita e il “conflitto” custodisce la differenza simbolica fra le generazioni, purché resti un rapporto dialettico e non si blocchi in una opposizione sterile. I giovani non devono percepire la Legge solo come “repressione”, i vecchi non si devono porre solo come i tutori infallibili della Legge. Nella interpretazione di Recalcati della parabola, sia il figlio maggiore che il figlio minore all’inizio della sua avventura esistenziale sono cattivi eredi: il maggiore, per eccesso di obbedienza, il minore, per eccesso di rivolta. Il primo pretende di essere erede per diritto di sangue e vive il rapporto di filiazione come obbedienza servile e ”interessata” in attesa del rimborso, senza mai interrogarsi sulla sua vocazione, su cosa “desidera” fare della sua vita; il minore segue invece giustamente il suo desiderio (di uscire dalla famiglia), ma crede di essere solo in credito col padre, e il suo imperioso <<dammi la parte di eredità che mi spetta>> somiglia alla pretesa velleitaria di tanti figli di oggi che (sedotti -bene suggerisce Recalcati- dal discorso del capitalista) scambiano la sregolatezza della pulsione e la richiesta di beni solo materiali, di cose, per “libertà”, votandosi come il figliol prodigo alla dissipazione, al fallimento, alla perdita di se stessi. Il padre della parabola è quello che dovrebbe essere ed “è” il padre per Lacan, colui che dice : <<eccomi>> nell’infanzia del figlio (cioè presenza sicura) e <<vai>> nella giovinezza del figlio, gli permette cioè crescendo di andare via (come Abramo libera dai lacci Isacco), gli dona la libertà, consapevolmente esponendosi all’incognita/rischio del “viaggio di formazione” del figlio che va alla ricerca della “propria” verità e/o del “nuovo”. Dunque non un padre-padrone, ma un Padre permissivo e donatore -secondo la formula nota di Lacan- che “sa amare” il desiderio singolare del figlio, sostiene il diritto di quello alla “separazione”, e se cade (come tutti cadiamo), se sbaglia e “si perde”, lo “aspetta” nel perdono, gli corre anzi incontro “gioioso”, e consente al giovane, con questo suo secondo dono d’amore assoluto, attivo e antinarcisistico, attraverso l’esperienza del pentimento e della maturazione/conversione, di “ricominciare”, di aprirsi a una “nuova forma”. Dall’altro lato, figlio giusto e giusto erede risulta chi comprende che l’“eredità” non è spartizione di bottino, ma soprattutto “un compito”, “riconquista” soggettiva del proprio passato. Solo riconoscendo -conclude Recalcati- con la gratitudine il debito simbolico si realizza una separazione generativa, e non solo oppositiva. Diversamente si resta nell’odio (che non rompe il legame, la dipendenza) o nella dipendenza infantile.
Dinamiche simili scattano nel rapporto maestro-discepolo, indagate nel capitolo settimo dal titolo Tradimenti, dove il focus si sposta su Giuda e Pietro. Conclusione finale anche qui sarà che giusto erede è chi conserva nel suo desiderio l’orma incancellabile del desiderio del maestro (se tale è stato il maestro!) quale segno decisivo dell’incontro con lui. Riconoscendo con gratitudine quanto ha ricevuto, proprio grazie a “tale” riconoscimento il discepolo può liberamente rinnovare il patrimonio trasmessogli, proprio come ha fatto Gesù -sottolinea Recalcati- il quale, erede di Mosè, di Giovanni Battista e della fede e cuore della madre Maria (non dimentichiamo il Magnificat!), ha lavorato con libertà su quanto aveva ricevuto, generando “frutti nuovi”. Quanto alla diversa natura dei rispettivi tradimenti da parte di Giuda e di Pietro del “loro” Maestro, un maestro capace di provocare grandi passioni (appunto “desiderio”) in chi lo ascoltava, incontrava, cercava, Giuda per Recalcati va letto come il discepolo “politico” che alla fine tradisce perché deluso nelle sue aspettative propriamente “politiche”, mutando il suo precedente amore in odio. Tradisce perché il suo amore idealizzato di Gesù non ha saputo tenere nel giusto conto l’alterità dell’Altro; voleva Giuda che l’alterità di Gesù coincidesse con la sua narcisistica rappresentazione di Gesù, con le sue personalissime attese, donde la rivolta aggressiva. Pietro invece, sempre sinceramente innamorato del suo maestro, anche quando lo rinnega tre volte, tradisce per umana debolezza, per paura e viltà, mostrandosi però ancora più colpevole perché, mentre nega di conoscere Gesù, sta tradendo il “suo” stesso desiderio, sta tradendo se stesso. Ma cedere sul proprio desiderio è per Lacan “strutturale” al desiderio stesso, rientra nella nostra umana mancanza/incoerenza, e Recalcati sigla il tutto dicendo che sapere cogliere la propria contraddizione…,il proprio tradimento non impedisce [tuttavia] l’amore… [anzi] lo istituisce come umano. Pietro si salverà con le lacrime del pentimento (pianse amaramente, leggiamo in Matteo) e accogliendo la sua vulnerabilità, riapre il suo rapporto con l’Altro. Anche le tre resurrezioni narrate nei Vangeli sono per la psicoanalista Françoise Dolto, citata da Recalcati, tagli simbolici di legami familiari divenuti soffocanti, mortiferi. Nel miracolo della resurrezione del figlio della vedova di Nain per la Dotto il ragazzo morto si risveglia giovane adulto con un suo proprio desiderio (sic!) ormai affrancatosi dalla prigione materna (infatti Luca precisa che cominciò a parlare). Analogamente la figlioletta di Giairo (Ragazzina, ti dico, svegliati!) si libera dal legame col padre che da 12 anni soffocava in lei ogni ragione di vivere, e Lazzaro stesso si sgancerà dal legame simbiotico con le sorelle Marta e Maria, evidenziato anche dal fatto per la Dolto che tutti e tre continuavano a vivere nella casa dei genitori. Eventi sovrannaturali o meno (in relazione all’essere credenti o no), le tre resurrezioni, la stessa Resurrezione poi di Cristo (e forza d’attrazione del suo sepolcro vuoto) e soprattutto le autodefinizioni che Gesù dà di se stesso in varie circostanze (Sono io la resurrezione e la vita… Io sono la via, la verità, la vita…) rappresentano per Recalcati, in contrasto con la mentalità “chiusa” dell’uomo tipico “religioso” che tutto fa ruotare attorno alla paura della morte e della vita, immaginando come fuga/risarcimento una vita al di là di questa vita, un inequivocabile invece appello alla vita, a stare “nella vita” in questa vita. I suoi miracoli, parole e azioni fanno insomma di Gesù l’incarnazione della forza indistruttibile del desiderio, del sempre residuare vitale della vita oltre ogni traumatica esperienza individuale e collettiva di distruzione e di morte, come la “fragile” vite piantata da Noè dopo le tenebre del diluvio universale. E a conferma della sua tesi l’autore cita una affermazione del teologo francese J. Moingt per il quale La fede nella resurrezione di Gesù… è inserirsi in una visione della storia, è un orientamento di vita, una decisione di ogni istante, è un impegno a vivere una vita sempre nuova perché incessantemente strappata al compiacimento di sé, all’inerzia, alla sufficienza, e riprende circa il presunto aldilà migliore le osservazioni di Bonhoeffer sulla speranza cristiana della resurrezione [che] si distingue da quelle mitologiche per il fatto che essa rinvia gli uomini alla loro vita sulla terra. Perciò acquista rilevanza pure la parabola dei lavoratori dell’undicesima ora che il padrone della vigna ricompensa con la stessa mercede pattuita con quelli della prima ora, perché -annota Recalcati- se la vita è ricca di vita (alias vita viva) lo è in ogni ora, e l’importante è rispondere alla chiamata del “desiderio“ (l’invito del padrone della vigna) in piena disponibilità e “purezza di cuore”. Dice infatti Gesù, nel vangelo di Marco, che non contaminano l’uomo le cose che sono fuori di lui, ma ciò che esce da dentro l’uomo: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, dissolutezza, occhio maligno, bestemmia, superbia, stoltezza, e nel vangelo di Matteo lancia un preciso ammaestramento/ammonimento ai farisei di ieri e di sempre: Andate -li esorta- piuttosto a imparare cosa significa: Voglio misericordia e non sacrificio.