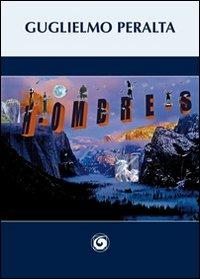“La Cecità pandemica del romanzo di Saramago” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 29 Giugno 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2358
 Nell’attuale pandemia indotta dal corona-virus il romanzo Cecità (1996) di José Saramago (1922/2010), premio Nobel per la letteratura 1998, suona singolare per chiaroveggenza, terribile per ammonimento. Intellettuale autodidatta e scomodo per molte sue scelte, dichiaratamente ateo e anticlericale (Dio è il silenzio dell’universo e l’uomo è il grido che dà senso a questo silenzio), ostile alla politica di Israele verso i palestinesi (gli ebrei non avrebbero imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni), critico verso l’operato di Berlusconi (riuscito nell’impresa di dividere il popolo italiano in due: quelli cui piacerebbe essere come lui e quelli che già lo sono), Saramago mostra nella sua attività una costanza/coerenza di fondo: ciò che chiama diritto di indignarsi per quello che accade nelle sfere della politica e della religione o della società, se in esse sembra ci sia del male. Si consideri a riprova l’avvertimento che fa da epigrafe a Cecità: Se puoi vedere, guarda. Se puoi guardare, osserva, cioè “rifletti”. E come premessa all’interpretazione del testo non sembra disutile ricordare anche che l’ampio ventaglio della produzione letteraria dello scrittore portoghese ha toccato tematiche diverse: dal mondo contadino e iberico (Terra del peccato, Una terra chiamata Alentejo, L’assedio di Lisbona, La zattera di pietra…) a quello neo e vetero-testamentario (Il Vangelo secondo Gesù, Caino) a quello capitalistico e globalizzato (La Caverna, Cecità, L’uomo duplicato…) secondo un’ottica, per conservare la sua autodefinizone, da comunista ormonale. Un comunista il cui cervello ha fatto propria l’indicazione di Marx e Engels: Se l’uomo è formato dalle circostanze, bisogna formare le circostanze umanamente, ma non essendo state “tali” circostanze realizzate né dal socialismo reale pervertitosi né tanto meno dal capitalismo e dalla globalizzazione (la liberalizzazione del pane -diceva- é soggetta a un proibizionismo feroce in metà del mondo), il suo cervello ha continuato a secernere “ormoni” di denuncia sociale. Con il corollario paradossale, ma non tanto, che gli unici interessati a cambiare il mondo sono i pessimisti, perché gli ottimisti sono contenti di quello che hanno (alias, “non guardano”). Nel romanzo Cecità trova innanzitutto pieno riscontro la motivazione del Nobel secondo cui Saramago con parabole sostenute dall’immaginazione, dalla compassione, dall’ironia ci permette continuamente di conoscere realtà difficili da interpretare. Nel caso specifico le “circonvoluzioni” della natura umana e gli errori/orrori della società contemporanea. Ma il suo racconto della improvvisa strana epidemia di cecità rapidamente diffusasi in una anonima località sotto forma di insondabile biancore, anzi di splendente luminoso biancore come il sole nella nebbia o un mare di latte che divorava colori esseri cose, suggerisce anche inevitabili proiezioni nel nostro oggi “pandemico”. Proiezioni in termini non solo di disperante disagio psicologico per il forzato isolamento e/o necessitato distanziamento sociale che stiamo vivendo, ma anche di paura storico-esistenziale per le necessità economiche e di sopravvivenza createsi e per i resistenti egoismi individuali e sociali che a scelte di lungimirante solidarismo e collaborazione sono venuti (o vengono) opponendo i soliti settarismi localistici e nazionalistici e truffaldine operazioni speculative.
Nell’attuale pandemia indotta dal corona-virus il romanzo Cecità (1996) di José Saramago (1922/2010), premio Nobel per la letteratura 1998, suona singolare per chiaroveggenza, terribile per ammonimento. Intellettuale autodidatta e scomodo per molte sue scelte, dichiaratamente ateo e anticlericale (Dio è il silenzio dell’universo e l’uomo è il grido che dà senso a questo silenzio), ostile alla politica di Israele verso i palestinesi (gli ebrei non avrebbero imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni), critico verso l’operato di Berlusconi (riuscito nell’impresa di dividere il popolo italiano in due: quelli cui piacerebbe essere come lui e quelli che già lo sono), Saramago mostra nella sua attività una costanza/coerenza di fondo: ciò che chiama diritto di indignarsi per quello che accade nelle sfere della politica e della religione o della società, se in esse sembra ci sia del male. Si consideri a riprova l’avvertimento che fa da epigrafe a Cecità: Se puoi vedere, guarda. Se puoi guardare, osserva, cioè “rifletti”. E come premessa all’interpretazione del testo non sembra disutile ricordare anche che l’ampio ventaglio della produzione letteraria dello scrittore portoghese ha toccato tematiche diverse: dal mondo contadino e iberico (Terra del peccato, Una terra chiamata Alentejo, L’assedio di Lisbona, La zattera di pietra…) a quello neo e vetero-testamentario (Il Vangelo secondo Gesù, Caino) a quello capitalistico e globalizzato (La Caverna, Cecità, L’uomo duplicato…) secondo un’ottica, per conservare la sua autodefinizone, da comunista ormonale. Un comunista il cui cervello ha fatto propria l’indicazione di Marx e Engels: Se l’uomo è formato dalle circostanze, bisogna formare le circostanze umanamente, ma non essendo state “tali” circostanze realizzate né dal socialismo reale pervertitosi né tanto meno dal capitalismo e dalla globalizzazione (la liberalizzazione del pane -diceva- é soggetta a un proibizionismo feroce in metà del mondo), il suo cervello ha continuato a secernere “ormoni” di denuncia sociale. Con il corollario paradossale, ma non tanto, che gli unici interessati a cambiare il mondo sono i pessimisti, perché gli ottimisti sono contenti di quello che hanno (alias, “non guardano”). Nel romanzo Cecità trova innanzitutto pieno riscontro la motivazione del Nobel secondo cui Saramago con parabole sostenute dall’immaginazione, dalla compassione, dall’ironia ci permette continuamente di conoscere realtà difficili da interpretare. Nel caso specifico le “circonvoluzioni” della natura umana e gli errori/orrori della società contemporanea. Ma il suo racconto della improvvisa strana epidemia di cecità rapidamente diffusasi in una anonima località sotto forma di insondabile biancore, anzi di splendente luminoso biancore come il sole nella nebbia o un mare di latte che divorava colori esseri cose, suggerisce anche inevitabili proiezioni nel nostro oggi “pandemico”. Proiezioni in termini non solo di disperante disagio psicologico per il forzato isolamento e/o necessitato distanziamento sociale che stiamo vivendo, ma anche di paura storico-esistenziale per le necessità economiche e di sopravvivenza createsi e per i resistenti egoismi individuali e sociali che a scelte di lungimirante solidarismo e collaborazione sono venuti (o vengono) opponendo i soliti settarismi localistici e nazionalistici e truffaldine operazioni speculative.
L’epidemia di “cecità” è seguita, nel libro, nel suo primo manifestarsi e successivi effetti quale progressivo disvelamento delle abiezioni umane e della collettiva indifferente (appunto “cieca”) assuefazione ad esse, donde la pregnante metafora che la sintetizza come infiltrazione insidiosa di mille e uno rigagnoli inquietanti che, dopo avere inzuppato lentamente la terra, all’improvviso la sommergono completamente. Il primo cieco diventa tale nella sua auto dentro il frenetico traffico urbano; seguono il ladro di automobili, che con interessato altruismo lo accompagna a casa ma gli ruba la macchina; la ragazza dagli occhiali scuri, che acceca in un albergo durante uno dei suoi mercenari esercizi amatori dopo avere incrociato il primo cieco in uno studio oculistico; il medico dello studio, mentre indaga invano le ragioni scientifiche della malattia (che è invece di natura morale); un vecchio dalla benda nera su un occhio e un ragazzino strabico che, pazienti del medico, simboleggiano nella vicenda gli estremi (fine/inizio) di una esistenza da “rieducare” secondo altri tipi di esperienze. Il vecchio ad esempio racconterà di essersi ritrovato cieco a casa mentre, tolta la benda, si guardava l’orbita vuota, sospettando fosse infiammata, e uno gli dirà: Sembra una parabola, l’occhio che si rifiuta di riconoscere la propria assenza (sic!). Quelli sopra citati sono i “primi” ciechi, e saranno anche i primi “internati” (eccetto il vecchio che arriverà dopo con i 200 malati di 4 autobus), tutti isolati in un manicomio vuoto, malandato, sporco, scelto dal Governo per la quarantena dei malati (ala destra dell’edificio) e dei sospetti contagiati (ala sinistra). Con loro la moglie del medico, che si finge cieca per non abbandonare il marito e che per tutto il romanzo rimarrà l’unica vedente, e dunque unica guida e aiuto (ossia infaticabile presidio di sana razionalità, generosità, umana dignità) in una società globalizzata di “ciechi” regrediti alla condizione animalesca di brutale risposta agli sfinteri, al sesso, alla fame, alla predazione del più forte. Un inferno il manicomio dove i ciechi abbandonati a se stessi, ma rigidamente sorvegliati dall’esterno e sbeffeggiati da soldati che ne vorrebbero l’eliminazione fisica (perché morta la bestia, tolto il veleno), vivono una convivenza/sopravvivenza disperata e difficile: per il fetore dei corpi e degli ambienti sovraffollati, per l’irregolare o insufficiente distribuzione del cibo, arraffato egoisticamente da alcuni e infine ferocemente requisito e razionato da un manipolo di ciechi malvagi, che pretendono in cambio danaro, gioielli e le donne, ansimanti su di esse come maiali e coi pantaloni calati come iene intorno a una carogna. La moglie del medico ne ucciderà il capo con una forbice e un’altra con un accendino appiccherà l’incendio che restituirà la libertà ai sopravvissuti. Fra questi il gruppetto strettosi sin dall’inizio come una pigna attorno ai principi etici della moglie del medico (Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali), principi purtroppo non generalizzatisi nel manicomio. Prima dell’esito “liberatorio” dell’incendio, nei vari capitoli è infatti tutto un crescendo di sofferenze e crudeltà, su cui il narratore indugia ora con polemica, sarcastica, ironia (verso il Potere e l’inossidabile cattiveria umana), ora con risentita pietà (verso la comune miseria): Sdraiati sulle brande i ciechi aspettavano che il sonno avesse compassione della loro tristezza, seminando qua e là Saramago in tutto il libro continui sottili raccordi fra la sua significante “allegoria” e la greve realtà di fine millennio. Tale “risuonerà”, nello spettrale chiarore lunare che illumina i due morti e gli sconfitti dell’assalto fallito alla camerata dei ciechi sfruttatori, la silenziosa riflessione della moglie del medico: nessuno potrà salvarsi, la cecità è anche questo, vivere in un mondo dove non ci sia più speranza. Tale, analogamente, la sua risposta, nel penultimo capitolo, al marito che la paragona per il suo operare al “testimone” di un misterioso, strano, tribunale: Il tempo sta per concludersi, la putredine dilaga, le malattie trovano le porte aperte, l’acqua si esaurisce, il cibo è ormai veleno, sarebbe questa la mia prima dichiarazione, disse la moglie del medico…
II crescendo di negatività nel manicomio comincia dall’aggressività e arroganza del ladro cieco che nella camerata alterca e si azzuffa col primo cieco da lui derubato (sì, sono stato io a rubartela [la macchina], ma tu a me hai rubato la vista, chi è più ladro?) e che, in fila per andare alle latrine guidati dalla moglie del medico, palpa e stringe sfrontatamente il seno alla ragazza dagli occhiali scuri, la quale con un calcio all’indietro gli infilza il tacco sottile della scarpa nella coscia. La ferita si infetterà per l’acqua putrida dei tubi, e il ladro che si vedrà negate dal sergente le medicine per disinfettarla (rifiuto contrario a ogni principio umanitario -dice il medico) morirà ucciso per paura da un soldato quando in un estremo tentativo di sopravvivenza e richiesta di aiuto, trascinatosi fuori fino al portone mostrerà la sua faccia bianca di contagioso fra le sbarre verticali del cancello. Altri morti ci saranno nell’atrio delle due ali del manicomio un giorno in cui, saltata la colazione e tardando il pranzo, un gruppo di ciechi vi si raccoglie in attesa, ma con l’effetto di spaventare con la sua inaspettata presenza in quella penombra i soldati entrati con le casse del cibo: questi fuggono strillando per la paura e i compagni della scorta armata scaricano i caricatori sugli affamati, presentando poi bugiardamente la cosa come repressione di un moto sedizioso. E orrore nell’orrore, i contagiati, pur vedendo il sangue dilagare sul pavimento, vorrebbero impadronirsi delle casse destinate ai ciechi, divisi fra paura dei possibili veleni e spiriti malefici sprigionantisi dalla carne sfracellata dei morti, e le ragioni dello stomaco. Le stesse ragioni per le quali alcuni ciechi mentono sul numero dei presenti nella propria camerata, o se la squagliano con alcune casse, invece di dividere equamente con gli altri, rimpinzandosi con razioni doppie, triple in qualche luogo nascosto delle vecchie e decrepite costruzioni, o vorrebbero, a loro volta, rubare il cibo ai contagiati (solo ancora per poco vedenti), presentandosi nell’atrio a spaventarli. Uno svilimento/avvilimento interiore e fisico -come si vede- reso ancora più grave dall’umiliazione, dopo la strage, del dover cercare i ciechi da soli le casse lasciate fuori fra i gradini d’ingresso dell’edificio e il cancello, procedendo a quattro zampe con la faccia strisciante per terra come suini, un braccio avanti a scandagliare l’aria, mentre i soldati stanno con le armi puntate su di loro trattandoli quali imbecilli che si muovevano davanti ai loro occhi come dei granchi zoppi, agitando le pinze malsicure in cerca della zampa mancante. Nessuna tenerezza mostra Saramago per l’umanità, fissata alla pari, carnefici e vittime (esclusi pochi), in un livellamento generalizzato e colpevole di viltà e di egoismo! E la “ricchezza” dei sentimenti? Quasi zero, come si evincerà poi esplicitamente nel terz’ultimo capitolo, sullo sfondo del labirinto demenziale della città sconvolta, dal dialogo sul rapporto parole/sentimenti fra la moglie del medico e uno scrittore pure lui cecato dalla malattia: Vuol dire - chiede questi -che abbiamo parole in più, Voglio dire che abbiamo sentimenti in meno, Oppure ce li abbiamo, ma non usiamo più le parole che potrebbero esprimerli, E dunque li perdiamo (si noti l’irregolare, caratteristica punteggiatura di Saramago!). Quando arriveranno nel manicomio i quattro autobus con 200 altri internati eccedenti la giusta capienza dell’edificio, ci sarà non solo gente che dorme a terra nei corridoi, ma anche una estensione dei “cessi” propriamente detti ai corridoi stessi e al recinto, dove i ciechi hanno sepolto da sé i morti. Agli sciacquoni fuori uso, alle docce otturate o staccate dalle tubature, ai chiusini traboccanti di acqua sporca, si aggiungerà ora il gruppetto dei ciechi malvagi armati di bastoni, sbarre di ferro e di una pistola, che estromessi gli altri dalla camerata e dall’uso dei bagni dell’ala sinistra, monopolizzano la distribuzione e il razionamento del cibo (da oggi saremo noi a gestire il cibo…adesso il cibo si vende, chi vuole mangiare paga). E i soldati chiamati in aiuto fingono, secondo gli ordini ricevuti, di non sentire (Se si ammazzano a vicenda tanto meglio, ne restano di meno). Terribili inoltre scorrono le pagine che descrivono le violenze sulle donne, sacrificate per assicurare il pane a tutti gli occupanti delle rispettive camerate. Nella prima di destra sono solo 7, e quando si dispongono in fila dietro la moglie del medico, per raggiungere l’altra ala, il narratore crudamente osserva: una fila grottesca di femmine maleodoranti con gli abiti immondi e cenciosi, sembra impossibile che la forza bestiale del sesso sia ancora tanto possente al punto di accecare l’olfatto, e dei maschi vogliosi sottolinea grida nitriti risate grugniti da porci sgozzati. Una delle sette, che soffriva di insonnia, muore al ritorno dagli stupri nell’atrio e viene presa in braccio dalla moglie del medico che nel corpo disarticolato di quella vede il ritratto del suo stesso corpo e delle altre: le gambe insanguinate, il ventre livido, i poveri seni scoperti, segnati con furia, un morso su una spalla. Riuscirà la donna a procurarsi dell’acqua, forzando disperata una manopola dell’ex refettorio, e laverà una dopo l’altra le sue compagne, se stessa, e la morta per ripulirla del sangue proprio e della secrezione altrui [e] consegnarla purificata alla terra, ammesso che ancora abbia senso -riflette il narratore- di parlare di purezze del corpo in questo manicomio in cu viviamo, ché alle purezze dell’anima, si sa, non c’è modo di giungervi. Orrido anche l’ultimo episodio, premessa dell’incendio che col crollo del tetto dell’ala sinistra si lascerà dietro pure una massa informe e sanguinolenta di ciechi calpestati. Dopo l’uccisione del capo dei malvagi, poiché l’esercito non porta cibo per tre giorni, al quarto un gruppetto di uomini e donne (fra cui la moglie del medico) decidono di andarselo a prendere assaltando la camerata dei malvagi, ma due colpi di pistola sparati bassi freddano due degli assalitori, fanno fuggire rovinosamente gli altri, e saranno il medico, la moglie, il vecchio e un’altra donna (quella che poi torna con l’accendino), trascinandosi a terra nel sangue (sic!) degli uccisi a recuperare coraggiosamente i due morti, mentre sibila un’altra pallottola. La Morte è onnipresente nel romanzo, ora velata di umana pietas (il rametto ad esempio di roseto posto sulla fossa della vecchia sottratta ai morsi dei cani), ora e più spesso rappresentata nell’orrore dell’annientamento totale di ogni umanità, come sarà la visione/acme nell’ultimo capitolo dei fuochi fatui (idrogeno fosforato) che stavano lì avvinghiati e ballavano alle fessure del sotterraneo del supermercato trasformatosi in un enorme sepolcro per i ciechi precipitativi in cerca di cibo.
Speculare all’inferno-manicomio sarà infatti, fuori di là, l’inferno-città ridottasi senza Governo, soldati, poliziotti (tutti cecati), senza elettricità, acqua, gas, con gruppi erranti di ciechi/fantasmi “a caccia di cibo” fra cumuli di spazzatura, escrementi umani e animali, auto e camion abbandonati, morti divorati dai cani nelle strade, negozi e supermercati svuotati, banche saccheggiate ma con le casseforti sotterranee vegliate da ciechi ancora avidi (sic!) di ricchezza. Anche in questo contesto caotico e di disperazione assoluta, la donna unica vedente continua ad affannarsi per aiutare i sei che dipendono totalmente da lei (come i piccini dalla mamma) e che attorno a lei e grazie a lei erano riusciti durante la disumana quarantena a conservare un minimo di ordine e di rispetto di se stessi e degli altri: il marito, il vecchio, il primo cieco e sua moglie, la ragazza dagli occhiali scuri maternamente protettiva sin dall’inizio verso il ragazzino strabico. E’ la moglie del medico che riesce a riempire fra enormi difficoltà, nel magazzino sotterraneo e buio di un supermercato saccheggiato, dei sacchetti di cibo, portandoli, con fatica sotto la pioggia e avanzando nel fango, fino al negozio vuoto dove ha fatto riparare i suoi, pietosamente accompagnata da un cane che le ha prima leccato la faccia in lacrime, quando ha temuto la donna di avere perso la strada. E’ lei che guida i sei a casa della ragazza, dove finalmente attorno a un tavolo, con il poco che hanno, fanno come una festa di famiglia, una di quelle feste, rare, dove quel che possiede ciascuno è di tutti. E’ lei che poi li conduce tutti a casa sua (una delle poche non saccheggiate e occupate da estranei) e che durante una notte di pioggia scrosciante laverà sul balcone le scarpe e i vestiti sporchi di ognuno aiutata dalla ragazza e dalla moglie del primo cieco (forza -dice- siamo l’unica donna con due occhi e sei mani che esista al mondo), lavandosi a loro volta tutte e tre reciprocamente, tre grazie nude sotto la pioggia, in un nuovo rito purificatore, rigeneratore. E’ a casa della moglie del medico che con l’acqua di un bottiglione ritrovato in cucina fanno insieme un brindisi alzando bicchieri di cristallo finissimo (semplicemente comunicava al mondo che cosa meravigliosa sia un bicchiere d’acqua), mentre la lucerna ad olio al centro del tavolo era come un sole circondato da astri brillanti. E’ lei che la sera legge al gruppetto un libro, lungo filo di suono che sopravvive tra le generazioni (sic!), e a lei si rivolge lo scrittore rifugiatosi con la famiglia nella casa del primo cieco, dicendo: Non si perda, non consenta di perdersi. Fondamentale infatti risulta la funzione pedagogica di questa donna verso gli altri: nel senso della resistenza e del coraggioso altruismo, della collaborazione instancabile e della salvaguardia dell’umano (sono soltanto colei che è nata per vedere l’orrore, voi lo sentite, io lo sento e lo vedo), e con esso della vita e delle “lacrime”, cioè il dono/dote della compassione (secondo il valore etimologico del termine). Se la ragazza (che poi si legherà sentimentalmente al vecchio) scoraggiata afferma: penso che siamo già morti, siamo ciechi perché siamo morti… siamo morti perché siamo ciechi, lei le oppone: Io ci vedo ancora… e la responsabilità ce l’ho oggi…la responsabilità di avere gli occhi quando gli altri li hanno perduti. Se il vecchio dice: Siamo regrediti all’orda primitiva… con la differenza che non siamo più qualche migliaio di uomini e donne in una natura immensa e intatta ma migliaia di milioni in un mondo spolpato ed esaurito (e cieco), lei riflette che possiamo tuttavia difendere la fragilità della vita come se fosse lei la cieca… forse la vita si è abbandonata nelle nostre mani dopo averci resi intelligenti e noi l’abbiamo portata a questo. Né annunci magico-millenaristici dunque, né falsa politica compromessa con gli interessi di singoli, o di parte, ci servono, come evidenziano i discorsi infervorati fatti nelle piazze da gruppi di ciechi ad altri ciechi e ironizzati da Saramago (il pensiero convesso, quello concavo, quello piano, quello verticale, quello concentrato, quello disperso, quello sfuggito, l’ablazione delle corde vocali, la morte della parola), e neanche, per “l’ateo” Saramago, i Santi bendati delle chiese (che contemplano solo la propria cecità). Ci serve semplicemente “aprire gli occhi”. Non siamo diventati ciechi, -concluderà il medico nelle ultime righe del libro- secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che pur vedendo, non vedono. Purtroppo, finita l’epidemia e tornata a tutti la vista, la città era ancora lì con i suoi errori. E noi, fra il corona-virus e il dopo, quali vie nuove stiamo inventando?