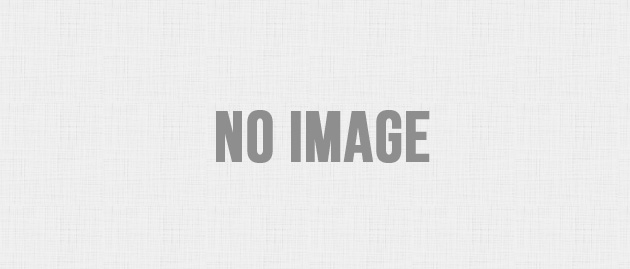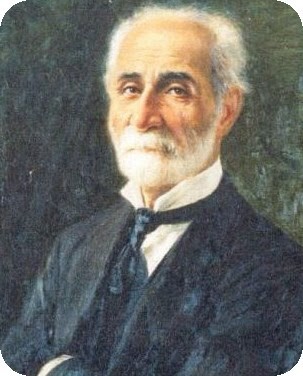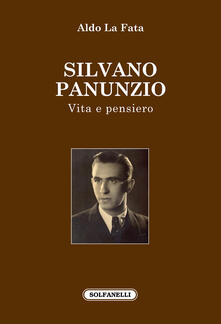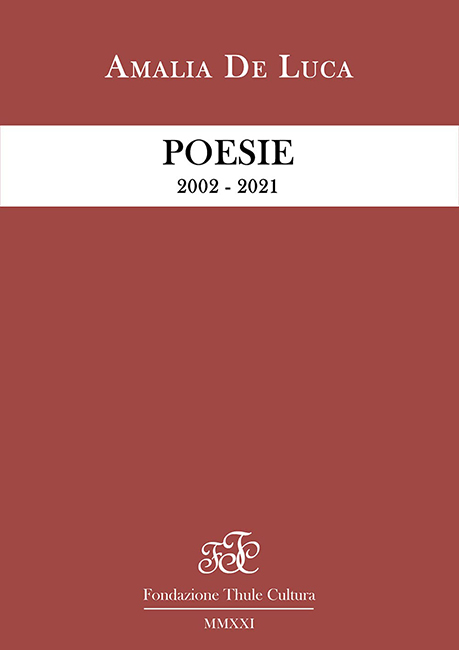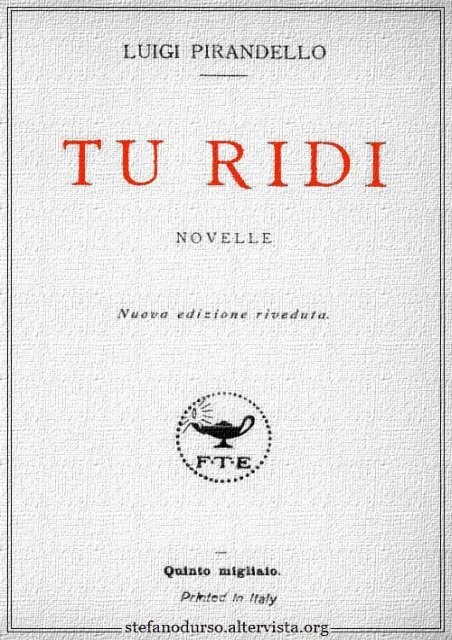L'età dei Patriarchi, ovvero la "policromia" della vecchiaia - di Tommaso Romano
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 24 Ottobre 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 241
In una celebre lettera di risposta al filosofo e narratore tedesco Ernest Jünger, il controverso pensatore Carl Schmitt scriveva: «La vecchiaia è finita, adesso comincia l'età dei patriarchi».
Una tale definizione per l'età estrema della vita, ci riporta immediatamente alla Bibbia, al libro sacro che rappresenta anche una radice antropologica profonda della vostra civiltà che, con buona pace di Rousseau, pur con tutti i limiti e le violenze, è sempre la grande acquisizione dell'umano cammino, non sempre rettilineo, tuttavia, e anzi, a volte, francamente involutivo.
Ma questa ciclicità, non ignota al pensiero filosofico del nostro Vico, ci riporta primariamente alle fonti della saggezza, a quel desiderio di verità che, insieme allo stupore, rappresenta la scoperta fondante della filosofia Occidentale.
Senza, in tal quadro, dimenticare il grande contributo che pensiero e saggezza di medio ed estremo Oriente hanno consegnato alla riflessione sulla condizione umana, sulla vecchiaia, fino all'opera portentosa di Raimon Panikkar.
Nel lungo viaggio verso la terra promessa, Mosè canta per esortare il popolo a mantenersi orientato sul volere di Dio, avendo come scintillante modello proprio la fedeltà degli anziani: Interroga i tuoi vecchi e te lo diranno (D. 32,7).
E ancora, nella Bibbia possiamo leggere: Presso gli anziani dimora la saggezza, e in una vita lunga la prudenza (Gb 12,12). In convergenza leggeremo anche ciò che il filosofo cinese Lin Yutang scriveva: A questo mondo non c'è nulla di più ammirevole che un uomo vecchio e saggio.
Possiamo allora parlare di una sorta di "policromia" della vecchiaia? Goethe scriveva a Carl F. Zelter: «Posso davvero sussurrarti all'orecchio la gioia che provo a motivo dei pensieri che insorgono in questa mia età avanzata, per dar retta ai quali e metterli in atto occorrerebbe un'altra vita intera».
A sostegno della buona vita, anche nell'età dei patriarchi, nel 1879 lo psichiatra, e pensatore tede co Heinrich Hoffman affermava: «Io non capisco perché tante persone si lamentano della vecchiaia e ne abbiano timore. Da parte mia nelle limitazioni che essa impone all'esistenza, trovo qualcosa di rasserenante, confortevole e pacificante. In quanto ottimista nato, considero questa fase della vita come la migliore a confronto di ogni altra finora sperimentata».
Certo, anche l'ultima e significativa stagione dell'esistenza, ha sempre bisogno di un significato, di un senso profondo, come ci insegna Viktor E. Frankl, ha bisogno di motivazioni, che nascono dall'accettazione individuale mista di gustare per intero l'attimo, il prezioso momento irripetibile, il giorno che pazientemente si conquista.
Per fare e questo occorre una vita insieme attiva e contemplativa.
Così si esprimeva il grande Blaise Pascal: «Nulla nell'uomo è così insopportabile come il ritrovarsi senza passioni, occupazioni o doveri. Sente allora tutta la sua nullità, la sua solitudine, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, Il suo vuoto. Ed ecco levarsi dal fondo della sua anima la noia e la malinconia, la tristezza, l'affanno, il cattivo umore, la disperazione».
Sicuramente, la nostra società consumista ed edonista, frutto della civilizzazione che pone al centro il denaro, l'utile e l'effimero, tende a considerare il vecchio – che non si atteggia a "giovane vecchio" o con pessima espressione altrimenti giovane - come ingombro, come una privazione alla presunta "libertà", come una imposta sopportazione, tanto da proporre, a volte, la rapida conclusione dell'esistenza del patriarca, ritenuto inutile a sé e agli altri.
Ma, in virtù di quanto appena detto, è il caso di ricordare in che misura sia stata considerata l'età finale dalle comunità tradizionali, specie contadine attraverso il valore di trasmissione e di sapienza che gli anziani incarnavano, insieme all'intangibilità e alla condivisione umana fino al sacrificio di sé che i vecchi suscitavano tanto da occupare un ben definito posto nel consorzio umano.
Oggi, in tempo di disprezzo e sottovalutazione della vita dal suo primo sorgere fino alle pratiche violente ed eutanasiche, la società presa dal primato dell’avere, ha perso ogni compassione e condivisione nei confronti non solo dei più deboli ma soprattutto dei vecchi.
Le offese, i soprusi, lo sradicamento dalle proprie dimore, i ghetti più o meno dorati dove spesso si depositano i vecchi, ne sono una ulteriore conferma, rispetto alla dimensione e misura della stabìlitatis che, in seno alla famiglia, voleva significare e rappresentare appartenenza, delicatezza, grazia portatrice di un immenso contributo immateriale proprio dei più anziani.
La perdita del concetto di unicità e irripetibilità dell'essere umano, si ripercuote così pesantemente anche nella perdita del modello solidarista e della pratica del rispetto verso le persone molto anziane.
Ancora, ci richiama la filosofia alla recta ratio, che nel libro biblico Siracide (25,4-6), coniuga la saggezza giudaica, il discernimento, con la sapienza greca; per ciò che riguarda - oltre il retto giudizio - anche le pratiche delle virtù che dovrebbero contraddistinguere le persone assai anziane: "Ai bianchi capelli s'addice il retto giudizio, / agli anziani dare il giusto consiglio. / Ai vecchi s'addice la sapienza, dagli uomini / eminenti ci si attende discernimento e consiglio. / Corona dei vecchi è la molta esperienza, / loro vanto è il timore del Signore".
Del resto tutta la sapienza greca e la filosofia stoica, si pensi a Seneca, apprezzavano in sommo grado la pazienza come virtù che può rendere gli uomini in grado di dominare le situazioni penose della vita.
Anche la libertà spirituale e la capacità di giudizio si manifestano come gli elementi dell'autorevolezza e come distacco nell'età dei patriarchi, insieme al valore del sentimento che non ha più paura di manifestarsi, fino al ritrovato stupore per la scoperta delle origini che si coniuga alla memoria del cuore (Raymond Saint-Jean), utilissima anche a combattere le paure, le ansie e la depressione, comunque, in tale età, sempre in agguato. Sostanza certamente importante per l'anziano è la rimembranza.
Sicuramente il ricordo è anche assenza, perdita, sconfitta che potrebbe provocare stati d'ansia e di instabilità nelle persone molto avanti negli anni.
Ma può avvenire anche il contrario, come afferma il filosofo Max Scheler: «Il ricordare è l'inizio della liberazione dal segreto potere della cosa ricordata o dell'evento richiamato alla mente».
Il ricordo come contemplazione, dunque, come «unico paradiso dal quale non si può essere scacciati», per dirla come il filosofo Jean Paul.
E non è tutto, Eva Jaeggi, partendo proprio dal concetto di "ricordo" ha anche trattato il tema del "trascendersi" come esperienza e superamento di sé, come mezzo dell'ironia, senza illusioni, in tutto lo svolgersi del l'età ultima: "quasi all'improvviso tutto diventa diverso. Io posso prendere le distanze dalla quotidianità, posso dimenticare le preoccupazioni, mi sento totalmente in me", posizione questa sposata e condivisa dalla filosofia clinica che reputa agevole, come eventuale, la via della vecchiaia per il raggiungimento della felicità.
Bernauon ha scritto che «l'infanzia e la vecchiaia estrema dovrebbero essere le due grandi prove per l'uomo», e Kirkegaard sosteneva che «la vecchiaia realizza i presentimenti della gioventù».
In realtà, è la vita stessa che per essere pienezza ha certo bisogno, come sosteneva Marziale, non solo della buona salute, che certo è indispensabile, ma di ben altro.
Notiamo, infatti, molti esempi di come si possa soffrire in tarda o tardissima età con esemplare consapevolezza e senza cadute nel rincrescimento e nel rammarico.
Vittorio Calogero ha scritto un testo dal titolo L'arte della longevità. Ovvero come capire che invecchiare è una vittoria e non una sconfitta (2010) in linea con l'antica saggezza che, rafforzando la pazienza che diventa virtù, è possibile dominare ogni controversia, contesa, disputa, ogni situazione, insomma, comprese nella logica della tardissima età.
Interessante, inoltre, è la posizione di Hermann Hesse il quale sostiene che «Nel giardino della vecchiaia sbocciano alcuni fiori di cui prima ben poco ci siamo curati. Germoglia, per esempio, il nobile arboscello della pazienza. Si diventa più rilassati, più indulgenti, e quanto minore si fa il nostro bisogno di intervenire e realizzare, tanto più s'accresce la capacità di osservare e ascoltare la vita della natura e dei nostri simili. E ciò senza il bisogno di criticare, ma lasciandoci attrarre con sempre nuovo stupore dalla sua varietà, talora con interesse e silenziosa partecipazione, talora col sorriso, con limpida gioia, con umorismo».
La condizione della vecchiaia estrema può rendere, dunque, più liberi di pensare e di dire con schiettezza le proprie opinioni. E' giusto il pensiero sulla libertà, come una delle virtù della vecchiaia, che il filosofo e teologo Grün così sintetizza: «L'anziano non sente più l'urgenza di rispondere alle attese della società nei suoi confronti, né di giudicare sé stesso in base alle proprie realizzazioni».
E, ancora, il pensatore tedesco afferma come un vecchio sappia riandare con memoria riconoscente «alle cose belle e buone che hanno interessato la trama della sua vita, - e che considera come un tesoro prezioso che nulla e nessuno può sottrargli - ha una ragione in più per sentirsi serena mente grato anche per ciò che caratterizza la sua vecchiaia. Nonostante la prova ardua rappresentata dalla solitudine, dalla debolezza o dalle malattie, egli prova gratitudine per quello che ogni giorno riceve in dono: può ancora alzarsi e camminare, parla con altre persone, si gode lo splendore del sole, gioisce perché figlio e nipoti stanno percorrendo una buona strada ecc.» e, contemporaneamente, sappia gustare la via del silenzio "qualità del puro essere" che nella vecchiaia si affronta, rafforza l'attitudine alla contemplazione che parla altri linguaggi ancor più profondi della parola a volte vacua e consolatoria: «Il silenzio è un riflettere su ciò che è stato e su ciò che è. E anche il tacere davanti al mistero della vita e della morte».
Poco tempo prima della loro morte in avanzatissima età molti filosofi si sono interrogati sullo scorrere della vita, sulla speranza, sulla paura e la morte, e tuttavia, ammonisce Karl Rahner, «La vita che ancora ci rimane va pienamente vissuta», aldilà di ogni paura di ogni speranza di ogni possibile spiegazione razionale circa la nostra stessa esistenza.
«Non mi sbigottisce la morte» diceva Machiavelli «se si passeranno almeno quattro ore al giorno con i testi dei maestri della filosofia e della letteratura».
Il celebre filosofo e analista junghiano James Hillman, si è posto un altro nodale problema del nostro tempo, ovvero l'implacabilità con gli anziani avanti negli anni e spesso afflitti da sofferenze.
Così dichiara polemicamente nel suo libro La forza del carattere: «Il disprezzo per i valori generalmente associati alla vecchiaia diminuisce il valore della persona anziana. Nel contesto di questa sottrazione di valori ci viene più facile giustificare il geronticidio. Lo chiamiamo liberarli dalle loro pene e lo copriamo con espressioni più asettiche come evitare l'accanimento terapeutico, eutanasia, accelerazione della morte e suicidio assistito». È, in sostanza, quella negazione della vecchiaia tipica della società edonistica, vecchiaia percepita come malattia (in ciò è insita l'ineluttabilità) e quindi come problema che va affrontato dal punto di vista medico e/o dall'assistenza domiciliare, escludendo quelle misure della civiltà dell'amore che un grande vecchio come Giovanni Paolo II, seppe indicarci come strada luminosa di autenticità e di ascolto.
Lo storico e pensatore Carlo Maria Cipolla, ci ricorda a proposito che «nella società agricola il vecchio è saggio, in quella industriale un relitto». Nel 1970, Simon de Beauvoir, celebre scrittrice e filosofa, compagna di Sartre, sosteneva che la vecchiaia è divenuta un problema, proprio perché la società odierna ha mitizzato la giovinezza, creando una categoria di emarginati, in un clima, aggiunge il filosofo e teologo italo-tedesco Romano Guardini, di materialismo senile.
Paolo Montegazza, positivista ottocentesco, scrisse un bel libro intitolato Elogi della vecchiaia in cui sosteneva che l'estrema condizione della vita è l'igiene della filosofia con cui questa va affrontata, avendo imparato «con lunga e spesso dolorosa esperienza che molte seccature sono necessarie condizioni della vita, e che il volerle abbattere con la violenza è lo stesso che dare un pugno ad un tronco, che ci contende il cammino. Il tronco rimane al suo posto e la nostra mano ne rimane ferita o storpiata. E il vecchio si guarda bene dal voler abbattere la pianta, ma la gira, continuando il suo cammino. Il giovane quando coglie le rose è ben raro che non si punga e non ne abbia insanguinate le mani. Il vecchio coglie le rose e non si punge mai (...). Egli ha anche imparato a sue spese che nulla è più prezioso del tempo e le ore o i giorni spesi nel lamentarsi sono una pura perdita del più prezioso dei capitali».
Certo, come ci ammonisce Schopenhauer «vista dai giovani, la vita è un avvenire infinitamente lungo. Vista dai vecchi, un passato molto breve» e tuttavia è proprio Cicerone a ricordarci che «come approvo il giovane in cui ci sia qualcosa di senile, così il vecchio in cui ci sia qualcosa di giovanile, chi si attiene a tali norme potrà essere vecchio di corpo ma non lo sarà mai di spirito».
Nicolò Rosario Lombardo ne Il senso della vita in età adulta e avanzata parla opportunamente di un'Etica del senescente ove è da «porre nella accoglienza della cosa in gioco, cioè della senescenza medesima, per quel che essa già è. Questo implica una benevola interpretazione della condizione di senescenza come di un'età della vita che ha un proprio tipo di risorse», onde vivere serenamente il traguardo, anche usando come strumento terapeutico il libro, per il quale «occorre una decisione, una scelta: occorre leggerlo».
Ecco, in sostanza attraverso le note su esposte come il perenne insegnamento che la filosofia ci dona sull'età dei patriarchi, possa rappresentare una sorta di estrema prova per l'uomo (Bernanos), a condizione però di conseguire un'auto formazione indirizzata verso la saggezza fatta di esperienza, di sensazioni sempre e pienamente da gustare e da vivere come stupore e scoperta, alla ricerca di quel senso che non si riduce solo alle "parole in libertà" che si sprecano sul tema o peggio all'ingannevole pubblicità. Saper cogliere e praticare pienamente questa dimensione dà misura sia della filosofia che della stessa vita e, contemporaneamente, rende divina, come diceva Giuseppe Maria Sciacca, quella apparente inutilità che sembra essere ai più la filosofia.
In nessuna età, comunque, non s'arresti mai il battito per raggiungere poi la scintilla, per percepire l'Eterno.