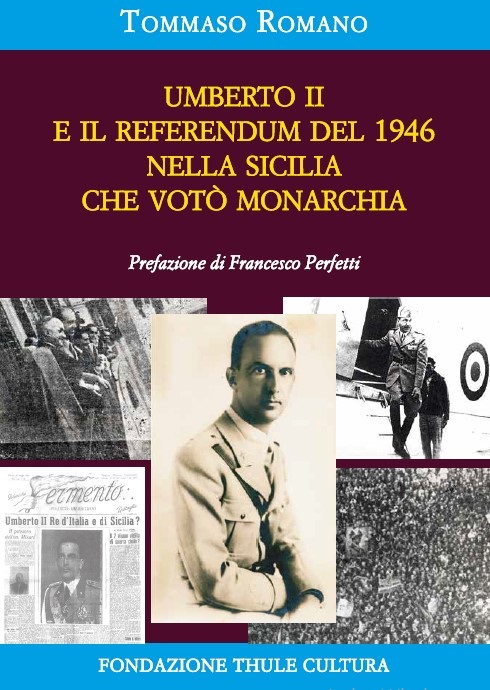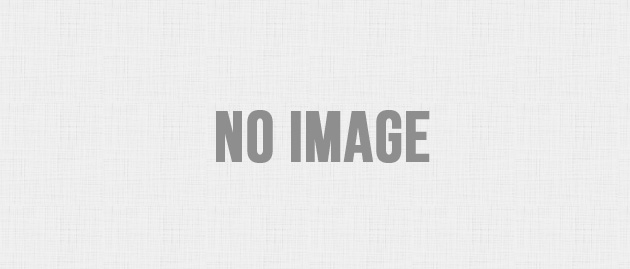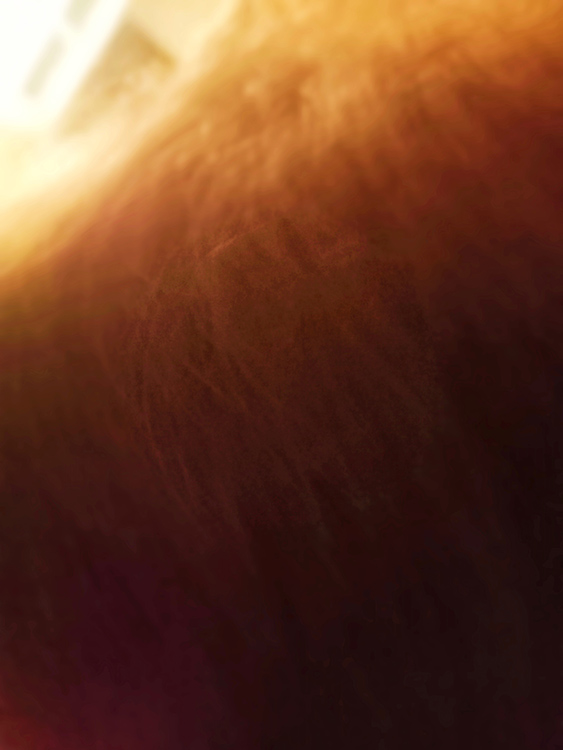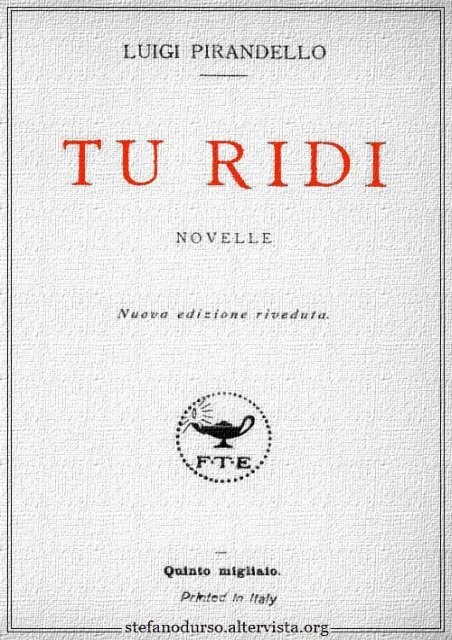"Intervista a Tommaso Romano" a cura di Salvatore Vecchio
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 19 Luglio 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 970
Poeta, filosofo, storico e critico. Tommaso Romano è uno scrittore dai molteplici interessi. Non è il caso di elencare le sue opere che superano il centinaio. Come poeta ricordiamo L’airone celeste (2018), del filosofo dialogante l’Essere nel Mosaicosmo e Il mosaicosmo nell’infinito (2021), dello storico Sicilia 1860-1870. Una storia da riscrivere (2011), del critico La Divina Commedia dipinta da Madè (2013) e L’indispensabile e creativa libertà (2021). Di lui si apprezza anche il collezionista. Romano ha nel centro di Palermo un salotto invidiabile, ricco di oggetti e opere di valore, a cui ha dedicato se stesso, oltre che un romanzo (La casa dell’Ammiraglio), dove trapela l’amore e la dedizione di tutta una vita per l’arte.
1. Ne l n . 3 - 4 , 2023 di Spiragli (www.rivistaspiragli.it) abbiamo pubblicato una pagina molto interessante dal titolo: «La parola dell’essere del mosaicosmo. La poesia è». In poche parole, essa è come un’àncora di salvezza per gli uomini. E lei ne parla in modo esemplare e bello. Mi chiedo, e chiedo: all’atto pratico, è proprio così? Pensa che la poesia assolva ancora la sua funzione di intermediaria tra l’uomo e il mondo?
Sono convinto che non solo nel mondo, ma anche negli altri esseri, la parola è sempre stata la levatrice delle cose del mondo. La parola è la scintilla del divino. Ci viene in aiuto Sant’Agostino, quando afferma che la parola è un modo con cui Dio si manifesta alle sue creature, un Suo riflesso. Un esempio lo si può cogliere nell’elezione di papa Leone XIV; nella sua parola già da subito si è notato un cambiamento di rotta che ci porta alla Chiesa di Gesù, in quella in cui siamo cresciuti e vissuti, e in cui ci riconosciamo, la Chiesa della pace, della fratellanza e del rispetto reciproco. Ci sono volute le prime parole di papa Leone per ridare fiducia ad un’umanità sfiduciata, barcollante, bisognosa di quella parola che dà sollievo e speranza. La conoscenza non è dovuta e non è da ricercare soltanto nel divenire storico, bensì nella conoscenza naturale del divino che è in noi e nelle cose; in essa c’è la scintilla del divino che assume anche la funzione di salvezza e ci apre alla bellezza delle cose e del mondo.
2. A proposito mi viene di pensare a Walt Whitman che intitola un suo componimento La poesia salverà il mondo, ma anche e soprattutto ad Heidegger, che dà risalto alla parola poetica, perché spinge a dire il non detto. Sicché fa del poeta un sacerdote. Dobbiamo essere fiduciosi?
Sono realista più che fiducioso, anche considerando la decadenza dell’uomo e del mondo in cui stiamo vivendo, un mondo di ladrocini e di guerre che si stanno consumando in Occidente e in Oriente, senza rispetto per nessuno, bambini compresi. Ho i miei dubbi. Ma per il mio credo individualistico, la salvezza individuale, al di là di ciò che si dice e si propone, al di là del successo, non può essere scissa dal bene comune. Certo il poeta - come scrivo nel pezzo che avete riportato - possiede la chiave della sintesi giusta e per questo può incidere in profondità nell’animo dell’uomo più di ogni altro artigiano della parola o di qualsiasi atto creativo, senza per questo assumersi o sentirsi investito da compiti profetici o salvifici, ma rendendosi possibile strumento di un disegno di Dio. La persona per dare senso alla vita deve essere soprattutto se stessa nel momento in cui si immette in un percorso di conoscenza, e solo così può tendere verso l’impensabile, dare veramente senso alla sua vita, una e molteplice, che fa dell’uomo la creatura più importante dell’universo e del creato.
3. Indirettamente siamo entrati nell’ambito del Mosaicosmo, termine di sua coniazione: mosaico che presuppone dei tasselli o, meglio, delle tessere, e cosmo, lo spazio celeste, l’universo. Questo neologismo si carica di una filosofia, della sua filosofia, che assomma il particolare e l’universale, l’uomo e Dio, riduce le distanze e fa partecipi della vita del mondo. È così?
Ognuno di noi, anche se compie delle azioni minime che sembra non abbiano alcun riscontro, partecipa e dà un suo pur minimo contributo a quello che è un contesto generale e totalizzante. Il tutto rientra nella visione del mondo come un mosaico, non accozzaglia di tasselli, ma come armonia e bellezza. Perciò ogni attività si ascrive in una dimensione universale, celeste e quindi ha una sua peculiarità, un fondamento. Bisogna tener conto del presente, non trascurando però le nostre radici. Questa realtà, a cui tendiamo, si compone di due aspetti, l’individuale e il collettivo. Così il presente si carica di valore, e l’uno tende verso l’altro e viceversa. Non c’è un cambiamento puro e semplice. Socrate ci insegna ancora molto. Il carpe diem, vero, coglie il presente, ma invita pure a guardarsi dentro con il risultato di una capacità di vedere il mondo senza ideologie. Allora da questo punto di vista il mondo ci appare sotto altre sfumature, lo vediamo con occhi diversi, magari con una certa ironia, proprio per tenere lontano il disagio esistenziale.
4. A suo tempo ho letto con piacere le 7 Tessiture dal Mosaicosmo (2008). Sono una chicca di pensiero che compendiano il Mosaicosmo e in sintesi lo avvicinano a tutti. Può dire ai nostri lettori qualcosa a riguardo?
Innanzitutto queste Tessiture sono il manifesto del mosaicosmo; un riassunto essenziale in cui ho sistematizzato la teoria che ora si è concretata nello scegliere le pagine più salienti del mio pensiero, della mia biografia che ha, come tutte le altre, la sua importanza, perché traccia un sentiero, pur minimo, nel grande mosaicosmo. La storia ne è una obiettiva sistemazione tramite la ricerca e i documenti che sono indispensabili, e vanno filtrati per dare voce ad un’esperienza (fare poetico, letteratura, storia, arte), non alla maniera di Adorno, antagonista e cangiante, ma considerarla una tessera, da aggiungere ad un grande mosaico. È la singolarità dell’uomo che entra nel grande mosaico della vita, tutto ciò che egli ha compiuto e compie, essendo dotato di libero arbitrio. Un es. è che l’uomo sta facendo un passo avanti con l’utilizzo dell’AI, fondamentale, utile per fare ricerca. Così come è utile il lavoro che ha fatto Antonino Sala (Glossario unificato del mosaicosmo di Tommaso Romano secondo l’Intelligenza Artificiale, Ex Libris, Palermo 2025). Chi non conosce il mio pensiero e la mia opera vi trova tutti i presupposti per conoscermi e iniziare un percorso di lettura dei miei scritti. Come in tutte le cose, certo, l’AI avrà certamente i suoi lati negativi, che sono da scartare. Ciò che conta è cercare il bene e il meglio, come il parlarne, metterla in discussione, dare risalto alla ricerca. Tutto ciò che l’uomo compie deve essere usato per il bene dell’umanità. Dinanzi all’innovazione non bisogna tirarsi indietro e etichettarsi per tradizionalisti. Pur con i rischi che essa può portare con sé, l’importante è agire con cautela, evitando il male. Perciò faccio mia l’affermazione di Popper: la paura del male non mi appartiene.
5. Rimanendo in ambito filosofico, si è tanto occupato della libertà e delle libertà. Riporto il titolo di un suo libro sopra ricordato (L’indispensabile e creativa libertà), riferito alla libertà di espressione di ogni creativo, ma soprattutto mi riferisco al lavoro Reagire per le libertà (2022), in cui ha coinvolto tante personalità. Un libro da fare circolare e consigliare a tutti, interessante specialmente ai nostri giorni in cui le libertà, tante volte anche abusate, sono in pericolo. A lei la parola.
Assolutamente così! Naturalmente la libertà che si pratica molto spesso lascia a desiderare, cade nell’eccesso e, come scrive Zolla, si cade nella volgarità che è delirio, rappresentazione di un malessere abbastanza diffuso che spesso sfocia nella violenza fisica, tutto il contrario della libertà, intesa anche come responsabilità. La libertà è cultura del limite, rispetto dell’Altro, linguaggio, purità della parola. In sostanza, occorre costruire ponti, non muri. Libertà è ritrovare il senso della propria individualità, dare forma alla propria creatività e al tempo stesso tendere verso l’Altro, facendo lega con chi lavora per il bene comune, essendo entrambi votati al bene dell’umanità. Ciò comporta l’impegno costante che ognuno di noi deve portare avanti per una renovatio che sia di apertura verso i giovani e indurli ad una vita più sana, autentica e li porti a riscoprire la spiritualità, la buona lettura, l’Altro. È necessario aprirli al bene, perché possano realizzarsi secondo il loro modo di vedere e sentire una scintilla interiore che li porti ad essere pezzi unici, non servili, a circondarsi di cose belle, anche nella propria casa, contro le brutture odierne e le guerre.
6. La realtà è che stiamo vivendo un periodo brutto in tutti i sensi. Guerre e scompensi sociali enormi, arroganza dei detentori di potere, un Nuovo Ordine Mondiale che si vuole attuare a tutti i costi, a scapito delle nazionalità esistenti con lingue, religioni, costumi diversi. Cosa si vuole, una nuova Babele?
Una nuova Babilonia, o Babele, è in atto non solo nella proliferazione delle guerre, ma nella perdita delle identità specifiche delle nazionalità, negli eccessi dei particolarismi, nelle difficoltà in cui si trovano i singoli. Lo Stato che garantiva un’educazione condivisa non è più educatore; al suo posto tante agenzie fanno confusione e disorientano. Lo Stato e la famiglia, anche in maniera minima dovrebbero esercitare autorevolezza nelle loro funzioni e il tutto per il bene comune che possa riscrivere un diritto naturale, il diritto della natura. Occorre riscoprire i diritti fondamentali. Non c’è bisogno di un super Stato, non ne abbiamo bisogno; ciò che occorre è unità nella diversità tra le nazioni, che è sale della vita dei popoli, non legati a un dirigismo autoritario. Per questo bisognerebbe incentivare la cultura, cercare nella tradizione occidentale la civilizzazione con tutti i rischi conseguenti (miti, rivoluzioni, imperialismo arrogante). Ma ci vogliono voci che suggeriscano la via e aprano ad un vero dialogo, cosche nella realtà non c’è; nessuno si mette in discussione e la sintesi è quella che manca. C’è bisogno di riscoprire le fonti ottimalizzanti di questa nostra civiltà e il senso di religiosità che è rispetto dell’Altro, una dimensione di profondità. L’uomo deve riscoprirla tramite la filosofia, il pensiero, la sintesi: un modo per cambiare noi stessi e al tempo stesso realizzare un mondo migliore.
7. Come storico si è occupato di tante problematiche inerenti alla storia in generale e a quella siciliana in particolare. È stato ricordato Sicilia 1860-1870, ma molto interessanti sono tanti altri tuoi scritti, fra cui Dal Regno delle Due Sicilie al declino del Sud (2010), Vittorio Amedeo di Savoia Re di Sicilia (2013; 2020), Contro la rivoluzione la fedeltà (2012; 2021) che aprono alla verità dei fatti. Bene, storicamente parlando, tanto è stato desecretato e scritto, a proposito della Sicilia, eppure si continua a propinare il falso storico, riportandolo anche nei libri di scuola. Sono ancora pochi 150 anni dall’unità d’Italia o è destinata ad essere «storia da riscrivere»?
Tutta la storia è da riscrivere. Essa - come afferma Giuseppe Parlato - è revisione, ricerca assoluta delle fonti. Lo storico che si affida soltanto a riepilogare scritti di altri, etichettandoli con la propria ideologia, non fa storia, ed è in contraddizione con il suo corso effettivo che, come suggerisce S. Tommaso, è un intreccio di eventi voluti dall’uomo e predeterminati da Dio. In essa ci sono costanti e eccezioni, perciò bisogna guardare ai disegni complessivi. La storia d’Italia, come altre storie, è interessante e ricca di intuizioni. La vita è una costante in cui l’uomo si dibatte tra l’eccesso e la possibilità, il tornacontismo e la spinta al bene collettivo. L’opera di revisione non può trascurare la biografia. Gli uomini che in prima persona hanno agito devono avere il loro spazio nel fare storia, perché furono determinanti e devono essere messi in discussione per meglio comprendere e entrare nel vivo della storia. Scrivendo del Regno di Sicilia non si può fare a meno di soffermarsi sulla figura e l’opera del conte Ruggero, a cui la Sicilia tanto deve in termini di politica, di religione, cultura e arte. Così come, per es., non si può parlare di una civiltà arabo-normanna, ma normanna con contributo dei Berberi. Certo, siamo in presenza di tante ombre, che sono anche presagio di luce. Altro particolare da non trascurare è che la storia va trattata come storia degli uomini. Napoleone nel bene e nel male è stato Napoleone e così tanti altri che la storia hanno fatto. Churchill, ad es., convinse l’America ad entrare in guerra. La storia così prese una svolta diversa. Non credendo alla storia fatta dai popoli, bisogna dare credito alle personalità. Ma un dato di fondo è il metodo. Non si può parlare di Umanesimo, se non si mette a fuoco, per es., la personalità del Petrarca, così come del Rinascimento che tanto diede alla cultura e all’arte, se non si studiano gli uomini illustri che lo hanno nobilitato con le azioni e le opere. I maggiori nomi dell’unità d’Italia, Cavour, Minghetti, ed altri, con pregi e difetti, si sono adoperati per un disegno a cui diedero anima e corpo. Eppure chi dice la verità viene sempre attaccato. Ricordo, a proposito, l’incontro di Don Fabrizio con Chevalley. Io, Tommaso Romano, sono dalla parte di Chevalley. Nel Gattopardo si delinea in chiare note la filosofia della rinuncia.
8. Nel volume su Vincenzo Mortillaro, Contro la rivoluzione la fedeltà, fa luce su un uomo e un intellettuale che tanto fece e soffrì per il bene della sua terra, di cui lasciò testimonianza con l’azione e le opere in parte riportate, e tuttora esempio di vita “intransigente” e di libero pensiero. A chiusura del saggio, così sintetizza: «Mortillaro testimonia, afferma e contraddice. Da uomo libero, affidando fedelmente le sue certezze, la sua dottrina, le speranze, i disinganni, i tradimenti alla considerazione sulla natura dell’uomo e sul crollo paventato, ma che gli appare ineluttabile, della civiltà». È proprio così?
Di Mortillaro (1806-1888) si ricordano soltanto alcune opere di letteratura e di arabistica, non quella storica che invece è molto ricca di spunti e considerazioni che fanno comprendere meglio di altri l’Ottocento siciliano. Quello che preme evidenziare è l’uomo Mortillaro, coerente con le idee e l’attività che lo distinsero, con lo spirito di servizio verso la Sicilia, per cui patì ingiustizie e il carcere, ma sempre fedele al re e alla sua terra, che non volle mai abbandonare anche nei momenti più difficili. Intellettuale libero, ha messo in luce fatti e momenti abbastanza cruciali della nostra storia, in special modo quella che stava vivendo in prima persona. Egli ha saputo controbattere alcune affermazioni di Michele Amari sia per ciò che riguarda la storia araba in Sicilia, a proposito della Storia dei Musulmani di Sicilia, ove ne esalta la superiorità, quando invece, semmai - come ho detto poc’anzi -, bisogna dare merito ai Berberi, sia per il pregiudizio anticristiano che tanta storia ha condizionato. Perciò Mortillaro lo contraddisse e se lo fece acerrimo nemico, ma rese omaggio al cristianesimo che, nonostante tutto, rimase come un faro di luce per la popolazione. Così facendo, attaccò duramente non solo l’anticristianesimo di allora, ma anche quello di oggi. Questa di Mortillaro è una figura di uomo e di intellettuale che per il suo trascorso politico di fedeltà alla Sicilia e ai Borbone è stata accantonata, perché scomoda ai tanti che per buona o mala fede si aggrapparono al carro dei vincitori. È tempo di una revisione (ed io sto cercando di iniziarla con questo volume) che metta pienamente in luce l’uomo pubblico e il letterato che, come sicilianista e indipendentista, diede il meglio di sé per il bene della Sicilia e della sua gente.
9. Sempre se ritiene, sta lavorando su che cosa, può anticiparcela?
Sto lavorando al riordino e riepilogo delle mie opere, di quella che è stata la mia vita di uomo e di poligrafo, per mettermi in discussione e aprirmi agli altri, per affermare o modificare certe mie opinioni. Al momento sono usciti i primi due volumi (Il mosaicosmo nell’infinito. Testi dal 2008 al 2021 e Imprescindibili. Elogi ammirati in punta di penna) e ne seguiranno altri, in tutto 10, che saranno pubblicati nella collana Omnis in verbis diretta da Carlo Guidotti per Ex libris edizioni. Questo lavoro serve a rivedere il mio pensiero e la mia attività concrete, a mettermi - ti dicevo - in discussione, senza niente rinnegare , ma rivisitare il tutto ed eventualmente correggere. Coerenza, un modo di essere, dall’attività artistica degli inizi a quella filosofica, poetica, e nei confronti dei miei interessi. Il tutto può servire a conoscere meglio ciò che è umano, verificare il consenso e se è accresciuto negli anni. Il materiale si conosce, interessa un pò tutto: arte, filosofia, poesia, aforismi. Esso può dare la sensazione di un processo, una possibilità di verifica delle mie idee. Ho fatto ciò che ritenevo giusto e per mettermi, ripeto, in discussione. La mia è una revisione a cui saremo sottoposti dalla storia. Perciò, faccio mio quanto disse Cristina Campo: «Ho scritto poco e avrei voluto scrivere meno». Grazie! Buona vita e buon lavoro.
in: "Spiragli - Rivista di arte, letteratura e scienze diretta da Salvatore Vecchio", Nuova serie - anno VI, 2025, NN. 1-2