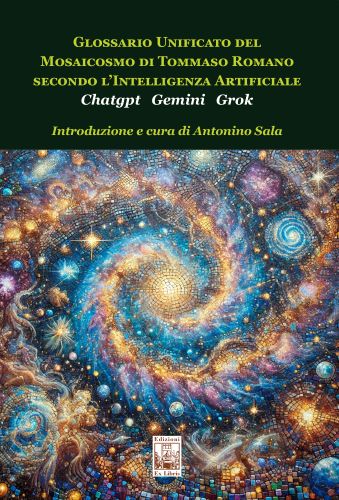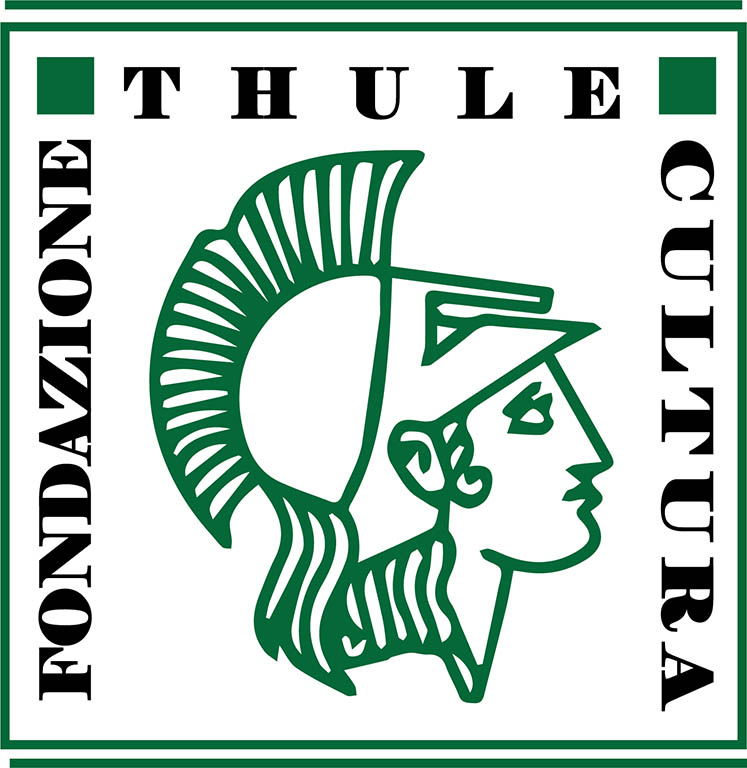Giuseppe Pappalardo, "I versi e le parole" (Ed. Thule) - di Giuseppe Modica
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 15 Luglio 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2168
 Avevo letto le poesie dialettali di Pippo Pappalardo e ne ero rimasto preso soprattutto per la freschezza dell’ispirazione costantemente coadiuvata da un uso sapiente, colto, del dialetto. E ciò me lo aveva reso simpatico poiché l’ho assimilato idealmente alla scuola di Paul Valéry, allorché il poeta francese sostiene che i versi si elevano al rango di poesia quando l’estro dell’ispirazione è sorretto dalla fatica dell’elaborazione, poiché quello senza questa è solo pressappochismo e questo senza quella è mero artigianato.
Avevo letto le poesie dialettali di Pippo Pappalardo e ne ero rimasto preso soprattutto per la freschezza dell’ispirazione costantemente coadiuvata da un uso sapiente, colto, del dialetto. E ciò me lo aveva reso simpatico poiché l’ho assimilato idealmente alla scuola di Paul Valéry, allorché il poeta francese sostiene che i versi si elevano al rango di poesia quando l’estro dell’ispirazione è sorretto dalla fatica dell’elaborazione, poiché quello senza questa è solo pressappochismo e questo senza quella è mero artigianato.
Quando però lessi Çiuri di notti – che, in ordine di tempo, è la sua ultima silloge in dialetto – la simpatia si trasformò in congenialità poiché è qui che il linguaggio poetico di Pappalardo diventa compiutamente "lingua del cuore", espressione di una intimità senza intimismo, d’una coralità pudica e silenziosa, d’una commozione sincera e, dunque, aliena da ogni retorica.
Ora però il poeta sfida se stesso cimentandosi, per la prima volta, con la poesia in lingua italiana (I versi e le parole) e lo fa con spirito "esplorativo", convinto che non tutto possa essere espresso nel dialetto, ossia attraverso stilemi tenacemente ancorati a una dimensione per così dire "domestica" e, perciò, lontana dalle convenzioni ideologiche proprie del post-moderno. E, da questo punto di vista, se il siciliano è la "lingua del cuore", l’italiano sembra attestarsi come la "lingua del pensiero", quasi uno sguardo più consapevole e avvertito della realtà circostante e dei modi che essa suscita in chi la osserva.
Sbaglierebbe, tuttavia, chi riscontrasse qui una sorta di rottura con la produzione precedente, quasi che la "lingua del pensiero" fosse una sorta di siciliano dirozzato, purificato da cadenze e cantilene e tradotto in bella copia per animi puri. Infatti I versi e le parole di Pappalardo, ben lungi dall’essere una traduzione dal siciliano, si attestano come un diverso modo di far parlare, ancora una volta, il cuore. Non a caso gli elementi che connotano e conferiscono una identità alla silloge sono le "similitudini" e la "rima". E sono proprio queste ricorrenze stilistiche a dar voce alla dimensione del cuore, svelandone, anzi, un tratto nuovo e inaspettato.
Si tratta infatti di un cuore “infantile", che è il sentimento di chi, non sapendo ancora parlare (in-fante, appunto) "sente" la parola come una conquista da realizzare. E poiché, prima ancora di imparare a parlare, l’uomo primitivo canta (secondo la celebre lezione vichiana), il bambino – precisamente come il primitivo – cerca il canto del verso, la parola che - proprio attraverso le similitudini e la rima - si fa poesia. È qui che il cuore infantile svela una insopprimibile creatività.
Certo, l’anima del poeta custodisce fremiti tormentati, moti incandescenti che non trovano requie: i versi e le parole sono «il grido acuto di un cuore abusato…» e «fermentano nel cuore come un vino che dorme nelle botti» quando la fugace vita della rosa mostra «l’inclemente legge primordiale che spegne le illusioni degli umani». E però il bimbo nascosto dentro quei meandri non demorde e non cessa di spargere luci di trepide attese, ché «apparirà l’azzurro dopo l’arcobaleno».
E se è «inutile cantare inni alla luna se pure la speranza cede al vento, a questo intollerabile tormento di una vita che fugge e che si abbruna», sempre «in alto ricomincia il vagabondo falco a volare». È in questo incessante inseguirsi di sentimenti tra loro uguali e contrari che la poetica di Pappalardo rinviene il contrassegno della propria peculiarità e, rispetto alla produzione dialettale, il profilo d’una sostanziale continuità.