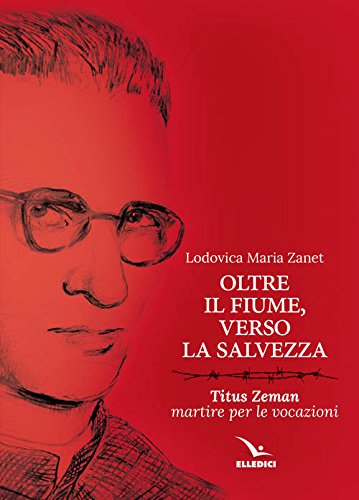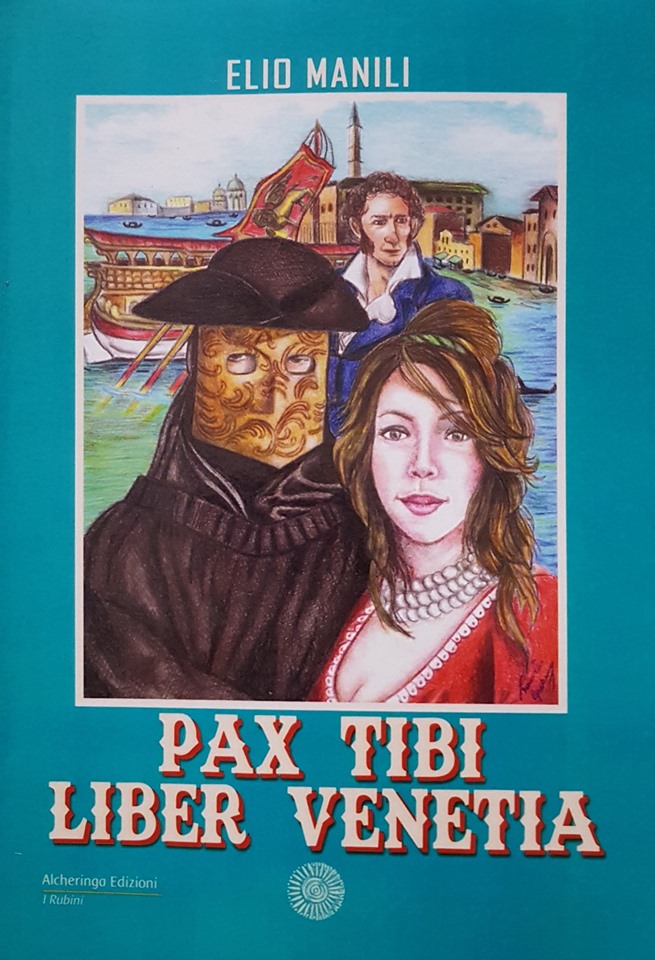Giuseppe Pappalardo, “Çiuri di notti” (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 01 Giugno 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1765
 di Giovanna Sciacchitano
di Giovanna SciacchitanoQuale mezzo migliore se non la poesia per stemperare l’amarezza che il poeta vive nella dialettica tra l’essere persona con le sue relazioni sociali ed affettive e l’essere individuo che si riconosce nella sua solitudine e nelle sue zone d’ombra? Ed è proprio incontrando questo buio, questa solitudine, che Giuseppe Pappalardo elabora pensieri di cui ci fa partecipi e diventa portatore di luce. Per questi motivi ritengo assolutamente centrato intitolare la sua nuova raccolta “Çiuri di notti”. La prima delle trentasei poesie presenti nel volume, edito da Thule Cultura, è incipit a una narrazione poetica che è incontro con la parte più intima e profonda di Pappalardo e con quello spazio in cui il poeta si rifugia per incontrare se stesso. Il filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne diceva che «bisogna riservarsi un retrobottega tutto nostro … nel quale stabilire la nostra vera libertà». I çiuri di notti sono fiori notturni, belli ed eleganti, e vengono fuori con l’oscurità della notte, così come i pensieri del nostro poeta. Pulsioni di vita che mirano alla bellezza di uno sbocciare di zagara o al soave canto dell’usignolo, pensieri che esprimono una forza vitale notevole, pur nella consapevolezza di una possibilità che deve scendere a patti con un destino a volte pieno di ombre: Sta vita è meli e zùccaru pi-mmia / mi ntrica, mi ncatina, mi mpircanta. / Di nfunnu fridda l’ummura mi talìa. (dalla poesia “Çiuri di notti”).
Scrive in dialetto, Giuseppe Pappalardo; un dialetto che è sintesi di contaminazioni fonematiche che provengono da aree geo-linguistiche diverse, quali sono quelle della Sicilia orientale e quelle della Sicilia occidentale. Sappiamo che Pappalardo è nato a Paternò, in provincia di Catania, e che negli anni giovanili si è trasferito a Palermo, dove risiede e opera. E soprattutto che l’autore non ha mai trascurato la sua continua, attenta e proficua ricerca linguistica. Ha analizzato nel tempo testi di autori siciliani, del passato e contemporanei, ed è giunto a elaborare e a scegliere un suo personalissimo registro poetico che usa il dialetto, come lui stesso ci dice, «per la sua capacità di evocare suoni, sensazioni, emozioni che la lingua italiana non sempre riesce a rendere con pari efficacia e intensità». Partendo dal bisogno di sganciarsi da strutture linguistiche pre-ordinate, dunque, Pappalardo affida al dialetto, in quanto «lingua degli affetti», i suoi stati d’animo legati ai suoi vissuti e alla presente condizione esistenziale, riconoscendo in esso la capacità di veicolare, attraverso la poesia, una grande carica emotiva ed espressiva. Leggendo le liriche presenti nella raccolta “Çiuri di notti” si ha la chiara sensazione di percorrere, insieme al poeta, visioni e sentimenti che si ricompongono in un mosaico le cui tessere sono tappe necessarie a un suo cammino interiore. A volte il nostro poeta non si identifica con il rumoroso dinamismo del flusso della vita e nel silenzio di una solitudine, spesso non scelta, ci rivela con lirica affabulazione i suoi paesaggi del cuore: Di iornu, / né risettu e mancu abbentu. / Ma quannu stenni l’ali / mmizzigghiusa / la notti, / ddu celu stiddi stiddi, / ddu silenziu, / mi sciògghinu li cordi di lu sènziu … (da “Lu iornu, la notti”). Versi dolcissimi che ricordano il poeta dialettale Ignazio Buttitta, quando parla del silenzio come condizione fondamentale per la creazione poetica. E penso, ancora, ai «sovrumani silenzi e profondissima quiete» che hanno dato origine all’idillio più bello e famoso del grande Giacomo Leopardi.
Nella prima delle quattro parti in cui sono distribuite le composizioni di Giuseppe Pappalardo (che porta il titolo della raccolta stessa, cioè “Çiuri di notti”) si rintraccia subito la relazione profonda tra l’Io del poeta e il silenzio. Ed è questa relazione che permette all’autore di riconoscere nel morso amaro del destino la consapevolezza di essere solo, cchiù sulu di la luna, a barcamenarsi nelle situazioni più o meno difficili che la vita gli presenta. In questa prima parte il poeta si pone profondi interrogativi sul senso della vita, interrogativi che a volte rimangono senza risposta ma che, con la complicità della notte, creano, come scrive Aldo Gerbino nel saggio introduttivo al volume, una dimensione in cui «il gioco umbratile delle cose, il fruscio dei pensieri corrono e s’inseguono per attaccarsi all’anima e stimolare la riflessione»: La luna stasira / mi fa cumpagnia / e lu silenziu / di li stiddi ncelu; / un cantu luntanu / m’accuccia e quadìa, / un mutu ricordu, / di lacrimi un velu. (da “Pinzeri”).
Giuseppe Pappalardo ci parla di sé, delle sue malinconie, delle sue certezze, delle sue fragilità, ma sempre fedele al sentire dell’amore in tutte le sue declinazioni. L’amore come unica sorgente cui attingere per dare senso agli accadimenti della vita e trasformarli in etica dell’amore. Il poeta ci sprona «a tornare a pensare con il cuore, senza barriere, preconcetti o tabù e senza altro dogma che la ricerca costante del Bene» (V. Mancuso “Il bisogno di pensare”). Per quanto detto, i versi del nostro poeta diventano a volte denuncia civile nei confronti di una società che non riesce a contenere le numerose violenze e discriminazioni su uomini e donne ai quali viene tolta non solo la dignità della persona ma, spesso, anche il diritto di vivere. Nascono così versi pregni di amarezza e al contempo di generosa speranza per un mondo dove, riconoscere e rispettare l’altro, diventi un imperativo morale indiscutibile: Damu a la libbirtà nomu e cugnomu / ccà nterra c’è lu beni e c’è lu mali, / si di l’amuri ni mintemu l’ali, / talè, mori lu lupu e nasci l’omu. (da “Lupunaru”).
I Çiuri di notti di Giuseppe Pappalardo sono il luogo della sua verità, sono cassa di risonanza alle emozioni più intime e il loro schiudersi offre al lettore questa sua personale esperienza elevata agli alti livelli della poesia. L’autore si identifica con questo fiore che scambia la notte con il giorno e fiorisce al chiaro di luna, quando le tenebre nascondono la sua bella veste. A chi giova il suo fiorire nell’oscurità? Forse una difesa, o l’impossibilità di svelarsi nella propria verità. Il “fiore di notte” diventa, così, metafora della vita del poeta che vive, pure lui, un’esistenza oscurata. Tutto questo emerge, soprattutto, nella sezione “Parrannu di mia”, dove Giuseppe Pappalardo torna ai ricordi e prende dolorosa coscienza della monotonia e della solitudine di una vita diversa da quella che avrebbe voluto. La lontananza dai figli, razionalmente accettata, diventa nei suoi versi motivo di struggente lirismo: Luntana, / la vuci di li figghi / ca ccu manu piatusa m’arricogghi / sti scàmpuli di vita lampi e trona / e mi fa cumpagnia / quannu ca nforza la malincunìa. (da “Si fussi un picciriddu”).
Questa contraddizione fra ciò che l’autore desidera e ciò che nella realtà vive è evidente in tutta la sezione, ma soprattutto la ritroviamo forte nella poesia “Si spuntassi l’amuri”. A un sole d’oro che mette allegria e che riscalda, e a un cielo azzurro che riflette i colori dell’arcobaleno, non c’è in risposta la gioia di un amore nascente, ma ancora un altro giorno di dolore: Ma, vidi, spunta arrè / lu stissu suli, / lu stissu celu / d’un àutru iornu fàusu e ngannaturi, / u-gnornu risulenti di duluri. (da “Si spuntassi l’amuri”).
E, però, lo scoramento di Giuseppe Pappalardo trova il suo contraltare nella poesia; la quale si accompagna sempre a una commovente musicalità che si dipana lungo strofe rimate alternate a endecasillabi sciolti, e crea una dolce armonia che sembra voler consolare, come nenia lontana, l’inquietudine del poeta.