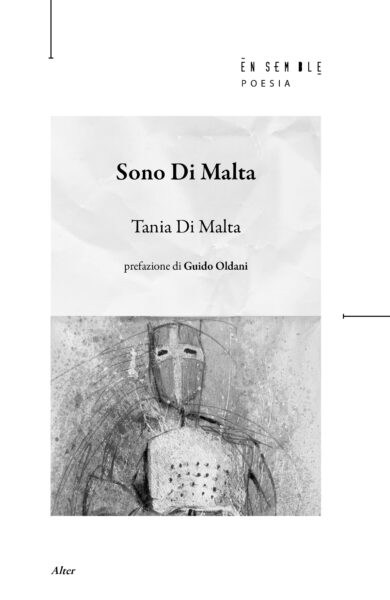“La Scuola di Palermo” di Emanuele Casalena
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 29 Giugno 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2616
 Palermo Capitale italiana della Cultura 2018, una città blindata dal giudizio di mafia, condannata all’Averno delle ombre che non hanno più bisbigli né vita, vagante corte di Ade, dio della morte, il più odiato dai mortali eppure invocato perché generatore di ricchezze. Nelle viscere della terra si è condannati all’amebità eterna ma dal suo utero fecondo sgorgano la vita per i campi, i tesori preziosi del sottosuolo, in primis le sorgenti dell’ acqua. Questo dualismo Eros-Thanatos incarna Palermo nella sua storia millenaria, magnificenza barocca orgogliosa della sua bellezza passionale, dei suoi tanti gioielli, gene di antica aristocrazia, greca, araba, normanna, nella sua gente accompagnato però dallo stordimento mortale per chi la stupra nell’anima oltre che nella carne tappandole la bocca. Ma come in Guernica, da questa città dolente, è sbocciato dalla nuda terra un fiore bianco, è quello dell’arte ch’è vita ben oltre quella soglia del comune destino, superata l’ultima porta, Proserpina lo coglie poggiandolo sull’asfalto a primavera.
Palermo Capitale italiana della Cultura 2018, una città blindata dal giudizio di mafia, condannata all’Averno delle ombre che non hanno più bisbigli né vita, vagante corte di Ade, dio della morte, il più odiato dai mortali eppure invocato perché generatore di ricchezze. Nelle viscere della terra si è condannati all’amebità eterna ma dal suo utero fecondo sgorgano la vita per i campi, i tesori preziosi del sottosuolo, in primis le sorgenti dell’ acqua. Questo dualismo Eros-Thanatos incarna Palermo nella sua storia millenaria, magnificenza barocca orgogliosa della sua bellezza passionale, dei suoi tanti gioielli, gene di antica aristocrazia, greca, araba, normanna, nella sua gente accompagnato però dallo stordimento mortale per chi la stupra nell’anima oltre che nella carne tappandole la bocca. Ma come in Guernica, da questa città dolente, è sbocciato dalla nuda terra un fiore bianco, è quello dell’arte ch’è vita ben oltre quella soglia del comune destino, superata l’ultima porta, Proserpina lo coglie poggiandolo sull’asfalto a primavera.Morte e vita della “Scuola di Palermo” è il tema appunto della mostra inauguratasi a Palazzo Belmonte Riso, il 22 marzo ( non un caso all’incipit dell’equinozio primaverile) e curata da Sergio Troisi (critico d’arte palermitano) con la collaborazione di Alessandro Pinto, aperta al pubblico fino al 25 aprile, altra data-metafora di liberazione. Arte figurativa attuale, controcorrente, da drizzarsi i capelli, è quella che credevi inghiottita nell’Averno del post concettuale, del manierismo art tech, se pensi, cliccando, che tra i dieci artisti contemporanei imperdibili ai cultori, nessuno usa i vecchi arnesi di Leonardo. E invece il vecchio mestiere, quello che il greco De Chirico richiamò nel primo dopoguerra, fa resistenza, lancia il suo guanto di sfida d’ una rivoluzione conservatrice, di più ossigena i nostri cervelli metabolizzati dalla tecno-scienza, insufflati dalla brama avida ch’essa fomenta in manichini bionici incollati ai cellulari. Già perché le “cose” siamo noi, svuotati come polli degli organi vitali, teniamo fisso l’occhio vitreo sugli schermi piatti come i nostri cervelli. Le rivoluzioni partono dai linguaggi, evolvono in direzioni opposte, anche nel bosco sacro delle arti, dove s’incontrano furbi maghi, incantatori di “utenti”, medium dello spirito globale ma ancora, grazia Dei, pontefici e vestali. La lingua è comunicazione, ha bisogno d’essere compresa senza ipocriti interpreti, la grammatica figurativa dei quattro artisti è chiara, cattura come le parole, pur nella diversità scontata di stile e di ricerca.
Se pensiamo al panorama dello stato dell’arte della risorta Quadriennale di Roma, la forbice è aperta, da un lato si chiude a tagliare tessuti sintetici di alchimia industriale scoprendone l’usa e getta del facile consumo digitale, mentre qui torna nelle mani sapienti di sarti artigiani a ritagliare modelli d’ abiti di lusso, stoffe preziose ritrovate nei bauli del corredo. Pittura anche come volo di rinascita della Fenice oltre quel precipizio degli anni ’90 segnati da Capaci, cocciuta volontà di non migrare oltre Cariddi restando qui a raccontare cos’è il fare arte nella Trinacria.
L’ex (una vocazione la sua) Assessore alla Cultura della Regione sicula Vittorio Sgarbi li ha chiamati “I quattro cavalieri dell’Apocalisse” chissà se avesse in mente A. Dürer o l’Armageddon del vecchio S. Giovanni, di certo ha incensato anche se stesso. I Templari del pennello sono Alessandro Bazan, Francesco De Grandi, Andrea Di Marco, Fulvio Di Piazza. Ragazzi negli anni’90 che lavoravano assieme in Piazza Garraffello alla famosa Vucciria, sbocciati come Pomelie alla mostra “Palermo blues” tenutasi ai Cantieri della Zisa; fu quel successo a proiettarli sul palco nazionale dell’arte meritandogli la consacrazione della critica, nacque la “Scuola di Palermo”. Era risorta la pittura tradizionale, fatta coi pennelli dove i soggetti trovano riconoscimento nella memoria popolare, quella pittura che cattura lo sguardo perché ti sembra di capirne l’inganno, dalla sua magia ti lasci conquistare similmente alla trama d’un racconto, alla musica che t’ entra nell’anima trascinandoti lontano. Uno di loro è caduto combattendo, Andrea, aveva solo 42 anni (era nato a Palermo nel ’70). Ci ha lasciati con un volo improvviso nella morte, non quella fastidiosa come una mosca impertinente che cacciata via, ineluttabile ritorna, la morte d’un artista ci lascia eterna la sua vita perché l’amore è forte quanto la morte. Su di lui ho sentito di scrivere poche righe né ipocrite né supponenti, si comprende un artista solo entrando nel suo cosmo a partire dallo studio. Io invece vedo e da spettatore traccio riflessioni.
Andrea Di Marco ( Palermo 1970-2012)
Anche signora morte è banale, uno shock anafilattico spegne la lampada d’ Andrea nella notte fra il 1 e il 2 novembre 2012, è il giorno dei defunti colorato dai fiori sui sepolcri, accarezzati da preghiere e pensieri muti. Di Marco era allegro, ironico, discreto, santo bevitore d’ immagini strappate alla sua Palermo con la camera scura, ricostruite al buio proiettandole sulla tela. Un Caravaggio che illumina la scena senza l’ardere delle candele ma con un proiettore: gli attori non ci sono, sono già nei camerini, restano le robe dell’eterna commedia, tracce della recita quotidiana. Eppure sono intrise di vita, logorate dall’uso, dal tempo scaduto, dense di malinconico abbandono oppure sospese in attesa che qualcuno le colga, salga quelle scale, sgomberi il marciapiede, accarezzi il muro scrostato. Metafisica dell’arte, veicolo di verità ancor prima della parola, un Heidegger allo Zen. Il pennello scrive un appunto discreto, popolare, dipinto coi colori forti della Sicilia, ma le voci sono sciamate, le muse inquietanti sono poltrone damascate, ombrelli chiusi, Api straripanti d’oggetti, stracci ammucchiati senza la Venere di Pistoletto o ancora scorci di vicoli, di strade al declinare della sera, alberi e tralicci in una sfida tra giganti, un melodramma delle cose lasciate sole senza il tepore dell’uomo. E’ la poesia melanconica di un’archeologia attuale, recitata dagli oggetti, non c’è tempo né azione, eppure anche i rifiuti ereditano quella “nobile semplicità e quieta grandezza” di Winckelmann riscoperta tra le pieghe della società dei consumi. Di Marco non racconta, trasferisce il verismo letterario di Verga in pittura, il realismo politico di Courbet non è nelle sue corde, cattura sorpreso l’epifania improvvisa delle cose, cogliendone la lirica sottile che le veste. Verità senza contaminazioni, né stupri intellettuali ma appunti d’un viaggiatore sull’esserci nudo, crudo, hic et nunc. Proprio in questo suo fare, l’oggetto trascende la sua rappresentazione mimetica trasformandosi da umile baco in volo di farfalla che l’artista coglie aprendo la zip della tenda per mettere a fuoco l’occhio sui manufatti del suo mondo.
nella foto in alto Andrea Di Marco, Senza titolo, 2012, ultima opera dell’artista