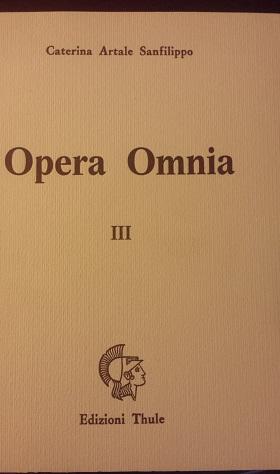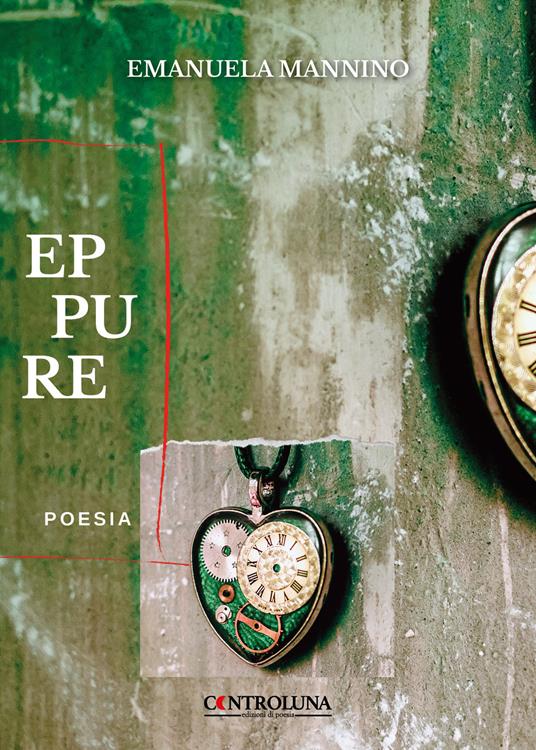Vincenzo Guzzo “L’Aurora dal manto di croco” (Ed. Carlo Saladino)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 09 Settembre 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1943

di Giovanni Teresi
L’anima del Mito viene individuata dall’autore nel titolo della sua opera: “L’Aurora dal manto di croco”. Infatti, come Vincenzo Guzzo descrive nel secondo capitolo del testo, “l’Aurora non appare con le delicate rosee dita ma con un regale manto di croco che mostra la luce e il deciso colore di quel nuovo giorno in cui il Padre degli Dei, regalmente, rimette in equilibrio le sorti della guerra.” (Libro VIII dell’Iliade).
Prima fu il celeste Urano, poi Crono e quindi il “luminoso” Zeus. L’autore cita Kàroly Kerényi e, esaminando l’aspetto semantico e simbolico, dice che l’originario contenuto del nome “Zeus” richiama “il sorgere della luce, e solo come derivazione da ciò e Colui che illumina: non solamente è il sorgere della luce del giorno, ma è un benefico rischiararsi in genere, perfino del mare”.
In un’altra affermazione di Kerényi, presa da un frammento di Eschilo, si legge: “un pescatore, che fruisce dei doni del mare, invoca, oltre a Poseidone, lo “Zeus del mare”.
Ciò mette in luce come e quanto fosse labile il gioco tra ciò che chiamiamo politeismo e ciò che si espandeva o contraeva in relazione a tendenze enoteiste, ossia relative alla prevalenza netta di una sola divinità sulle altre.
Per comprendere il mito occorre avere una mente “sostanziata” dell’essenza del mito. Confrontando i testi universali, cioè le espressioni dei vari orizzonti etnico-religiosi, ci si trova come primo impatto dinanzi ad identiche categorie mentali.
Se un bouddhista leggesse l’Odissea con gli strumenti forniti dalla propria struttura mentale, non potrebbe rimanere estraneo ai simboli universali insiti nella trama delle vicissitudini di Ulisse: il dolore permea il reale, l’impermanenza dissolve ogni cosa. Calipso, Circe e le sirene sono la Maya degli Indù; Ulisse accompagnato da Atena è la chiaroveggenza del saggio che è pervenuto attraverso l’iniziazione misterica alla Conoscenza Suprema.
Questi i simboli sono universali: già Plutarco nel suo “Iside e Osiride” metteva in evidenza l’ubiquità del medesimo contenuto simbolico in tutte le latitudini. Non diversamente agiva la Tradizione Romana nel riconoscere e nell’acquisire gli Dei di altri popoli. Ubicumque res non dissimiles sunt: homo quaerit sacrum et id exprimit imaginibus. Medesima sostanza sotto forme diverse, tanto diverse quanti sono i popoli.
Il Nostro, nella introduzione e piano dell’opera, afferma che i miti ci parlano di divinità e di eroi dai comportamenti contradditori che usano paradigmi paradossali tesi a forzare la natura, nonché dell’audacia di imprese estreme e del travaglio delle scelte e dei ritorni … Il mito, che è racconto sacro, parola ma pure silenzio, abita l’anima dell’uomo d’ogni tempo e ne illumina, in vario modo, il cammino.
Adesso poniamoci una domanda: Cos’è il mito ?
Non è certamente ciò che ne hanno detto gli storici, eccetto pochi come Creuzer e Otto. (Walter Friederich Otto, Il volto degli dei, Roma 1986).
Il mito è sostanzialmente apertura su una trascendenza che si intuisce ma che non si sa esprimere perché non si può. Ci sono fatti che danno vita al mito, ma tali fatti non sono il mito. Spesso i fatti, pur veicolando il mito, ne sono in realtà la distorsione.
« La tradition, dit de Welte, n’a point de discernement ; sa tendance n’est pas historique, mais patriotique et poétique. Plus les récits sont beaux, honorables pour la nation, merveilleux, mieux ils sont reçus… ». Per tale motivo il Mito rinvia ad altro. (Renan, Etudes d’Histoire Religieuse, Paris 1863, p. 150)
Nella sua introduzione al testo “Miti pagani e cristiani” Margarete Riemschneider sostiene che per lo scrittore antico non ha senso la parola inventare. Riguardo al mito, in particolare, lo scrittore non inventa nulla, ripropone semmai in veste nuova, sperimentandosi in un esercizio formale che entri in competizione con lo stile di altri scrittori.
Dunque il mito non si inventa, ma si ripropone.
Vincenzo Guzzo, a proposito della “Maternità virginale nei miti e nelle religioni”, rammenta che Platone, nei suoi Dialoghi , cercò la via dell’alètheia, la Verità, illustrandocela con miti d’immenso valore per la comprensione del rapporto uomo-mondo e nel Simposio ci parla dell’Androgino che venne separato in due da Zeus, il maschile e la femminile, che da allora si attraggono con forza per ricostituire l’unità perduta. “Anche se l’idea di maternità virginale viene considerata un’aporia, occorre ribadire che i miti non sono narrazioni a contenuto rigido e non si attengono alla coerenza logica, ma offrono intuizioni preziose che orientano alla più coinvolgente verità muovendo da rappresentazioni dei massimi modelli primordiali, gli archetipi.”
Ma il mito ha una natura talmente poco umanamente accostabile che richiede un mezzo espressivo adeguatamente meno corruttibile come la parola. Ed è proprio la parola omerica su cui hanno incespicato i lettori nei millenni, a dimostrare che l’immediatezza espressiva deve “prendere” l’uditore nel momento della sua emissione. Omero non ha inventato nulla, ma la sua rielaborazione ha fatto versare fiumi di inchiostro sia tra gli antichi che tra i moderni. Segno che non si poteva più comprendere il senso della parola omerica.
Il Nostro, riguardo “Il Mito di Ermete Trismegisto”, descrive che, procedendo all’approfondimento dello studio storico e filosofico delle fonti, si può contemplare un vasto panorama che ci consente di rilevare una pluralità di connotazioni cosmogoniche, astrologiche, sapienziali, etiche, magiche, terapeutiche, geometriche e filosofiche, che orientano a rintracciare le origini di questo mito in ambito ellenistico-alessandrino, a partire dai tre secoli che precedettero l’era cristiana.
Interessante osservazione, anche perché il periodo ellenistico fu caratterizzato anche da una forte propensione al sincretismo, e quello di Ermete Trismegisto fu un fenomeno che si sviluppò e si diffuse rapidamente nel bacino del Mediterraneo e nel Vicino Oriente assumendo le caratteristiche di un riferimento sapienziale, come afferma Vincenzo Guzzo, capace di immenso incantamento, divenendo paradigma di ogni conoscenza essoterica ed esoterica, delle cose visibili e invisibili.
“Per quasi due millenni sussistette, in modo ampiamente condiviso, il convincimento di una reale dimensione storica, anche se non fu omogeneo il modo di rappresentarsi, l’esistenza concreta di un essere umano che potesse incarnare le doti e le conoscenze che gli furono attribuite o che potesse essere assimilato o accostato, in quanto destinatario della Rivelazione, a personaggi di immenso spessore mitico, religioso e filosofico, e precisamente a Mosè, a Pitagora, a Platone, a Zoroastro, ad Orfeo e persino a Thoth, divinità di primo rilievo della religione dell’antico Egitto.” (pag. 87).
Tuttavia il maggior peso valutativo, nel senso della focalizzazione della inscindibilità del nesso Sacro-Simbolo, va decisamente attribuito alla “psicologia del profondo”, indirizzo recente della psicologia che, sulla scorta di Jung, ravvisa in radicibus, quindi da sempre, il bisogno umano del Sacro, bisogno che non può essere riconducibile ad abstractum ma che nasce dalla “dimensione estesa” della realtà umano-cosmica.
Verso questa “captatio sensuum” si è orientato sensibilmente Hillman ai cui studi si deve il deciframento in tal senso della mitologia greca. Il Mito è trascendenza, è superamento della dimensione immediata verso un radicamento totale e imprescindibile. Tale radicamento è appunto il sacro quale apertura verso il totum che è originariamente la φύσις.
Come dice giustamente Renan, il Mito è indiviso e la sua indivisibilità rinvia alla “epifanicità”. Se la φύσις è il totum di cui l’uomo è una parte, di questo totum sono parte integrante anche gli Dei.
In Grecia i percorsi mitico-spirituali ebbero come peculiarità la sintesi tra mythos e theos.
I simboli, in età più antica, e la scrittura, in epoca successiva, ci hanno indirizzato, a partire soprattutto dall’Oriente, verso un’identità di ruolo tra quei poteri che usiamo distinguere in spirituale e temporale. Gli Dei e gli uomini si parlavano, l’uno di fronte all’altro.
Infine, vi fu un forte collegamento tra regalità e pratiche d’intervento sui cicli vitali e produttivi, sulla fecondità delle risorse naturali e su particolari potenzialità di tipo spirituale a cui tutti non partecipavano mentalmente ma ritualmente. In ambito greco, il ruolo regale includeva anche poteri di carattere numenico e la parola numen esprime il senso e l’effetto concreto della presenza cogente del sacro. Il Nostro, a tal proposito, mette in risalto alcuni aforismi significativi: “Il Signore di Delfi non dice e non nega ma dà cenni” secondo quanto ci ha tramandato Eraclito. In ambito cristiano vi è una grande ed esoterica testimonianza del numenico in noi nelle parole di Cristo: “Va la tua fede ti ha salvato”. E Agostino d’Ippona: Non uscire da te, ritorna in te stesso; la verità abita all’interno dell’uomo”.
Le prerogative numeniche della divinità o di altri soggetti sacri, il mito le aveva già elaborate e divulgate anche in ordine all’ambito cosmogonico, per poi ampliarle attraverso continue formulazioni mitopoetiche e adeguarle a tutti gli aspetti della vita, man mano che mutavano le sensibilità spirituali. Vincenzo Guzzo, nel capitolo “Regalità e nobiltà: una visione inconsueta”, enumera una serie di esempi del rapporto tra regalità e divinità, relativi ai periodi di cui restano testimonianze nel Mediterraneo e nel vicino Oriente,ed ebbero le seguenti caratteristiche essenziali:
“In Egitto, il faraone discendeva direttamente da Horus, figlio di Iside e Osiride, e numerose sono le testimonianze iconografiche e papirologiche che ce ne danno testimonianza.”
“In Persia i re derivavano il loro potere direttamente da Ahura Mazda, divinità di riferimento per eccellenza che, grazie a Zarathustra diverrà Dio unico, assorbendo in sé i poteri degli altri Dei”
“In Mesopotamia il nome dell’antichissima città sumera di Kish significava “totalità” e pertanto il re di questa città era pure il re della totalità, ossia dell’unità tra dimensione divina e dimensione terrestre”.
“In Grecia, relativamente a ciò che riguarda il tempo dei re micenei, ci riferisce ampiamente la tradizione omerica.”
La visione tragica, con Eschilo contemplava ancora l’aspetto religioso, ma già con Sofocle e soprattutto con Euripide metteva in risalto una crescente crisi della religiosità della Grecia antica, ed esprimeva il passaggio a una visione sempre più connessa alle caratteristiche culturali della polis.
A riguardo del teatro greco, Angelo Brelich ha sottolineato l’impossibilità di separarne il senso dal sentimento religioso del Greco: se si prova a leggere il mito su questo sfondo, si intuisce che l’agire umano e divino non è esente dalla conseguenza che esso comporta.
(Cfr. Angelo Brelich, I Greci e gli dei, Napoli 1985: il teatro greco è una “demonstratio virtutis” contro la ύβρις.).
In ogni caso l’agire umano comporta delle conseguenze che l’uomo deve assumere virilmente: da qui l’esigenza della catarsi. Proprio perché assume le proprie conseguenze, l’uomo greco si riconosce in rapporto con determinate forze cosmiche a lui superiori. La catarsi non è un concetto giansenistico. Per il Greco, il vivere in sé è già un atto “dovuto”, la cui espressione deve essere unicamente religiosa, dunque intra-cosmica.
L’interessante testo di Vincenzo Guzzo va letto gustandone l'Aurora regale, dal manto di croco, che si prepara a condurci lungo un itinerario incantato alla ricerca del senso profondo di antiche narrazioni sacre le quali fondono simbolicamente teogonie e cosmogonie, e che ci offrono l'incontro con figure incerte o improbabili, ma di forte incisività emotiva, assieme alla conoscenza di eventi che non sono mai accaduti ma che sempre rivelano l'essenza delle cose.