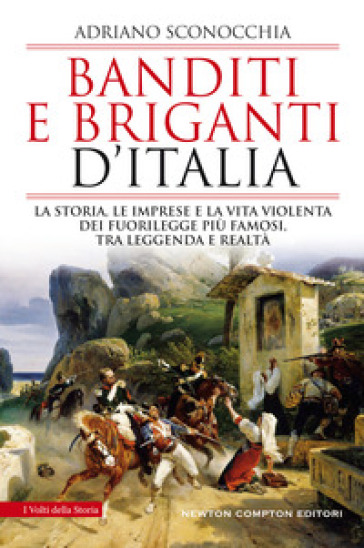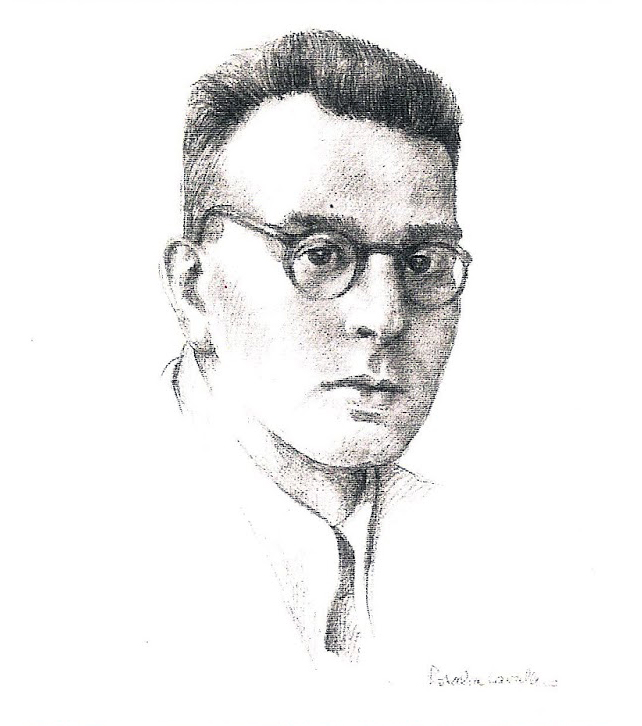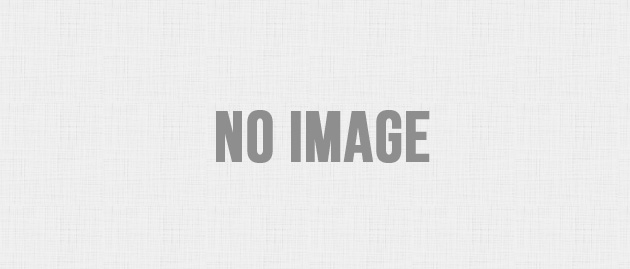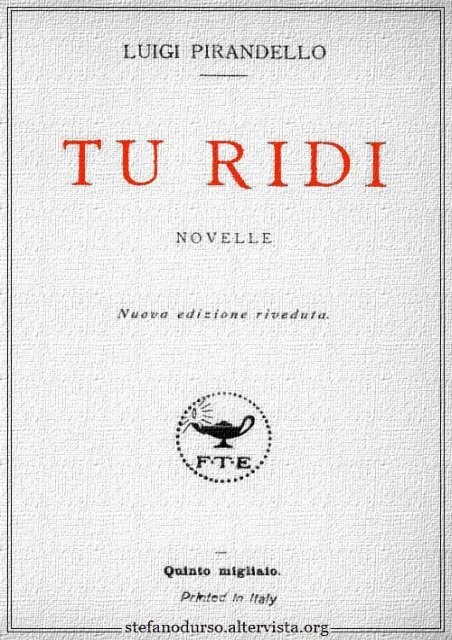Storia, cibo, natura… viaggiando con Tiziano Terzani – di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 16 Settembre 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 481
 Una recente ristampa ha riproposto il famoso libro di Tiziano Terzani (1938/2004) Un indovino mi disse, edito nel 1995. Rileggerlo oggi, a trent’anni di distanza, è tornare a “liberare” il pensiero e l’immaginazione fra storia, avventura e il mistero di esistere. Sono queste le tre coordinate cui si possono ricondurre le vicende ricordate, o registrate per così dire “in presa diretta”, nel corposo volumetto. Occasione di esso la profezia fatta nel 1976 al giornalista da un vecchio indovino cinese di Hong Kong circa il suo gran rischio di morire in volo nell’anno 1993, donde la decisione di Terzani di non usare aerei in quell’anno, viaggiando solo in treno, in automobile, su nave, a piedi, o anche dentro una cesta scomoda e malferma su un dorso di elefante, come farà la mattina del 1 gennaio 1993 avviando quella sua singolare esperienza. Esperienza che, affrancandolo dalla fretta di schizzare via quale giornalista da un posto all’altro in un frenetico routinario giro di aerei taxi alberghi, gli permise di rallentare, di darsi del tempo, di incontrare e vedere persone, luoghi, cose che altrimenti non avrebbe mai visto, guardando e godendo in quei mesi del mondo da una prospettiva “altra”, non quella ufficiale o delle statistiche che passano sulla testa della gente, ma fisicamente ravvicinata, a contatto diretto con “quel” preciso tratto di mare, frontiera, sponda di fiume… con la diversità insomma e vastità del mondo nel ritrovato piacere della “scoperta personale” e dell’”avventura”. Invece gli aeroporti -osserva opportunamente Terzani nel libro- falsi come i messaggi pubblicitari, isole di relativa perfezione anche nello sfacelo dei paesi in cui si trovano, si assomigliano ormai tutti… bolle ad aria condizionata con immancabile free duty shop. Accolse perciò l’autore la profezia come un alibi, una sfida a vivere per un anno una vita diversa, quasi un continuo gioco pieno di sorprese, e tuttavia sempre col dubbio/interrogativo aperto -dato il mistero dell’esserci- sul “destino” (già scritto? o determinato da noi?), se realmente il 20 marzo del 1993 un elicottero delle Nazioni Unite cadde in Cambogia nei pressi delle rovine di Angkor con 15 giornalisti a bordo (tutti sopravvissuti però), fra cui Joachim Holzgen del settimanale Der Spiegel che l’aveva sostituito: Al diavolo tu e il tuo indovino -gli urlò il collega al telefono dall’ospedale. Holzgen ne uscì fortunatamente solo con una gamba rotta e la spina dorsale ammaccata.
Una recente ristampa ha riproposto il famoso libro di Tiziano Terzani (1938/2004) Un indovino mi disse, edito nel 1995. Rileggerlo oggi, a trent’anni di distanza, è tornare a “liberare” il pensiero e l’immaginazione fra storia, avventura e il mistero di esistere. Sono queste le tre coordinate cui si possono ricondurre le vicende ricordate, o registrate per così dire “in presa diretta”, nel corposo volumetto. Occasione di esso la profezia fatta nel 1976 al giornalista da un vecchio indovino cinese di Hong Kong circa il suo gran rischio di morire in volo nell’anno 1993, donde la decisione di Terzani di non usare aerei in quell’anno, viaggiando solo in treno, in automobile, su nave, a piedi, o anche dentro una cesta scomoda e malferma su un dorso di elefante, come farà la mattina del 1 gennaio 1993 avviando quella sua singolare esperienza. Esperienza che, affrancandolo dalla fretta di schizzare via quale giornalista da un posto all’altro in un frenetico routinario giro di aerei taxi alberghi, gli permise di rallentare, di darsi del tempo, di incontrare e vedere persone, luoghi, cose che altrimenti non avrebbe mai visto, guardando e godendo in quei mesi del mondo da una prospettiva “altra”, non quella ufficiale o delle statistiche che passano sulla testa della gente, ma fisicamente ravvicinata, a contatto diretto con “quel” preciso tratto di mare, frontiera, sponda di fiume… con la diversità insomma e vastità del mondo nel ritrovato piacere della “scoperta personale” e dell’”avventura”. Invece gli aeroporti -osserva opportunamente Terzani nel libro- falsi come i messaggi pubblicitari, isole di relativa perfezione anche nello sfacelo dei paesi in cui si trovano, si assomigliano ormai tutti… bolle ad aria condizionata con immancabile free duty shop. Accolse perciò l’autore la profezia come un alibi, una sfida a vivere per un anno una vita diversa, quasi un continuo gioco pieno di sorprese, e tuttavia sempre col dubbio/interrogativo aperto -dato il mistero dell’esserci- sul “destino” (già scritto? o determinato da noi?), se realmente il 20 marzo del 1993 un elicottero delle Nazioni Unite cadde in Cambogia nei pressi delle rovine di Angkor con 15 giornalisti a bordo (tutti sopravvissuti però), fra cui Joachim Holzgen del settimanale Der Spiegel che l’aveva sostituito: Al diavolo tu e il tuo indovino -gli urlò il collega al telefono dall’ospedale. Holzgen ne uscì fortunatamente solo con una gamba rotta e la spina dorsale ammaccata.
Innamorato dell’Asia, e in essa residente fin dal 1971 fra Singapore, Hong Kong, Pechino,Tokio, infine Bangkok (e qui in una casa di legno sull’acqua fra piante e animali, oasi di vecchio Siam in mezzo all’orrore di una città cementificata e inquinata), Terzani riesplora dunque nel 1993 il continente asiatico spostandosi solo “via terra” e “via mare”, mentre continua a scrivere i suoi servizi giornalistici riflettendo fra passato e presente, e con un senso di angoscia crescente. Non per quello che i tanti indovini (uomini e donne che continuerà a consultare più per curiosità di conoscere i loro metodi e umane caratteristiche) gli diranno di Paese in Paese (dal Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam alla Malesia, Indonesia, Mongolia, Londra) sul suo destino “letto” per lo più in positivo in contrasto con la profezia del cinese di Hong Kong, quanto per la corsa dell’Asia del cosiddetto miracolo economico verso il suo “suicidio” per quella che già allora gli appariva una galoppante, sfrenata, “deriva” verso la modernizzazione/occidentalizzazione guidata solo dal materialismo e dalla logica del profitto. Campioni di tale “mutazione” per Terzani i micidiali cinesi [emigrati] della diaspora, della Terza Cina, volgari, sicuri di sé, esibizionisti, con loro capitale/modello Singapore, mantenutasi equidistante dalla Cina comunista di Mao e da quella nazionalista di Taiwan (ma entrambe anch’esse ormai così simili fra loro nell’habitus esteriore e interiore di uomini d’affari occidentali), una Singapore su cui cala pesantemente il giudizio negativo dell’autore: isola ad aria condizionata… Betlemme della nuova religione dei consumi, del benessere materiale, del turismo di massa… il più grande supermercato di beni di consumo, di inutilità, di perbenismo dell’Asia. Donde la formulazione finale del desiderio di andare a vivere in India, ultima spiaggia forse di spiritualità e di divino, e la strutturazione “a contrasto“ del libro. Se rigorosa e interrogante è la rappresentazione storico-politica dei territori attraversati e osservati, sempre ammirata è la descrizione di paesaggi naturali mozzafiato, e altrettanto curioso e preciso si volge lo sguardo ai costumi alimentari, naturali e tradizionali, degli asiatici. Afferma Terzani che in Asia il cibo è uno dei grandi piaceri della gente. La varietà -sottolinea- è grande, il modo di prepararlo semplice e gli odori e i colori fanno parte della gioia quanto i sapori. Ogni piatto ha poi quel suo speciale valore magico che rende il mangiare ancora più attraente. Una cosa fa bene al fegato, una alla circolazione del sangue. Un frutto riscalda, uno raffredda, mentre tante cose fanno bene al sesso, ossessione quest’ultima comune non soltanto agli orientali. Anche se meno presente rispetto ad altri elementi locali, il “cibo”, quando sale in primo piano, acquista rilevanza dalle situazioni specifiche in cui è calato, ad esempio la denuncia della cementificazione selvaggia e della malefica industria del turismo di massa con i suoi ottusi invasori carichi di macchine fotografiche e implacabili videocamere che grattano via l’ultima naturale magia di certi luoghi, quale l’incanto dell’isola di Phi Phi (Thailandia), un tempo uno di quei paradisi tropicali con il mare blu e la sabbia bianchissima, le capanne di bambù e di paglia… e le sue grandi misteriose grotte con i pali altissimi di bambù lungo i quali i ragazzi si arrampicavano per andare a prendere i preziosi nidi di rondine, che erano e sono tuttora, per la zuppa gelatinosa che se ne ricava, uno dei cibi più prelibati per i cinesi e “specialità” della loro cucina. Tipica thailandese è invece la omelette di uova di formiche rosse che Terzani gusta però nel Laos, il 31 dicembre 1992 (sic!), nella foresta di Bolovens, ridotta allora a uno sterpaio a causa dei massicci bombardamenti durante la guerra del Vietnam, perché proprio in quell’altopiano confluivano tutti i rifornimenti che venivano da Hanoi, lungo il sentiero di Ho Chi Minh (aperto attraverso le foreste del Laos), prima di essere smistati ai vietcong operanti nel Vietnam centrale e del Sud. Mangia Tiziano la frittata in una capanna di legno costruita su una cascata dallo scroscio assordante, come solitario “cenone” di mezzanotte siglato, in assenza di champagne, con un brindisi di acqua fresca, quale impegno formale a non cedere nel 1993, per nessuna ragione, alla tentazione di volare, e la mattina del 1 gennaio, per aggiungere simbolismo alla sua decisione, se ne ritorna infatti verso la Thailandia a dorso d’elefante, dentro la già citata cesta, attraverso una valle dove l’erba era alta e verdissima, punteggiata qua e là dai brillanti pennacchi argentei del lulan appena mossi dal vento.
Quanto alla strutturazione “a contrasto” di cui si diceva, l’autore indugia ora sulla commovente bellezza della Natura (il verde giada delle risaie, la giungla cupa e primitiva, il verde pallido dell’immensa prateria mongola con la profumatissima erba arz e la struggente dolcezza dei tramonti estivi di Ulan Bator, l’immensa taiga siberiana con le piccole betulle dai fusti bianchi e i prati verdi in estate pieni di fiori) e su tutte le tracce resilienti o timidamente risorgenti, dopo la violenta repressione ideologica socialista/comunista, di un passato “antico”, “verginale”, magico/spirituale (dalla Luang Prabang antica capitale reale del Laos alla birmana Kengtung, mitica città degli Shan, all’isola di Pulau Pinang, ai misteriosi Bunyan dell’isola di Lingga, ai novizi buddisti); ora su una altrettanto “commovente” ma inquietante, in quegli anni ’90, massa di umanità disperata disorientata avida adirata (alias immiserita), che Terzani viene incontrando per le strade e nelle stazioni ferroviarie con addosso i drammi delle illusioni e delle “rivoluzioni” tradite. Il fallimento cioè della modernità socialista sovietica, della rivoluzione culturale cinese, delle lotte comuniste in Indocina se osservato dalla visibile miseria e grigiume di Hanoi, dalle condizioni di Città Hochiminh (ex Saigon) ancora più caotica, più sporca, più indecente e più puttana che ai tempi della guerra, dalla Cambogia delle stragi purificatrici di Pol Pot divenuta meta di speculatori con le mani sulle risorse del paese e negli affari più loschi, dalla Betong thailandese città-bordello con l’ex quartiere generale della guerriglia nella foresta trasformato in una Disneyland (turistica) della guerriglia con sala-video, ristorante, cartoline ricordo, visite guidate nei tunnel, dalle “tappe“ della Transiberiana scaduta a prosaico bazar ambulante, per non parlare, nel vincente, omologante, assedio di plastica cemento droga denaro bordelli mascherati da massage-parlours o barber shops, dei tanti ex-guerriglieri datisi alla coltivazione dell’oppio, al contrabbando, agli affari. Altrettanto variegati in una ottica socio-antropologica, e non solo in obbedienza alla dimensione piacevole del “gusto”, gli itinerari del “cibo”. Sfilano sotto gli occhi del lettore ora l’orrida macellazione dei cani, che in Vietnam sono destinati alla pentola (a un cane imbavagliato e appeso per i piedi un uomo taglia prima la pelle dietro l’orecchio, cercando la vena per farne colare il sangue in un recipiente, poi lo scuoia e lo fa a pezzi: il petto per lo stufato, le cosce, forse, per l’arrosto) o il crudo riferimento a un ristorante di Canton, dove i tavoli erano sistemati su tre piani attorno a una enorme gabbia di ferro dentro la quale in diversi scomparti erano in mostra i vari animali da mangiare. Cani, serpenti, scimmie, orsi e altre “specialità”… I cuochi, nelle loro uniformi bianche, entravano e uscivano dalle gabbie con i pezzi che la gente aveva ordinato e quelle povere bestie, ogni volta che qualcuno vestito di bianco si avvicinava… si mettevano a strillare come ossesse, quali le scimmie rimaste mutilate, vive e con le ferite cauterizzate alla meno peggio con ferri roventi. Altrove emerge il “pittoresco” policromo della compresenza di etnie diverse, e secondo gradazioni precise di pacifica convivenza, o di ostilità latente, oppure palese e dichiarata. In Birmania a Kentung all’inizio del suo anno sabbatico Terzani, mentre di buon mattino fa colazione con la moglie Angela e un amico, intingendo nel latte condensato untuosissime frittelle che un giovane prende abilmente a mani nude da un calderone di olio bollente, vede scendere per il mercato donne e uomini delle tribù delle montagne con i costumi caratteristici e i prodotti tipici da vendere o scambiare: le donne Akka con minigonne, gambali neri e strani copricapo ornati di monetine e palline d’argento, le donne giraffa dei Padaung con i lunghi colli sostenuti da collari d’argento, le donne Meo con i giubbetti ricamati di blu e rosso, i cacciatori Meo con lunghi e rudimentali fucili, i selvaggi Wa (a giudizio dei loro vicini, i Luà) vestiti di nero con al fianco il grosso machete nel fodero di bambù. In Malesia, nella Kuala Lumpur ormai dall’aria musulmana -scrive Terzani- per la politica governativa tesa a rafforzare nei malesi l’identità musulmana come difesa contro lo strapotere economico dei cinesi immigrativi da generazioni, assistiamo sia a un pasto consumato in strada, in un quartiere popolare, a un carretto, attaccato a una motocicletta, che si trasforma a un tratto in un piccolo ristorante con 2 fornelli a gas e un bel tavolinetto coperto di appetitose specialità esposte in piccoli vassoi da cui la gente prende spiedini con polpettine di carne, pezzetti di polipo, fettine di fegato, salsicce e ali di pollo, li fa cuocere nell’acqua bollente delle due pentole, li intinge nelle salse gialle rosse e arancione allineate nei piattini, e li mangia poi in piedi (cinese il proprietario, cinesi i clienti); sia alla festa tradizionale malese di Hari Raja, nella quale è consuetudine che anche il primo ministro apra la sua residenza ufficiale a tutti, ed entro i neri cancelli di essa il lettore vede perciò aggirarsi una enorme folla (per lo più malesi) attorno ai vassoi ricolmi di riso, di polpette, di involtini, di centinaia di bicchieri di plastica con acqua e aranciata, andando poi a mangiare tutti sull’erba vestiti di belle sete colorate e luccicanti. A Malacca, emporio commerciale in cui nei secoli si sono incontrati e scontrati malesi cinesi portoghesi olandesi inglesi giapponesi e perciò ancora vi bisbigliano, soprattutto di notte, inquieti i fantasmi dei morti, Tiziano, nel vecchio quartiere portoghese, nel ristorante gestito dal malese-portoghese Michael Texiera (bravo pure a scacciare i diavoli) mangia un buonissimo baccalà lesso con patate, cipolle, olive nere e aglio crudo. Nella sua Singapore, che ritrova dopo più di 15 anni di assenza stravolta in una artificiale isola a aria condizionata, dove anche il mare gli sembra riciclato, disinfettato, in un ristorante popolare, con tante bancarelle dentro uno stanzone ciascuna con un cinese che cucina una sua specialità, mangerà sì con piacere una bella zuppa di vermicelli di riso con germogli di soia e del fegato di pollo affettato fine fine, ma nel quartiere intorno è tutto così perfetto pulito ordinato (cioè programmato/controllato dal regime, pure la gente) che sente solo voglia di fuggire via. Nell’indonesiana isola di Pulau Pinang (ancora naturale e magnifica, ma per poco perché già alcuni uomini di affari sono all’opera per farne la Hawai del Sud-Est asiatico), il suo interprete e autista lo guidano, nella capitale, a un ristorante cinese con una bella terrazza sul mare e in basso una vasca con vari tipi di pesci vivi: granchi aragoste gamberi che i clienti scelgono dall’alto, un ragazzo li pesca e li manda al cuoco dentro un cestino; poi sempre dall’alto saranno buttate in mare le lische e i gusci che la marea porterà via. Una sera invece ceneranno tutti e tre a un tavolo nell’affollatissimo mercato locale fra decine di banchetti ciascuno con una sua specialità: frutti di mare, carni, verdure, una infinità di pesci… un affascinante -sottolinea Terzani- mosaico di colori e di forme fra zaffate continue di fortissimi odori e le fiammate dell’olio dei grandi calderoni maneggiati dai cuochi cinesi come fossero prestigiatori. Ma c’è il controcanto nel buio dietro i banchetti dei branchi di cani e di mendicanti affamati, e di un ragazzino lustrascarpe potenziale ladruncolo appunto di scarpe.
Quanto ai pasti consumati sulle navi, le quali danno sempre all’autore un senso di salutare pausa e libertà con il loro ansimare, scuotere, respirare, con il loro gioire delle carezze delle onde [e]… godere l’amplesso del mare, spaziando il suo sguardo nell’infinità del cielo fuori dal solito mondo e avendo finalmente tempo per sé e silenzio, nella nave che lo porta attraverso lo stretto di Malacca fino a Sumatra fa una esperienza del “gusto” deludente. Poiché gli indonesiani -scrive- vogliono rispettare gli dei di tutti, non mangiando gli indiani maiale, essendo gli hindu vegetariani, non volendo i cinesi cibi piccanti… a Tiziano è toccato riempirsi lo stomaco con una minestrina scipita di cavoli e patate, gran piattate di riso bianco e pesciolini fritti. Sulla malconcia nave da carico invece Nagarose con cui va da Bangkok in Cambogia e che ha un equipaggio tutto di birmani fuggiti dai dittatori di Rangoon, gusterà una cena magnifica grazie alla giovane cuoca thailandese, che è anche la bella moglie ventenne “affittata” del capitano, la quale alla partenza ha pure ornato, come portafortuna, la poppa della nave con una collana di fiori di gelsomino, strisce di seta colorata, bacchette di incenso e una ciocca di orchidee. Una cena con stufato di zampe di maiale (e dire che Terzani chiuderà il suo anno 1993 con un corso di meditazione buddhista e dieta rigorosamente vegetariana!), pesci fritti, verdure allo zenzero, riso a volontà, e i birmani seduti accanto a lui vi aggiungeranno peperoncini rossi a morsi ripetuti e compiaciuti, e come dessert involtini di betel (una noce grossa e gustosa tipica di Sumatra tagliuzzata e avvolta in una foglia con spezie e un pizzico di calce) che lasceranno macerare a lungo in bocca. Per il cuoco napoletano della nave porta-container italiana Trieste, su cui viaggerà per 18 giorni tornando dall’Europa a Singapore, gli basta invece usare una sola frase, ma esaustiva e ricca di sapidi sottintesi: il cibo, preparato da un cuoco napoletano, era ottimo e non una sola volta uguale alle precedenti (sic!). Circa i treni, usati soprattutto per il viaggio “via terra” dalla Thailandia verso l’Europa (attraverso Cambogia Vietnam Cina Mongolia Siberia Mosca Polonia…) Terzani li “scopre” più come treni-merci che come treni per passeggeri dati “gli affari” che molti vi realizzano fra bisogni di sopravvivenza e corruzione. Su quello vietnamita, che da Saigon va verso Hanoi, incontra ex soldati, divenuti bigliettai e controllori (ma con stipendi da fame), e individui qualunque (anche donne) che, comprati a Saigon televisori di importazione thailandese o ad ogni stazione ceste di uva, spiedini di pesce secco, piante medicinali, vanno a rivendere il tutto ad Hanoi con notevole guadagno. Anche su quelli cinesi, da Nanning a Xian a Lanzhou, cuochi, camerieri, ferrovieri trafficano con sacchi di ananas nascosti sotto i sedili, e a suon di dollari o yuan integrativi assicurano posti-letto nel vagone soffice, e al ristorante una bella cena su tovaglia bianca e non di plastica appiccicosa. Analogamente sulla Transiberiana il capocameriere grazie a un biglietto di 10 dollari garantirà per 5 giorni a Tiziano un posto pulito a tavola, caviale fresco e vodka ghiacciata. Sul treno da Huhehot a Ulan Bator e sulla Transiberiana da Ulan Bator a Mosca alcuni mongoli sembrano a Terzani corrieri della droga (secondo un tracciato scontato che va dallo Yunnan all’Europa), perché armeggiamo in modo strano con aperture nel soffitto e piccole botole nei corridoi, mentre altri riempiono gli scompartimenti con grandi sacchi colmi di vestiti, cibo e grappoli di birre, comprati all’ultima stazione cinese, quella di Erliang. Di altrettanti enormi sacchi ingombreranno poi altri mongoli laTransiberiana, sventolando a ogni fermata fuori dal finestrino alla gente, che freneticamente si accalca, la loro merce (“rivestendo” -osservava Terzani in quel 1993- i discendenti di Gengis Khan -scaduti a semplici merciai- di abitucci cinesi i poveri russi sconfitti dalla storia), e realizzando -quanto a guadagno- il triplo rispetto al migliaio di dollari inizialmente investito. Il mongolo, corpulento businessman compagno di viaggio fino a Mosca di Terzani, a ogni risveglio di quel lungo percorso, consuma frattanto regolarmente sul tavolino dello scompartimento il suo pasto dall’orribile odore, ma perfettamente conservato per giorni e giorni: ravioli con ripieno di carne di pecora, e spiega in cinese a Tiziano che a Ulan Bator ogni famiglia a fine ottobre acquista un bue intero o un paio di pecore, li scuoia e li mette sulla terrazza: con il freddo la carne si congela e durante l’inverno man mano la si mangia.
“Affari” e “soldi” dunque preminenti ovunque, mentre il Dharma, “la via della verità, della purificazione, della disintossicazione”, secondo Buddha, passa per la comprensione/ consapevolezza che l’essenza del mondo è la sua instabilità, la sua non permanenza, aniiccia (tutto è passeggero, anche il dolore e il piacere). E diviso fra razionalità cristiano-occidentale, con il suo inestinguibile desiderio/bisogno di giustizia in terra, e spiritualità orientale (Lascia andare… lascia andare… Non attaccarti a niente… Non desiderare niente… mormora il maestro buddhista del ritiro di Pongyang), Terzani nel suo libro del 1995 non fa che chiedersi, di pagina in pagina, quanto potrà durare un mondo così retto esclusivamente dai criteri immorali dell’economia (Non ci sono più ideali, non ci sono più fedi, non ci sono più sogni -scrive nel cap. 16, definendo la “depressione” un diritto e quasi ultima spiaggia di “umanità”) e si lascia andare al “suo” personalissimo sogno/utopia di un’isola ancora abitata da una tribù di poeti in serbo per quando dopo il medioevo del materialismo l’umanità dovrà ricominciare a mettere altri valori nella propria esistenza. Finirà mai tale medioevo?