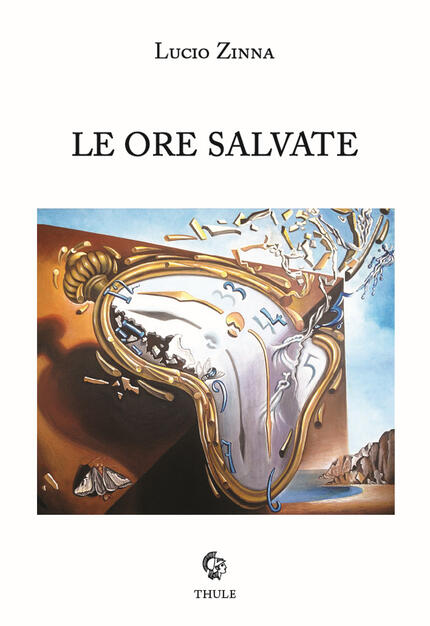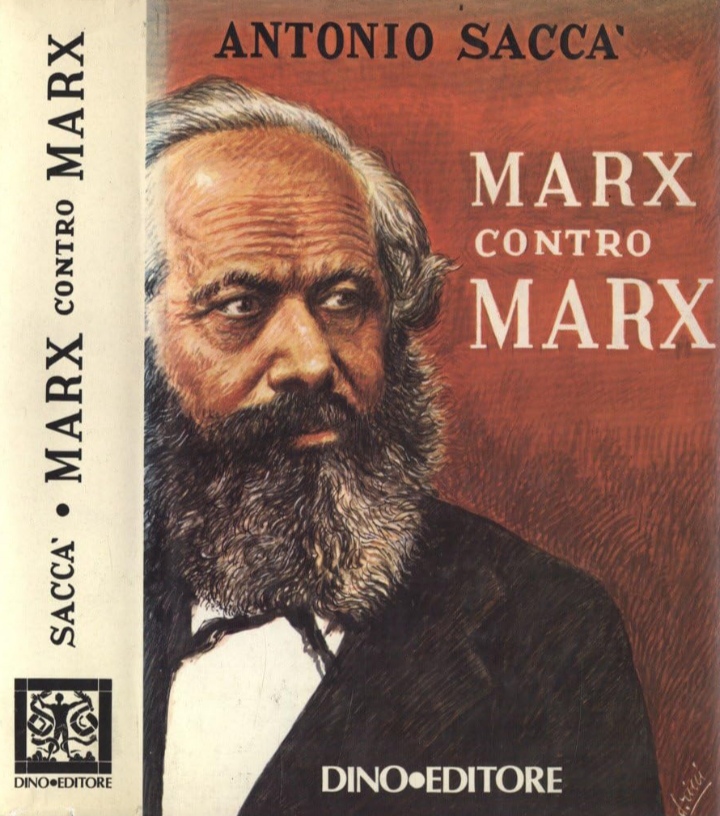Recuperi/3 - "L’assiolo" di Nino Aquila
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 23 Aprile 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2401
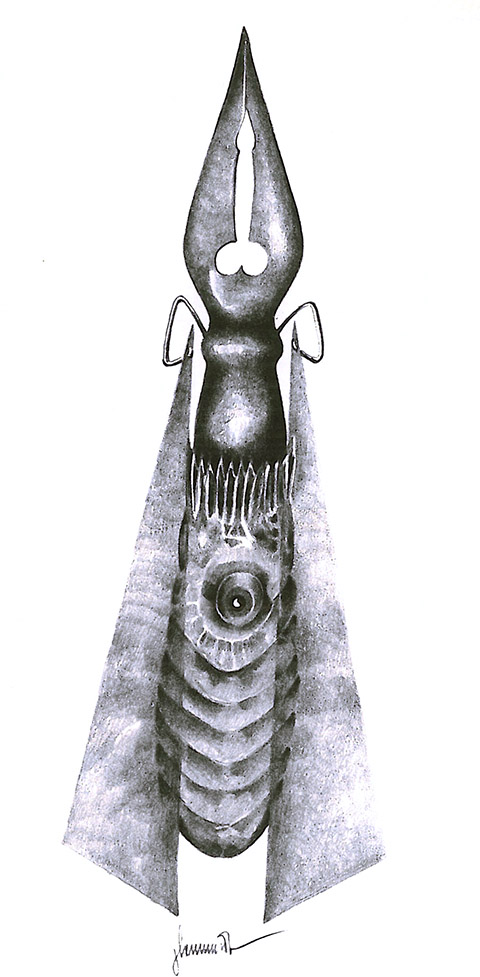 Una piatta lingua di terra chiudeva ad occidente il golfo che si stendeva lungo il dolce contorno del suo arco sino ed oltre il luogo in cui sorgevano le case le cui mura erano dipinte dalla bianca calce o avevano una tenue colorazione indaco, per l’aggiunta di azzolu alla mistura colorante.
Una piatta lingua di terra chiudeva ad occidente il golfo che si stendeva lungo il dolce contorno del suo arco sino ed oltre il luogo in cui sorgevano le case le cui mura erano dipinte dalla bianca calce o avevano una tenue colorazione indaco, per l’aggiunta di azzolu alla mistura colorante.
Vi abitavano i non molti pescatori che rappresentavano il nucleo principale di quel minuscolo centro abitato.
La lingua di terra non distava molto dall’agglomerato delle casupole e raccoglieva in ampie pozzanghere l’acqua piovana e quella salata che talora la maretta più intensa vi scaraventava o che si infiltrava attraverso la spiaggetta di ghiaia che cingeva la riva.
In quelle pozze si muovevano lentamente i rospi e le raganelle che, a sera, facevano risuonare il loro rauco verso cadenzato.
Sulla superficie, rosse, verdi, azzurre, svolazzavano le libellule le cui ampie ali simili a vetrate rifulgevano agli ultimi raggi obliqui del sole.
Ma, assieme ad esse, imperversavano le zanzare, principali e micidiali ospiti del pantano; quello che gli abitanti del posto chiamavano “ ‘a punta da lena” per le fetide esalazioni che da esso si levavano.
E le zanzare non si fermavano solamente sul pantano, sulla lingua di terra che lo circondava, ma - specialmente al tramonto - assetate di sangue, si precipitavano in stormi sulle case che sorgevano lungo il golfo.
Se ne vedevano le conseguenze, non solamente sugli anziani, ma purtroppo anche su i più giovani: la loro pelle era non solamente pallida, ma gialla ed il loro addome era globoso a causa dell’enorme ingrossamento della milza; avevano contratto la malaria, talora la terzana maligna, ad opera delle punture di quei minuscoli, fragilissimi insetti portatori di malattia e spesso di morte.
Ad onta delle compresse di chinino, gialle o di colore carminio, che lo Stato distribuiva gratuitamente già per la prevenzione, ma soprattutto per la terapia.
Né la maledetta anòfele risparmiò me.
Non avvertii la sua puntura; forse anestetizzata dal sonno, durante la notte.
Avvenne durante l’estate, nei mesi delle vacanze estive trascorse in casa della nonna in quell’ambiente splendido caratterizzato dalla luce, dal caldo, dal verde ed esaltato dall’azzurro del cielo e del mare: un luogo dove ogni cosa sembrava dovesse essere di segno positivo.
Oltretutto, quando la libertà più assoluta, la mancanza delle limitazioni imposte dalla vita cittadina, i bagni marini, i giochi anche rudi con i coetanei del luogo rappresentavano un diversivo affascinante.
E, invece, un giorno - appena svegliatomi da un sonno sereno confortato dalla frescura della brezza marina che penetrava attraverso le imposte socchiuse - fui colto dai brividi.
Non un sottile serpeggiare lungo la schiena, come se il fresco notturno fosse stato più intenso del dovuto, ma brividi sempre più intensi che portavano ad una contrazione di tutto il corpo, che facevano avvertire una profonda sensazione di malessere, una dolorosa percezione di quell’irrefrenabile scuotimento.
Di tale violenza che i moti che ne derivavano si trasferivano al letto sul quale giacevo, ai trespoli che lo sorreggevano i quali sospinti da quella convulsa energia irrefrenabile finirono, poco alla volta, con lo scostarsi dal muro al quale erano addossati trascinando per diversi centimetri il letto verso il centro della camera.
Era il preludio all’insorgenza di una febbre da cavallo.
La crisi acuta si era appena attenuata, mentre mamma, la nonna, gli zii cercavano di confortarmi ed assistermi ed io provavo un rilassamento generale del mio corpo e potevo credere che tutto si fosse concluso, quando imponente, con un faccione appena segnato da un paio di baffetti striminziti e dagli occhiali a pince-nez, giunse il dottore Di Dino.
Aveva un’aria severa e, per me, poco rassicurante; e non avevo torto.
Infatti, ascoltata la descrizione dei sintomi, auscultato il torace, palpatomi l’addome, sentenziò: “Malaria! A scanso di rischi bisogna praticare subito le iniezioni di chinino”.
Armeggiò nella sua borsa nera, trasse fuori fiala e siringa che, stretta nella sua manaccia, mi parve un’arma micidiale e si avvicinò a me che lo vidi incombere preso da terrore.
E, più che il dolore dell’ago infisso nella natica, fu il terribile bruciore indotto dal farmaco iniettato che, mentre la mamma mi teneva con fermezza, mi fece emettere un terribile urlo,
Il dottore, accigliato, sbarrò gli occhi; li vidi solamente per un istante ingranditi attraverso le sue lenti: le lacrime fluenti subito dopo annebbiarono ogni cosa.
Fu così per molti giorni.
Poi le crisi di brividi che preludevano agli accessi febbrili si attenuarono, scomparvero.
Ma avvertivo una profonda prostrazione, pur se consolato dal non vedere più quell’omaccione penetrare nella mia camera da letto, armato della sua borsa nera contenente gli strumenti micidiali con i quali aveva infierito sul mio corpo.
Mamma mi diceva sorridendo “sei palliduccio, ma ormai sei guarito”; e sapeva di mentire. Il mio incarnato dorato determinato dal sole estivo che in mare e sulla spiaggia mi aveva abbronzato, era scomparso; la mia pelle era asciutta, giallastra (lo vedevo guardandomi le braccia e le mani), ero smagrito ed esausto.
Una sera ebbi difficoltà a prendere sonno, ma serenamente avvolto dal buio e dal silenzio, mi concentravo su me stesso lieto che il peggio (il dottore Di Dino) fosse passato.
Ad un tratto un suono che sino ad allora non avevo mai avvertito mi fece aprire le palpebre.
Chiù...chiù...chiù...chiù...
Era un canto, un canto costituito da un unico suono, pastoso, misterioso, ritmico sul quale concentrai il mio udito.
Seppi, dopo, che si trattava del verso notturno dell’assiolo. Non l’avevo mai udito poiché quando il volatile era uso emetterlo io, spinto dalle cure materne e dalla stanchezza di una giornata attivissima per i giochi marini, già dormivo.
Ne rimasi incantato; era bella quella voce nella notte!
Mi evocava sensazioni di serenità misteriose, di lontananze e di esseri sconosciuti; ed il ritmo costante, musicale, mi parve godibilissimo, anzi mi conciliò il sonno.
Sarei tornato ad ascoltarlo, e lo attendevo, nella tarda sera, quando negli anni successivi, ormai non più bambino, aspettavo di udirne la voce con sincero godimento.
Certamente essa non proveniva ormai dal medesimo assiolo che mi aveva incantato tanti anni prima, ma il suono ed il ritmo erano assolutamente uguali.
Gli anni trascorsero; io tomai ogni estate a Marina in casa di nonna Teresa, la madre di mio padre, e alla gioia di quelle vacanze si aggiungeva il piacere di attendere l’appuntamento notturno con l’assiolo.
Ero ormai alla soglia della laurea in medicina.
Si era nel pieno dell’inverno del 1949. Un inverno particolarmente rigido, gelido.
Ci fu comunicato che le condizioni di salute di nonna Teresa, che soffriva di disturbi cardio-circolatori, erano improvvisamente peggiorate; forse anche in relazione alle condizioni climatiche.
Ci precipitammo a Marina: i miei genitori, i miei fratelli ed io.
Io che mi ero da sempre recato in quel luogo, a me tanto caro, quasi sempre in estate, fatta eccezione per qualche breve permanenza natalizia, al nostro arrivo rimasi senza fiato; il paesino era coperto di neve, ma addirittura il manto candido si era esteso anche sulla spiaggia, sino alla battigia.
Neve e spuma delle onde si confondevano in un inusitato bianco confluire.
Nonna respirava male; si spense serenamente il 3 marzo.
Perdevo un punto di riferimento affettivo di grande importanza ed ero afflitto dal rimpianto che non avrei potuto più darle la gioia, da lei intensamente attesa, del conseguimento della mia laurea che sarebbe giunta solamente qualche mese dopo.
Vegliai accanto al suo letto sino al momento della cerimonia funebre. La guardavo intensamente: le mani ed il viso, di un pallore madreperlaceo, spiccavano fortemente nel contrasto con l’abito nero che aveva indossato dal giorno della morte di nonno Nino, che l’aveva lasciata - autoritaria signora della casa e della famiglia - un anno prima che io nascessi.
La guardavo commosso poiché sapevo che non avrei più ascoltato la sua voce affettuosa, le sue domande su i miei studi e la mia vita, non le avrei più sentito raccontare le vicende della vita del mio nonno paterno sconosciuto.
A notte dischiusi, nonostante il freddo, le imposte dello studio del nonno, dove da alcuni mesi la nonna aveva preso alloggio - al piano terraneo - per non affrontare le scale che portavano a quello superiore dove si trovava la sua camera nel quale troneggiava un letto matrimoniale dalle spalliere di chiaro e lucidissimo rame.
Ad un tratto ebbi un soprassalto.
Chiù...chiù...chiù...
Il verso dell’assiolo,
Tesi l’orecchio, non pensavo di poterlo udire in inverno, a quell’ora ed in quel momento.
Ne fui sorpreso anche perché quello che era il suono che una volta mi aveva incantato, in quel momento mi parve che assumesse una connotazione lugubre: ossessiva, male augurante.
Mi parve che al cospetto di quel letto candido su cui giaceva la sagoma nera dell’abito della nonna esso stesse cadenzando il trascorrere del tempo: i minuti, i secondi, gli istanti che avrei potuto trascorrere ancora accanto a quell’essere ormai privo di vita che mi era stato tanto caro.
Non volli più ascoltarlo; mi precipitai a chiudere le imposte.
Né potei fare a meno di chiedermi, immediatamente e nei giorni successivi, come mai il medesimo verso, il medesimo suono, lo stesso ritmo che in passato mi avevano affascinato, improvvisamente avessero per me assunto una percezione, un valore tanto diverso.
E compresi, allora, che nulla possa essere giudicato come il bello o il brutto, come il buono o il cattivo in assoluto.
Mi resi conto che il positivo contenga in sé il negativo e viceversa.
E che siano le condizioni soggettive, momentanee, occasionali a farcene percepire l’uno o l’altro aspetto.
L’amatissimo e splendido golfo di Marina, o almeno una sua parte, - tanti anni prima - era stato per me all’origine della malaria e delle sofferenze che me ne erano derivate; il “chiù”, in occasioni differenti, mi aveva procurato piacere ed angoscia.
Era stato l’assiolo ad avermelo insegnato.