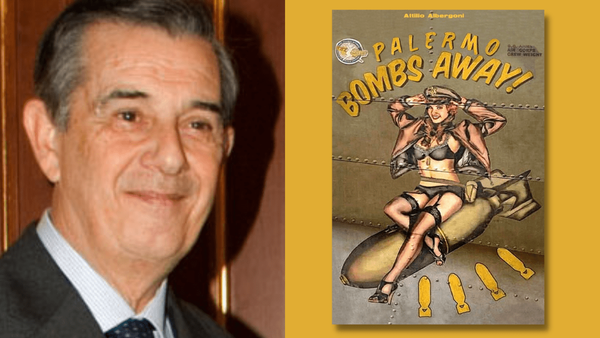LO SGUARDO DI ORFEO E IL CARPE LUCEM
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 23 Aprile 2019
- Scritto da Guglielmo Peralta
- Hits: 2908

Dire non è mai abbastanza ed è sempre relativo quando ci si trova di fronte a un’opera complessa, così bella e di spessore che verrebbe voglia di fermarsi a contemplarla, come quel personaggio di Thomas Bernhard, Reger[1], che ogni mattina si reca al museo, sedendosi sempre sulla stessa panca, di fronte allo stesso quadro[2]. Ma non per trarne come lui la monotona ripetizione della vita, ma per r-esistere contro la quotidianità, per riempirne il vuoto. Di ciò mi convincono le grandi opere che sollecitano lo sguardo a cogliere la bellezza al di là della dichiarata scomparsa o morte dell’arte; a godere dell’assenza di Van Gogh, del respiro della sua stanza, dove il suo spirito aleggia, o della “Metamorfosi” kafkiana, che è una ‘caduta’ verso l’infinito. Ritengo che l’avventura di un’opera sia sempre il «carpe diem», non nel senso proprio di cogliere l’attimo, ma dell’impossibilità di fermarlo, di trat-tenerlo. E l’attimo non è la frazione incalcolabile del tempo, ma la sua essenza e la sua misura. Dentro l’attimo c’è un’intera esistenza, la possibilità di viverla pienamente; ci sono i sogni, i desideri, le attese; c’è il tempo senza memoria e la r-esistenza contro la fuga. Ed è lo sguardo di Orfeo, che ci fa ‘orfani’ di Euridice. Perché lo sguardo non ferma la vita. Eppure tutto vi è contenuto; in esso dimora l’universo, ha casa l’infinito. E tuttavia, tutto sfugge in quell’attimo per l’impossibilità di contemplarlo. Tutto allora si traduce in linguaggio e si resta in attesa del significato, del canto perduto nel volto violato e per sempre inguardabile di Euridice. Se il Significato accadesse, sarebbe l’Infinito e lo coglieremmo nell’attimo. La nostra esistenza sarebbe lo stare delle cose, non avremmo bisogno di oltrepassarle, di oltrepassarci. Ci consoleremmo con lo sguardo di Orfeo, ci rassegneremmo alla perdita di Euridice. Perché là dove la verità è salva, è possibile ai mortali cantare, r-esistere.
Scrivere è distogliere lo sguardo da Euridice; è non trasgredire il divieto; è l’impossibilità di fermarsi a contemplare l’oggetto del desiderio e, dunque, la necessità che il volto amato sia consegnato per sempre alla notte, pena l’interruzione del canto, la fine della scrittura e la morte: come accadde a Orfeo, dilaniato dalle Menadi dopo che, nell’atto di disubbidire, gli fu concesso dal dio degli inferi un istante di grazia, di vedere la verità, di carpirla nel volto di Euridice consegnata all’Ade[3], all’oscurità impenetrabile. L’Opera è l’oggetto d’amore dello scrittore ed è il volto inguardabile a lui vietato, ma senza espresso divieto, sì che sempre si rinnova il rito della scrittura, e non cessa mai la brama e l’azzardo dello s-guardo, che si avventura fin dove l’assenza del confine gli consente di conquistare nuovi spazi senza mai giungere all’impossibile meta, alla visione della sorgente. Perché, anche se vede più degli occhi, allo s-guardo è concesso solo di sognare e godere di quegli istanti di grazia che sono le illuminazioni, gli improvvisi bagliori, che il «fiat lux» emana dalla sua notte eterna. Essi ri-velano l’invisibile presenza della Parola, che da “ordine” si fa annuncio ripetibile nell’atto della creazione. Ed è, quest’atto, il «carpe lucem», dove il «fiat lux» si “concede” nelle forme del sogno, quasi ad ovviare, a compensare il tacito divieto di guardare. Nello squarcio della sua coltre, la notte resta inviolata, al di là delle orme di luce che segnano il cammino della scrittura verso il suo principio imperscrutabile.
Vedere la verità fu il sogno di Adamo, che trasgredì il divieto di mangiare dell’albero per soddisfare il piacere di guardare, di “mangiare” con gli occhi il frutto della conoscenza, per cogliere la vita in cambio del destino immortale, della propria natura divina troppo divina. Più che le “delizie” lo attrassero il richiamo misterioso della vita e la promessa delle bontà nascoste nel frutto simbolico e proibito. Non gli bastò avere negli occhi il paradiso per goderne eternamente. Volle esistere, guardare in faccia la vita. Strappato dal seno divino e divenuto umano, troppo umano, scoprì la propria nudità e desiderò di tornare a contemplare la perduta bellezza. Il poeta condivide con Adamo la caduta. Reso dall’atto creativo meno umano, più divino, sconta il peccato originale con la passione della scrittura: con l’angoscia e con l’amore, con la brama di contemplare il volto della Poesia e soddisfare totalmente la vista. L’esistenza è il paradiso perduto, che possiamo solo sognare senza poterlo immaginare. Ed è il sogno incessante della scrittura, che non lascia vedere l’oggetto desiderato. Solo con la morte è possibile raggiungere l’Opera, che pone fine al cammino. Non si può vedere la verità e restare vivi. Per questo ad Adamo fu proibito il frutto della vita, per questo gli fu tolta l’immortalità. Per lo stesso motivo, fu proibito ad Orfeo di guardare la morte nel volto di Euridice e ai naviganti di seguire la voce seducente delle Sirene. E se a Ulisse fu concesso dal suo cieco Cantore di sentire il loro canto, gli fu, tuttavia, impedito di liberarsi dei lacci che lo tenevano legato all’albero maestro e di cedere alle lusinghe dei geni della morte. Allo stesso modo agiti dalla promessa di conoscenza e dalla brama di guardare in faccia, rispettivamente, la vita, la morte, il canto (“suono di miele”), Adamo, Orfeo, Ulisse, questi “eroi” e “dannati”, al tempo stesso, sono “figure” inseparabili, legate dal medesimo destino: quello di trasgredire e perdersi nell’abisso di uno sguardo non separato dagli occhi. A differenza di loro, il poeta è il vate “cieco”, cui tuttavia non giova la “cecità”, che accende il suo sguardo. Egli, infatti, non riesce a vedere tra le infinite visioni e, pur non trasgredendo alcun divieto, gli è solo concesso di sognare. Perché l’oscurità necessita alla scrittura, la quale solo nella sospensione del «fiat lux» può sempre iniziare. L’invisibile, quella zona oscura del «nulla», impenetrabile al pensiero, rende incessante il processo creativo preservandolo dalla fine. La «luce iniziale», che così si ritrae nell’abisso, nel buco nero precluso allo sguardo, lascia filtrare nel sogno le proprie ombre, quel lucore che ne “rivela” la presenza e che sfolgora negli istanti di grazia del «carpe lucem», dove il «fiat» che diede “ordine” al creato è il «fuit» irripetibile, l’Evento inimmaginabile, la cui assenza si avverte tanto di più quanto di più esso concede allo sguardo di vedere, di cogliere quei lacerti di luce.
Il medesimo sguardo unisce Adamo, Orfeo, Ulisse e il poeta; ad esso è congiunto il desiderio irresistibile di “mangiare” dell’albero della conoscenza, di “gustare” il frutto del mistero. Se il primo uomo lo coglie in paradiso preferendolo alle altre delizie, il figlio di Calliope ne ha una fugace esperienza nella catabasi. All’eroe greco non basta sentire il canto delle sirene; egli vuole guardarle, vuole “nutrire” gli occhi con la loro vista e dopo il ritorno ad Itaca, dove termina il racconto di Omero, andrà a cercare, probabilmente, proprio quelle in-cantatrici oltre le Colonne d’Eracle, dove perderà la vita. Anche il poeta, che ama il canto e l’ascolta nel silenzio della notte feconda, vuole “mangiare” dell’albero, “nutrirsi” della visione, tanto più che a lui non è proibito espressamente di volgersi alla sorgente. Tacito resta il divieto, ed è l’ineffabilità che lo salva dalla morte. Se, da un lato, la scrittura è angoscia, brama insoddisfatta dell’Opera, se essa è quell’anelito, quello stato d’animo, definibile nel migliore dei modi col termine di Sehnsucht, ed è, al tempo stesso, il mezzo che ci fa prossimi a quell’«oltre» che dall’oscurità profonda rilascia le orme di luce a segnare il cammino; se, ancora, essa è il segnavia ed è la via stessa che promette ed orienta il poeta nel suo peregrinare; se è la possibilità e l’aspettativa del ritorno, se questo si traduce nel nostos, termine gemello della Sehnsucht essendo insieme struggimento, nostalgia, desiderio inappagato di approdare all’eden della Poesia, che per il poeta è il paradiso perduto, dall’altro lato la scrittura è salvezza. Perché nelle sue molteplici forme e attraverso le infinite opere e il suo incessante fluire si “manifesta” l’Infinito; perché luce sacra dell’ombra invisibile è la parola che offre il grembo all’idea. Perché, soprattutto, scrivere è non morire dal momento che non si può «vedere» la verità, non si può contemplare il volto divino dell’Opera e restare vivi.