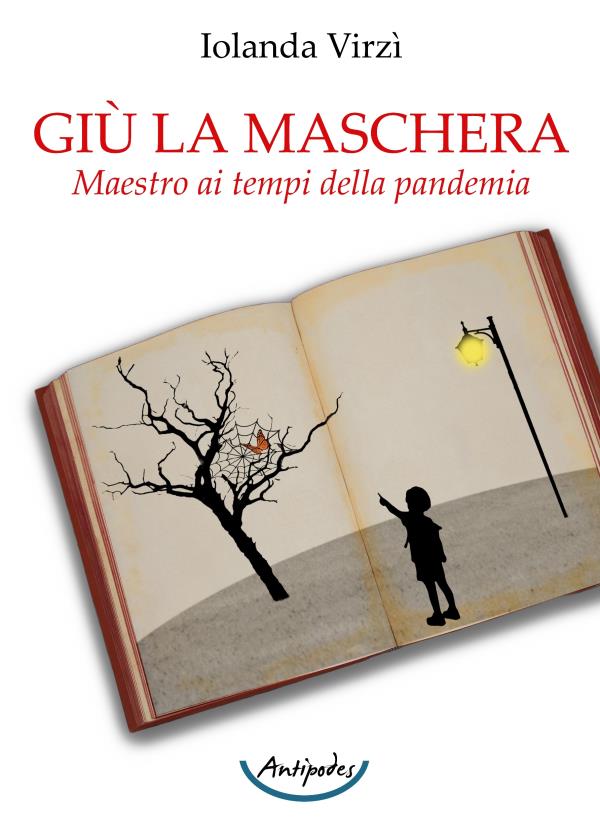“Il senso di una “logica poetica”. Squarci vichiani” di Giuseppe Modica
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 19 Luglio 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2860
 1. Identità semantica di mythos e logos
1. Identità semantica di mythos e logosForse in nessuno degli autori del pensiero moderno il mito riveste un’importanza fondamentale come accade in Giambattista Vico. Infatti la storia, che, com’è noto, costituisce l’oggetto principale della riflessione vichiana, è il prodotto straordinario del mito, precisamente il frutto di una implicazione reciproca, d’una identità semantica tra mythos e logos: il linguaggio originario è mito e/o il mito è linguaggio.
Per attestare la tesi del mito come istitutore della storia bisogna anzitutto far riferimento a quell’unica lingua di cui i primi uomini – i «fanciulli del genere umano» - erano capaci, qual è propriamente la favola. Non a caso la «chiave maestra» della Scienza nuova è, per Vico, la «discoverta» «ch’i primi popoli, per una necessità di natura, furon poeti», ovvero «parlarono per caratteri poetici», come dire attraverso l’immagine fantastica.
La «Logica poetica» della Scienza nuova seconda infatti esordisce con la tesi che logos originariamente «significò “favola”»; e subito dopo precisa che favola si tradusse in italiano «”favella”», cioè parola. Ora, la prima favella «nacque mentale», e, perciò, muta, cioè dovette cominciare con cenni o atti o corpi ch’avessero naturali rapporti all’idee», ossia dovette essere mitica, secondo l’ingegnosa derivazione vichiana di mutus da mythos, di muto da mito. Insomma, l’identità tra logo e mito è scandita da questi passaggi: logos – favola – favella – parola muta – parola – mito.
Ne sarebbe conferma il fatto che il mito archetipico, cioè Giove, è la «prima favola» creata dal bestione, il quale - emozionalmente scosso dall’irrompere improvviso del tuono e del fulmine - alza gli occhi e s’accorge del cielo; anzi, la «prima civile metafora» è proprio questa: «che Giove fosse il cielo, che scrivesse le leggi con la folgore e le pubblicasse col tuono».
Perciò Giove è la concrezione del nesso originario – o dell’identità semantica - tra mito e linguaggio. Egli è precisamente il cennatore, secondo l’acuta derivazione vichiana di «numen» da «nuo», cioè dall’atto proprio del «cennare». Giove può infatti emanare i suoi severissimi comandi in quanto è il «nume», e lo è in quanto è capace di produrre «cenni». Ora i cenni di Giove sono enigmatici: per un verso, messaggi velati di mistero e, perciò, bisognosi d’interpretazione, e, per un altro verso, «parole reali», in quanto i primitivi «”fingunt simul creduntque”», e dunque lo sono in virtù d’una coessenzialità tra finzione immaginativa e credenza, nel senso che i primitivi credono pienamente nell’oggetto della loro finzione creativa.
2. Lo stato eslege dell’erramento ferino: connotazioni del mito
Per comprendere adeguatamente il significato originario del mito bisogna calarsi nello stato eslege dell’«arbitrio incertissimo». Tale stato è governato dal culto dell’autón, in quanto è abitato da un primitivo capace di rivolgere le proprie attenzioni solo a se stesso. Non a caso, per descrivere la sua condizione, Vico usa i termini di «solitudine» e «amor propio», riconducendone la causa alle «passioni bestiali» che lo tiranneggiano in quanto lo inducono ad amare «solamente la sua salvezza» e a seguire esclusivamente «l’utilità propia». E le utilità, quando sono perseguite unicamente dal punto di vista della corporeità di cui sono sostanziate, lungi dal coesionare gli uomini tra loro, li dividono poiché ne esasperano l’istintivo individualismo.
D’altra parte, pur possedendo in embrione la capacità di «umanamente pensare», i primi uomini sono ancora «stupidi» e «selvaggi» bestioni, incapaci anche solo di avvertire «con animo perturbato e commosso» e in grado appena di sentire «senz’avvertire», sicché quando Vico definisce il loro vagare per la gran selva della terra un vero e proprio «erramento ferino», sottintende che esso è privo d’ogni criterio e d’ogni norma che non siano, ancora una volta, quelli istintuali della libidine e del capriccio.
Perciò la possibilità che questo sterile individualismo si apra all’alterità e si faccia germe d’un primigenio nucleo comunitario non può che passare attraverso l’accadere d’un evento che, squarciando le mura anguste della cittadella dell’autón, distolga il bestione da sé e ne fermi l’erramento fine a se stesso: è l’avvento sconvolgente del mito sotto le sembianze di un dio dal gran «corpo animato» che atterrisce con folgori e tuoni.
Da questo punto di vista, il mito non è un’entità ipostatica o, ancor peggio, un ens rationis o un flatus vocis, bensì la proiezione concretissima della necessità di trovare una regola e di dare un assetto all’erramento ferino. Il mito, insomma, è il segno visivo - perciò muto e figurato - attraverso cui il primitivo esprime e comunica e, anzi, racconta un’esperienza legata ai propri bisogni vitali e urgenti. In tal senso il mito ha una valenza storica, ma esso mostra al tempo stesso una valenza metastorica, poiché quell’esperienza è ingegnosamente proiettata in una dimensione che è trascendente in quanto il primitivo - che pure l’ha antropomorficamente prodotta - non può e non sa dominarla, anzi ne è dominato.
In proposito va sottolineata la funzione imprescindibile dell’ingegno come attività mitopoietica. L’ingegno è propriamente ars inveniendi, e, come tale, strettamente connesso con quella fantasia che, non a caso, è definita da Vico «ingenii oculus». L’ingegno è infatti facoltà dell’acuto, cioè dell’attitudine a cogliere somiglianze fra cose disparate e diverse. E cosa di più diverso tra la corporeità dei bestioni e il cielo tonante? Eppure i bestioni, in quanto ignorano le cause naturali che producono un fenomeno, vi trasferiscono la loro natura, rinvenendo una somiglianza tra il proprio corpo smisurato e la grandiosità del cielo tonante. Perciò, attraverso la potenza dell’attività mitopoietica, il cielo tonante diventa un gran «corpo animato». Non a caso Vico definisce in proposito il mito come l’«impossibile credibile»: impossibile, perché «dà mente al corpo», vita alla materia, anima all’inanimato; credibile, in virtù dell’equazione tra finzione immaginativa e credenza.
In tal senso il mito è vera narratio. La finzione immaginativa del primitivo implica, sì, una falsità di contenuto - poiché il corpo non è una divinità -, ma, insieme, implica una verità di forma, cioè del significato rappresentato da quel contenuto. Infatti il primitivo teme Giove, che pure egli stesso ha creato, in quanto lo crede vero. Perciò i miti non sono astratti favoleggiamenti, o, come pretende la boria dei dotti, allegorie filosofiche pregne di sensi mistici che celano dottrina ed erudizione, ma «vere e severe istorie» che sorgono non per convenzione ma per necessità di natura.
Quando “il cielo finalmente folgorò, tuonò con folgori e tuoni spaventosissimi, […] pochi giganti […] spaventati ed attoniti dal grand’effetto di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi ed avvertirono il cielo. E perché in tal caso la natura della mente umana porta ch’ella attribuisca all’effetto la sua natura […] e la loro natura era […] d’uomini tutti robuste forze di corpo, che urlando, brontolando, spiegavano le loro violentissime passioni, si finsero il cielo essere un gran corpo animato, che per tale aspetto chiamarono Giove, […] che col fischio de’ fulmini e col fragore de’ tuoni volesse loro dir qualche cosa”.
(G.B. Vico, Principi di Scienza Nuova -1744 -, 377)
RIFERIMENTI
G.B. Vico, Principi di Scienza Nuova (1744)
G. Modica, I cenni di Giove e il bivio di Ercole, Milano, Franco Angeli, 1988
Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda www.acrocori.wordpress.com