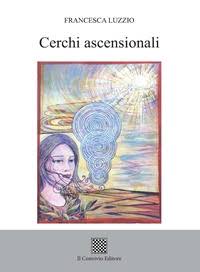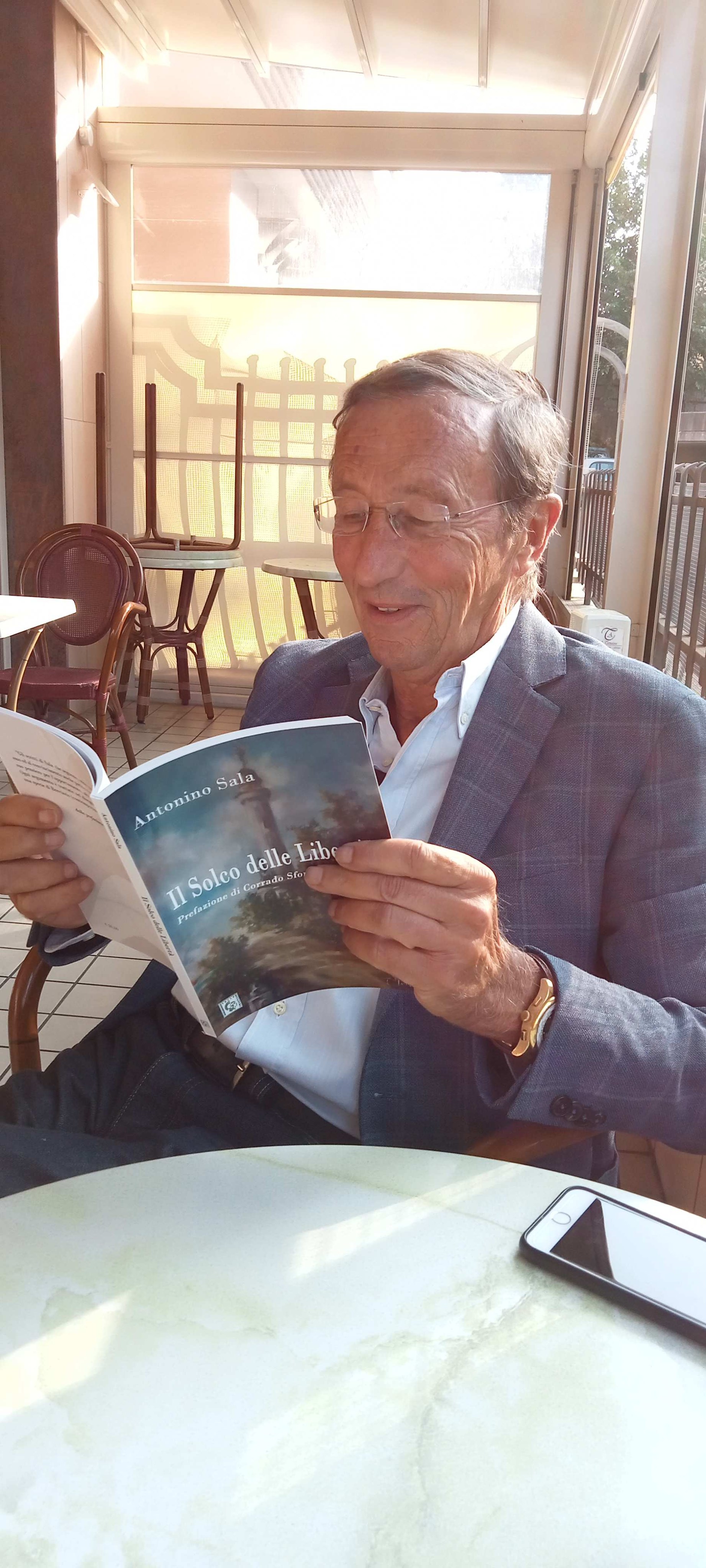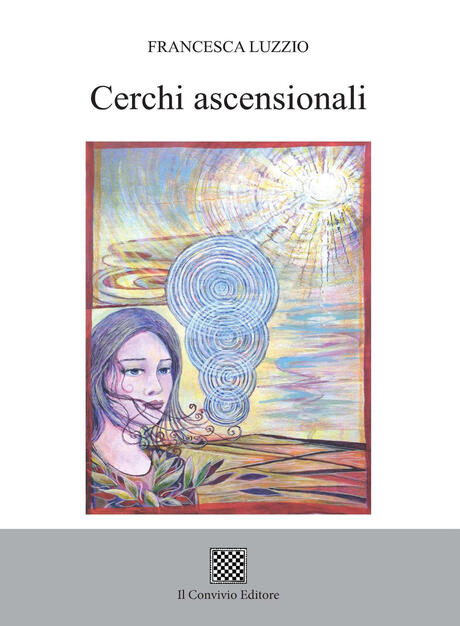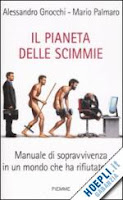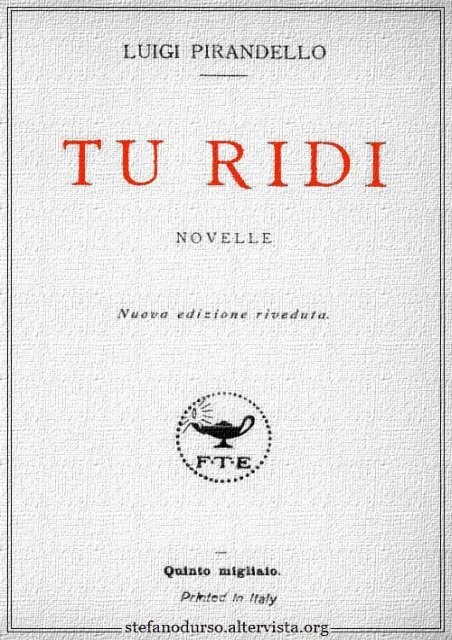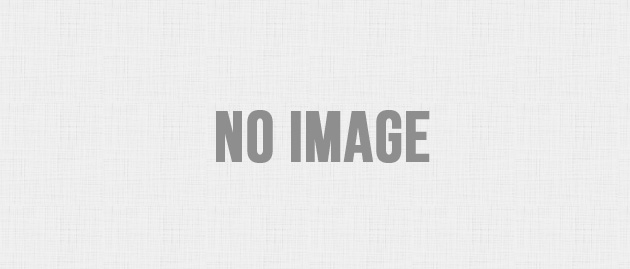Almeno il sentimento – di Guglielmo Peralta
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 26 Settembre 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 484
 Questa nuova silloge di Tino Traina richiede una particolare riflessione a partire dal titolo, il quale esprime un desiderio e una mancanza: l’uno originato, suscitato dall’altra. La mancanza è della parola, che non sa cogliere, oltre i propri confini, l’ineffabile: che non sa descrivere una visione celeste o un’intensa emozione spirituale; che si rivela fragile, instabile, incapace di penetrare l’interiorità profonda, di ‘manifestare’ il nostro essere. Grande e incolmabile è la distanza tra vis intellettiva e verbum oris.: “La parola non dice quel che siamo”. E qui possiamo aggiungere con Montale, che essa può soltanto dire «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». Accanto a questa tensione più intima, filosofica, che muove alla ricerca di un’impossibile identità, forte è, in Traina, il desiderio della parola in grado di sorreggerci e consolarci nel cammino esistenziale, “che commuova /nel giusto verso almeno il sentimento” e non sia con esso in contrasto. E qui iI termine “verso”, oltre a indicare il luogo dove volgersi, ossia, il mondo dei sentimenti, sta a significare la parola poetica, la sola capace di accostarsi a quel mondo ‘segreto’ e suscitarne la bellezza, la quale non è sempre nel dire, ma è, soprattutto, nel sentire. Al di là della sua evanescenza, la parola “resta ovunque ci sia /una veglia”, uno sguardo che ‘veda’ in profondità e contempli nel silenzio lo splendore che ci abita. E questo è il sentimento: ciò che veramente resta, quel “movimento tutto intero del petto” che non ha bisogno di essere detto per essere ‘ascoltato’, riconosciuto, ac-colto.
Questa nuova silloge di Tino Traina richiede una particolare riflessione a partire dal titolo, il quale esprime un desiderio e una mancanza: l’uno originato, suscitato dall’altra. La mancanza è della parola, che non sa cogliere, oltre i propri confini, l’ineffabile: che non sa descrivere una visione celeste o un’intensa emozione spirituale; che si rivela fragile, instabile, incapace di penetrare l’interiorità profonda, di ‘manifestare’ il nostro essere. Grande e incolmabile è la distanza tra vis intellettiva e verbum oris.: “La parola non dice quel che siamo”. E qui possiamo aggiungere con Montale, che essa può soltanto dire «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». Accanto a questa tensione più intima, filosofica, che muove alla ricerca di un’impossibile identità, forte è, in Traina, il desiderio della parola in grado di sorreggerci e consolarci nel cammino esistenziale, “che commuova /nel giusto verso almeno il sentimento” e non sia con esso in contrasto. E qui iI termine “verso”, oltre a indicare il luogo dove volgersi, ossia, il mondo dei sentimenti, sta a significare la parola poetica, la sola capace di accostarsi a quel mondo ‘segreto’ e suscitarne la bellezza, la quale non è sempre nel dire, ma è, soprattutto, nel sentire. Al di là della sua evanescenza, la parola “resta ovunque ci sia /una veglia”, uno sguardo che ‘veda’ in profondità e contempli nel silenzio lo splendore che ci abita. E questo è il sentimento: ciò che veramente resta, quel “movimento tutto intero del petto” che non ha bisogno di essere detto per essere ‘ascoltato’, riconosciuto, ac-colto.
Quell’Almeno che precede il sentimento cessa di essere un semplice avverbio con valore limitativo ed assume il carattere della necessità assoluta, dell’urgenza di scongiurare tutto il male che grava sul mondo, dove I beni più comuni: “giustizia, amore e libertà / i beni questi dell’umanità” sono dissipati, assenti: “Pur essendo di tutti nella vita / nella vita di tutti non ci sono!”. Ciò sembra suggerire il nostro poeta, che ripone la salvezza nel sentimento, vero, autentico: quello che la parola rivela quando attinge alla sorgente della poesia. Ritroviamo in Tramonti il rapporto tra parola e sentimento, e la difficoltà di esprimere ciò che si prova: “Di parole non sempre / vestirai ciò che senti”. Più della parola è l’ “occhio” a svelare il sentimento di ciò che non ha voce; e questo concetto è reso con l’immagine di una “foglia cadente” che “dà tutto il suo cuore” nel momento del distacco. E così, la “rosa” morente, che invoca di essere ‘ac-colta’, recisa con quel gesto naturale, necessario, che ricorda l’‘eutanasia’. Qui, la morte non è negazione della vita ma l’esito amaro della “vita / che si stanca d’amare”. Il fine vita, dunque, è l’atto d’amore esausto, non una condanna; è un passaggio necessario; forse una nuova certezza che travolge ed esalta la vita: quell’oltre imperscrutabile che, nelle ultime lapidarie parole di Amleto, è il silenzio, cioè il resto. Per Traina, ciò che “resta” è il rumore della caduta nel “niente” di “ogni cosa che c’era”. Ed è il silenzio: quel dire che si cela oltre la parola e sta al centro della silloge, come promessa inevasa e sempre differita che apre al sentimento come possibilità di accedere a una comprensione profonda del reale, oltre la nostra ignoranza quotidiana, che è l'incapacità di guardare le cose come realmente sono. Comprendere il reale attraverso il sentimento è accettare le difficoltà della vita; significa fare fronte alla sofferenza, al dolore, all’incompiutezza e alla “lenta dissolvenza” del tempo esistenziale lasciandosi sostenere dai ricordi, dagli affetti, da ciò che amiamo. La vita è un transito, un viaggio nel tempo e nella memoria, e questa silloge è il suo canto delicato e struggente, pregno del desiderio di restare, di attendere “ancora un’alba, un altro giorno” contro il cupio dissolvi: oggi, l’irrazionale progressiva autodistruzione dell’uomo, incapace, “stanco di amare”. L’impermanenza è l’amara verità che può aiutarci a vivere con sentimento e maggiore consapevolezza, apprezzando, amando ogni momento ciò che è, riconoscendo l’essenza, il giusto valore e la dolcezza delle cose che passano. La presa di coscienza della finitudine e la cognizione del dolore, mitigato dal sentimento, predispongono alla vita e muovono a ricercare quella grazia, quella leggerezza che solo la bellezza può farci ritrovare. A questa più ‘umana’ condizione esistenziale volge la poesia di Traina, intensa e contemplativa. Essa esplora, attraverso il filtro della memoria e del desiderio, il tema della transitorietà, sospesa tra la “voglia di fuggire” e la dolce tentazione di “restare”. Un flusso di coscienza evoca immagini dell’infanzia, sogni come treni in corsa, mattini fruttuosi, “di vendemmie e di ulivi”. Le metafore naturali - fiumi, vento, stelle, alberi - diventano custodi di un senso profondo che sfugge alla comprensione razionale: “Forse i fiumi lo sanno quale senso / non vediamo che c’è per ogni vita”; è questa una riflessione profonda sul mistero della vita, sull’invisibile che guida ogni esistenza (Di passaggio).
Tutto suggerisce un mondo che si muove appena, come in attesa, dove “tutto sembra fermo”, tranne il fluire inesorabile del tempo. Il cuore della poesia di Traina pulsa di nostalgia per la perdita di ciò che è stato, per “quel sentimento che resterà così tra vecchi amori”, Ed è una magra consolazione, che non cela la profonda solitudine, il gesto della “persona sola” - alter ego del poeta – che, “sulla battigia”, tira “un calcio a un sasso”: un gesto che è più di silenziosa ribellione (Contro il giorno). Malinconia, introspezione, ironia e slancio lirico. caratterizzano questa silloge: un universo poetico dove la memoria, la realtà, la finzione e l’amore si intrecciano nell’intimità della parola, in cui vibra una voce autentica, in linea col ritmo delle stagioni interiori ma incapace di rivelare una verità più profonda, di abbracciare il mondo, il (suo) poeta e donargli il dolce ‘peso’ dell’indicibile, la leggerezza del canto ‘appreso’ con ‘divino’ mestiere. C’è malinconia, sì, e c’è tristezza, ma anche voglia di bellezza che riporta alla luce “quella speranza, quella tenerezza e quella gioia viva” del tempo che fu. Così la poesia, la sua parola, rende salvifica la memoria e illumina il cammino diradando il “fumo” della finzione di cui pure il poeta è un ‘maestro’ (Pessoa docet!). “Mente il poeta e finge”; fonde la realtà con i sogni “perché sembri più vero / il viver che dipinge / col bianco sopra il nero”. Tuttavia, non c’è qui illusione; il nostro poeta è consapevole che la finzione e l’ironia sono l’altra ‘maschera’ che si confà al teatro della scrittura, la quale è “uno scrigno” di parole in cui resta segreta, inesprimibile la natura delle cose, che pure destano stupore, grande meraviglia nel poeta, che le interiorizza. E ineffabile resta l’essere, l’identità che è già dietro la ‘persona’: l’individuo e la ‘maschera’ che ne cela la natura autentica. “È il poeta l’immagine/ di tante cose in una: / il libro e le sue pagine, / le facce della luna, / però il più pertinente / è quel detto in usanza / del fumo in abbondanza / senza arrostire niente”. Ma la finzione non è solo “falso pensiero” né una falsificazione della realtà, non è totalmente diversa da essa, ma è un risvolto, una delle forme attraverso cui la realtà si manifesta. Essa è sinonimo di falsità, menzogna, inganno, ma, in quanto si lega alla scrittura, alla poesia, è anche un modo di pensare, immaginare, ideare, inventare. È attraverso la finzione che la poesia “porta alla bocca un attimo / di verità”: quella che non si concede interamente alla parola innamorata del suo poeta, che, a sua volta, l’ama; quella impronunciabile che, in quanto tale, lo sminuisce (“Non sarò mai un poeta”); quella che “nessuna luce” svela, ed è “l’ombra” sul terreno, che ‘manifesta’ la nostra vera natura. Nonostante la grande difficoltà di esprimere l’indicibile, la ricerca di una verità più autentica non viene mai meno: essa è “un’avventura” non solo poetica, ma anche umana, che richiede un nuovo ritmo, nuovi versi, una parola nuova, rivelatrice, che sia “specchio limpido”; che “sappia dirci dove sta l’inghippo”; che rimuova ciò che ostacola la comprensione tra gli esseri umani prima di “cadere giù, a precipizio”.
Traina si pone come esploratore del linguaggio, ma anche come osservatore dell’animo umano. La tensione tra forma e sostanza, tra parola e verità, tra misura e impeto, è “Un’avventura” che non attraversa soltanto il testo omonimo, ma caratterizza e percorre l’intera silloge, la quale sembra, perciò, un manifesto poetico e filosofico. Infatti, c’è in essa una vocazione poetica, una palese dichiarazione d’amore: il poeta è chiamato dalla poesia stessa, ed è “l’ innamorato predestinato”, affascinato, incantato dalla parola, quella capace di creare, sia pure con le difficoltà evidenziate, un ponte tra visione e verità, tra ragione e sentimento, tra caos e destino. Essa è dotata di grande musicalità che accompagna la riflessione; che mitiga, attenua la tensione emotiva prodotta dalla violenza, dalle guerre, dall’impotenza di un “Dio che non si vede (…) che aiuta / ma un altro lo distrae”. È una tensione orientata verso il futuro, accompagnata dalla speranza, dal desiderio di un mondo migliore e alla quale ben si adatta il tono meditativo, intimo e contemplativo, quasi mistico, profetico. Ci sono versi pregni di religiosità e di riflessione filosofica, dove il poeta si interroga sul senso della vita, della morte e della possibilità di un amore eterno, che la morte non può dissolvere, perché essa è vista non come fine, ma come passaggio. Il desiderio che la vita, anche quella oltre la morte, sia canto, cioè espressione di gioia, bellezza, e comunione scaturisce dalla fede, che per Traina diventa ponte tra il dolore e la bellezza, e in virtù della quale egli ‘giustifica’ l’assenza di Dio imputandola all’uomo, che riconosce la mancanza di Dio nei momenti di ignoranza, di smarrimento: “Ci sei mancato tanto / quando non sapevamo!”. Il testo, “Di là”, ci racconta questa fede e questo amore che vincono la morte; che colmano il vuoto spirituale con la speranza, sostenuta dalla fede, di ritrovarsi in quell’oltre, dove “Saremo meraviglia (…) / abbracci che recuperano il tempo” della pienezza, liberati dal timore della condanna, del giudizio finale di Dio. Fede, amore e bellezza, dunque, sono per il nostro poeta necessari alla rinascita. Aggiungiamo, con Erich Fromm, che bisogna «accettare il conflitto e le tensioni, rinascere ogni giorno e sapersi ascoltare». E questa è anche la ‘lezione’ che Tino Traina ci consegna qui. Poetica-mente.