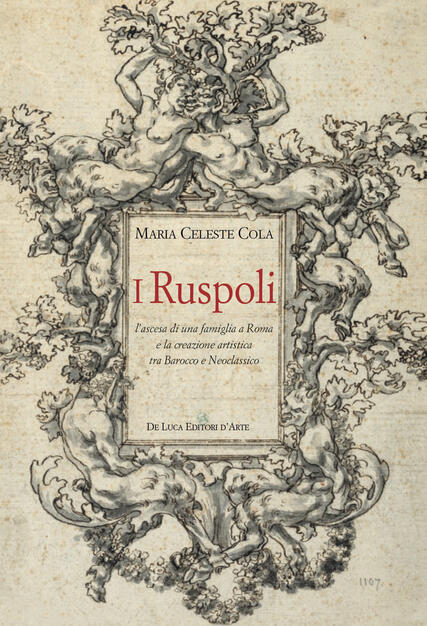Internati militari italiani (IMI) e liberi lavoratori civili in Germania: una precisazione necessaria
- Dettagli
- Category: Polis
- Creato: 08 Marzo 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 6270
di Stefano Fabei
«Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in carica delle forze anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Queste le parole con cui l’8 settembre 1943 il maresciallo Pietro Badoglio annunciava per radio agli italiani la firma dell’armistizio con gli Alleati, apposta segretamente il 3 settembre a Cassibile: parole riproposte ogni anno dai mass media per ricordare quel momento drammatico vissuto dall’Italia e coincidente, secondo alcuni, con «la morte della Patria», secondo altri con l’inizio della Resistenza.
Il 9 settembre, re Vittorio Emanuele III, suo figlio Umberto e Badoglio abbandonavano Roma per rifugiarsi prima a Brindisi e poi a Salerno, lasciando il Paese allo sbando, in balia degli ex alleati tedeschi che occupavano il centro-nord e procedevano al disarmo delle nostre forze armate: una serie di operazioni che, sviluppatesi in pochi giorni in Italia e in Francia ma durate circa tre settimane nei Balcani, riguardarono oltre 1.000.000 di militari italiani. Di questi, 810.000 furono trasferiti in campi di prigionia nel Reich o nei territori polacchi occupati; quasi 200.000, catturati per la maggior parte nell’area intorno alla capitale e nella Pianura padana, dopo il disarmo furono invece rilasciati, sia per accordi specifici tra i comandanti locali, sia per l’impossibilità di garantirne la sorveglianza in molte zone dell’Italia. Soprattutto nei Balcani, i soldati catturati per aver rifiutato la resa e non disposti alla collaborazione furono fucilati dai tedeschi; il loro numero si aggira, tra ufficiali e soldati, intorno a 6.000.
I soldati del Regio esercito catturati dopo l’armistizio, considerati in un primo tempo «prigionieri di guerra» (KG, Kriegsgefangene) e poi «internati militari italiani» (IMI) ebbero destini diversi. La maggior parte, circa 600.000, fu rinchiusa nei lager; circa 20.000 si arruolarono nelle Waffen SS; i restanti, circa 180.000, aderirono a vario titolo alle forze armate della Repubblica sociale italiana o a servizi ausiliari italiani o tedeschi. Una parte (15.000/20.000) fu destinata alle costituende quattro divisioni della RSI da addestrare nel Reich, i cui organici avrebbero dovuto ammontare a circa 60.000/70.000 uomini provenienti per la maggior parte da coscritti e volontari giunti dall’Italia. Occorre a tale riguardo precisare che queste cifre sono da considerarsi approssimative e come le stime continuino a oscillare nella bibliografia specialistica e non specialistica dell’argomento, costretta, man mano che sono acquisite nuove fonti documentarie, a rivederle e correggerle.
Gli ufficiali, compresi medici e cappellani, furono detenuti negli Offizierslager (Offlag), gli altri, soldati e sottufficiali furono destinati ai Mannschafts-Stammlager (Stalag, campi base di prigionia), campi ausiliari e comandi di lavoro (Arbeitskommando). La RSI dovette prendere atto di come l’alleato-protettore germanico tenesse internata questa ingente massa di uomini, non qualificati, né nominalmente né dal punto di vista giuridico, come prigionieri di guerra, ma come Italienische Militärinternierte ospiti di campi dislocati nelle aree controllate dal Terzo Reich, come il Governatorato generale, vale a dire la parte della Polonia non annessa direttamente alla Germania dopo la sua occupazione da parte della Wehrmacht nel settembre del 1939.
Se un certo numero di questi soldati espresse la volontà di rifiutare non già l’ordine del sovrano e l’armistizio di per sé ma le particolari modalità con cui esso era stato firmato, ritenute lesive dell’onore nazionale e militare, e di volere pertanto continuare a battersi al fianco dei tedeschi, dichiarando la propria disponibilità ad aderire alla RSI, la maggior parte, viceversa, affermò di non volere più imbracciare le armi e di non riconoscersi nel governo fascista repubblicano. Di tutti questi uomini − aderenti al nuovo Stato fondato da Mussolini dopo la sua liberazione, non aderenti, ostili o neutrali − il governo della RSI volle ritenersi organo di tutela e di assistenza.
Per quanto riguarda gli oltre 600.000 soldati deportati in Germania, tranne gli aderenti alla RSI, furono utilizzati abusivamente nei lavori più vari – come era, d’altra parte, prassi anche delle altre potenze belligeranti – malgrado la loro qualità di IMI, fino a quando Mussolini il 20 luglio 1944 chiese, e ottenne, da Hitler, sfuggito miracolosamente proprio in quel giorno all’attentato di Rastenburg, un regalo durante i colloqui. Il «dono» fu ufficializzato con i «Protocolli di Guben», così chiamati dalla località della Prussia orientale dove ebbero la loro attuazione, del 30 luglio 1944. A ognuno degli oltre 600.000 IMI fu concessa la possibilità di scegliere una fra le seguenti soluzioni: incorporazione nelle forze armate combattenti germaniche o in quelle della Repubblica sociale; assolvimento del servizio ausiliario presso le une o le altre; avere lo status di liberi lavoratori civili; mantenere quello d’internato qualora le precedenti opzioni non fossero state accettate.
La stragrande maggioranza, circa 500.000, comprese i vantaggi (passaggio dalla competenza del Servizio assistenza internati (SAI) alla giurisdizione dei consoli, libertà di movimento, trattamento alimentare ed economico equiparato a quello dei lavoratori italiani che già si trovavano in Germania, assistenza sindacale, impiego in attività corrispondenti alla propria professionalità, utilizzo prevalente nelle campagne dove la vita era meno rischiosa che nelle città sottoposte ai bombardamenti) offerti dalla terza soluzione e optò in massa per il passaggio al libero lavoro civile. Tra i 50.000 e i 70.000 – le cifre sono controverse – rifiutarono l’offerta e scelsero di rimanere dietro i reticolati. I restanti, alcune decine di migliaia, aderirono alle Forze armate o ai servizi ausiliari del Reich o di Salò. L’accordo fu di grande importanza per la RSI in quanto costituì una definitiva soluzione al problema degli internati, motivo di angoscia per i loro familiari, calcolati tra i 6 e i 10 milioni.
Presso l’archivio del ministero degli Esteri nei fondi della RSI è presente un documento, il «Verbale della riunione dei Consoli italiani in Germania tenutasi presso l’ambasciata italiana in Berlino il 12 e 13 gennaio 1945»[1], riguardante l’incontro cui presenziarono tutti i funzionari e addetti all’ambasciata e i titolari degli uffici consolari di Monaco, Vienna, Berlino, Innsbruck, Amburgo, Colonia, Dresda, Breslavia, Stoccarda, Graz, Klagenfurt, assenti i titolari degli uffici consolari di Danzica, Saarbrücken e Karlsruhe, il cui redattore, l’avvocato Giangaleazzo Bettoni, malgrado lamentasse il fatto di non aver «mai potuto ottenere una statistica precisa» dai tedeschi, ripetutamente parlava di 500.000-550.000 ex Imi diventati liberi lavoratori civili, cifra con la quale il numero complessivo dei lavoratori italiani in Germania saliva a più di 700.000, su un totale di oltre 1.000.000 di connazionali residenti allora nel Reich. Tale cifra concorda con la testimonianza di Renzo Morera, figlio del generale Umberto Morera capo della Missione militare italiana[2], e allora in servizio presso questa in qualità di caporale[3], il quale parla di circa 500.000 ex IMI e di 70.000 renitenti, soprattutto ufficiali, al lavoro e all’arruolamento, che decisero di rimanere internati. Secondo Morera, per le altre categorie di scelta previste dai Protocolli di Guben, solo poche migliaia passarono alla Wehrmacht o aderirono alle forze armate di Salò; del totale di oltre 624.000 internati ne morirono tra i 35.000 e i 45.000. Stando, invece, ai dati forniti dall’Istituto Centrale di Statistica in Morti e dispersi militari per grado e località di morte e dispersione, gli internati che persero la vita nei lager, soprattutto nel Reich e nell’area balcanica, furono tra i 20.000 e i 25.000. Anche in questo caso cifre e percentuali sarebbero da rivedere, al ribasso, alla luce della documentazione archivistica di volta in volta emergente.
Premesso quanto sopra, consideriamo opportuno, sia da parte degli storici sia di quanti veicolano le informazioni, rivedere la vulgata per decenni dominante.
La storiografia, anche quella più recente, tende, forse suo malgrado, a essere imprecisa attribuendo a tutti gli oltre 600.000 internati un ruolo e una forma di Resistenza che non fu così «efficace» come alcune fonti giudicano. Riteniamo occorra in merito procedere a una più approfondita analisi dei tipi di Resistenza. I 500.000/550.000 Imi che accettarono di passare alla condizione di «liberi lavoratori civili» compirono una scelta di tipo collaborativo, in modo diretto o indiretto, se non proprio collaborazionistico: non vollero più combattere, ma accettarono comunque di lavorare per la causa nazifascista. I 60.000/70.000 che non cedettero agli inviti e alle lusinghe dei tedeschi e dei loro alleati di Salò, continuando a rimanere nei lager, con il loro «no», motivato da varie ragioni, fra le quali l’attendismo, misero certo in atto una Resistenza attiva, ma meno efficace di quella compiuta da quanti scelsero – in un secondo momento, dopo aver aderito alle forze armate della Rsi ed essere rientrati in Italia – di combattere tedeschi e fascisti. Distinguere le due forme di Resistenza – quella «attiva e combattente» da quella «attiva», ma in minor misura, quando non «passiva» e/o «attendista», degli Imi rimasti all’interno dei reticolati – ci sembra doveroso nei riguardi di chi, ripetiamo, con una scelta più coraggiosa e difficile se non altro per l’impossibilità di prevedere gli esiti della stessa, imbracciò un’arma e lottò per una causa, pagando spesso con la propria vita. Ciò dovrebbero comprendere anche e soprattutto i giornalisti come Bruno Vespa e Paolo Mieli, tanto per citare i più noti protagonisti della ribalta televisiva, i quali, in trasmissioni di ampia divulgazione e anche in libri, tendono a far passare il messaggio che tutti gli internati fecero la Resistenza; è come dire che tutti gli italiani furono fascisti prima, o antifascisti poi, non distinguendo i diversi tipi e livelli di responsabilità e coinvolgimento nei fatti, e facendo perdere valore a chi ebbe il coraggio di compiere una scelta ben precisa.
[1]ASMAE, AG, Rsi, b. 32, Germania, 4/1.
[2] Vedi a proposito Fabei S., La missione militare italiana in Germania, in «I sentieri della ricerca», n. 23, giugno-dicembre 2016, pp. 153-166.
[3] Renzo Morera, allora diciassettenne, prestò servizio come portaordini presso la Missione militare italiana a Berlino comandata dal padre, Umberto, da cui raccolse e sistematizzò tutte le informazioni possibili, corredate da ampia documentazione. Ha pubblicato in proprio Dentro la missione militare in Germania della Rsi, Roma 2010.