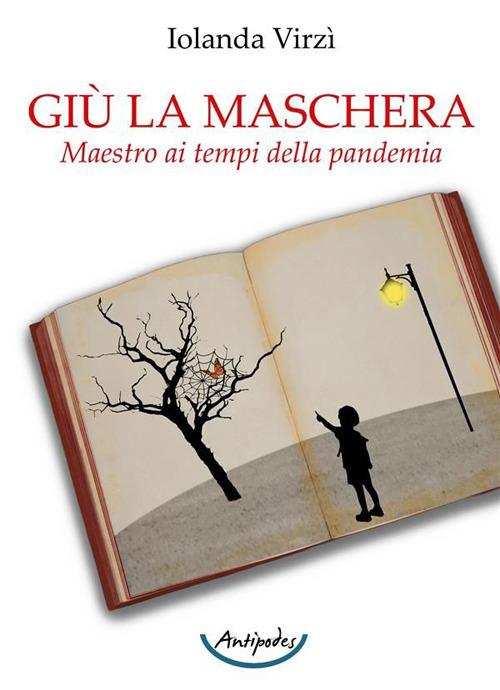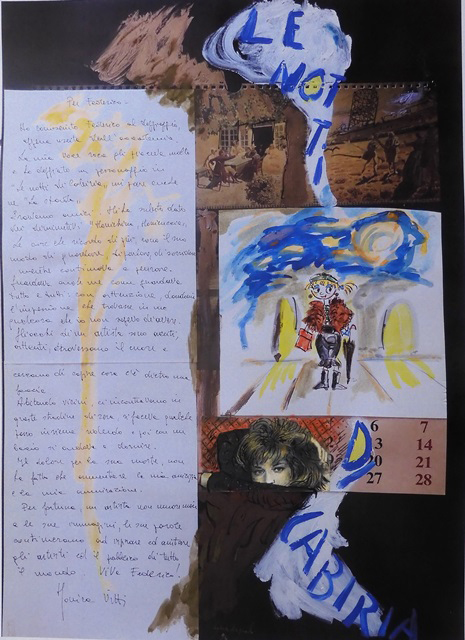“Il Christus patiens della tradizione popolare siciliana” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Polis
- Creato: 06 Aprile 2022
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1659
Chiudendo nel 1881 la sua rassegna delle Sacre Rappresentazioni in Sicilia, notevolmente ridottesi dopo l’Unità, l’etnologo palermitano Giuseppe Pitrè (1841-1916) osservava che i tempi nuovi sono indocili delle cose passate nelle quali è tanta inchinevolezza alle sacre rappresentanze quanta è nelle presenti malevoglienza, o dispetto, o noncuranza. Notazione che oggi, tra secolarizzazione diffusa e anglicismi rampanti nella lingua, suona ancora più attuale, nonostante le molte religiose processioni, più turisticamente affollate talora che profondamente partecipate, della Settimana Santa, e taluni revival di recite sulla Passione, assai numerosi in vero sia gli uni che le altre prima della recente e disorientante pandemia del biennio 2020-2022.
Dell’immaginario sacro pasquale siciliano in forma drammatica si vogliono qui ricordare col Pitrè le “processioni figurate”, dette casazze e i Mortori. Le prime, pompose, costose e assai antiche, con centinaia, o anche più di un migliaio, di figuranti divisi per gruppi, fino al 1870 circa rappresentavano, per le vie delle città e anche di piccoli paesi, scene dell’Antico e del Nuovo Testamento legate alla Passione, facendo ricorso a pantomime mischiate talvolta a parti recitate, con ampio corredo di allegorie, angeli, diavoli, martiri, dottori della Chiesa. I Mortori invece erano drammi sacri, di fattura letteraria o non, dal seicentesco Cristo morto del gesuita poeta Ortensio Scammacca ai settecenteschi Cristo condannato, Cristo al calvario del padre cappuccino Benedetto di Militello, all’ottocentesco Mortorio nella parlata gallo-italica dell’ex chierico Antonino Agalbato, oltre a testi più dozzinali o anonimi, tutto materiale documentato fin dal ‘400/‘500. Innumerevoli dunque i Mortori, fra i quali si affermò, surclassandoli tutti per più duratura fortuna fino a lasciare propaggini in assai noti romanzi di Sciascia e Andrea Camilleri (A ciascuno il suo, La scomparsa di Patò), il settecentesco Riscatto di Adamo nella morte di Gesù Cristo del cav. Filippo Orioles, buon poeta e improvvisatore di versi latini, morto a 106 anni, come scriveva nel suo Diario palermitano, nel ‘700, il marchese di Villabianca. Riprodotto in una infinità di copie manoscritte e ristampato ancora nel 1854, il Riscatto fu ridotto, ampliato, alterato a piacimento (dalla Passione di Salamoni Castelli membro dell’Accademia del Buon Gusto al Mortorio di Cristo di Acireale…), servì da fonte a varie Cene parlanti o Deposizioni dalla Croce, quali in dialetto Li parti di lu Calvariu, e fu adattato pure per i teatrini dei Pupi dove il pubblico, dalla scena iniziale dell’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme alla Cena, alla cattura, alla Crocifissione, alla Resurrezione, udiva e vedeva con una religiosità che mai la maggiore -annotava Pitrè-, arrivando perfino a scoprirsi il capo, e odiando di cuore Giuda come il Gano di Magonza della Storia dei paladini. Ma anche fuori dallo “spettacolo sacro”, e sempre sul filo conduttore dei segni dell’infanzia premonitrice di Gesù e delle pie sequenze della Via Crucis, la devozione popolare registra un ricchissimo repertorio di canti e di preghiere dialettali, di cui sono state approntate, pazientemente e amorevolmente, delle raccolte pure nell’ultimo ventennio del ‘900, scegliendo gli autori come informatori anziani tra i 60 e gli 80 anni. Canti e preghiere in cui la fede comune “riposa” su umili collettive certezze, quali la salvezza del peccatore che sinceramente si accusa e si pente (iu vi desi l’acitu mirratu…iu fu’ lu ciecu chi la lancia tirai), e il perdono ottenuto grazie ai dolori di Cristo e della Vergine.
Spigolando dai testi si incontrano sì versi poveri e meccanici di routine, e formule obbligate direttamente connesse ai riti liturgici in chiesa, ma qua e là spiccano anche parole e immagini di accattivante intensità, o di più scavata psicologia, specie nelle Coroncine per le cinque piaghe di Cristo o per i sette dolori di Maria, o in certi “canti dialogati” che focalizzano la santa Matri (dd’afflitticedda, dda sbinturata) in cerca di lu caru figghiu, terrorizzata dai chiodi che sta approntando lu mastru firraru (altrove lu mastru di li chiova), o invano implorante dietro la porta di Pilato, perché sintìa li scurriati (le frustate), quel Pilato presso il quale Cristo è stato trascinato scausu e nuru e scapiddatu (sic!), e tutta la notte è stato battuto cu na virrica di ranatu. O ancora, le sequenze dove calano sul mondo le “tenebre” alla morte di Cristo (Trema la terra, scumparìu lu suli,/ scurò lu cielu, li stiddi spuntaru,/ vinni lu vientu comu n’uruganu…), o dove è di scena la creatura umana sbandata, a cui lu cori sfila (si consuma) pp’un pocu d’acqua della fonte divina: avi tant’anni chi nni sugnu priva,/ avi tant’anni chi nni su’ luntana! Per lunga consuetudine il giovedì santo davanti ai sapurcri (altari detti “sepolcri”) si recitava: ddocu c’è ma figghiu nchiusu/ mi l’aviti a scatinari (liberare)/ la nuttata di stanotti/ figghiu miu unn’atu statu (dove sei stato), e all’Ufficio delle tenebre, nello spegnere le candele: a la notti di li trépini (tenebre)/ ranni (grande) scuru (buio) ca faciva. Il venerdì santo si intonava sotto il Crocifisso lo specifico rrusariu dô Crucifissu (E lu sannu di Ggesù/ dolci amuri e-ccarità./ Ppi lu vuostru ranni affettu/ spargiti razzia e-ccarità/ Sù li chiai di Cristu amurusu,/ sù li funtani di lu Padarisu…) e per la deposizione dalla Croce l’atto di dolore (V’aju offisu, sommu bbeni,/ mia morti, cruci e-ppeni… Mai, mai piccari cchiù… Primu, Ddì, vogghiu muriri,/ no-tturnàrivi a-ttradìri). E il fervore intimo aveva agio di riflettere nella coroncina per le piaghe del Crocifisso che lu pedi mancu (sinistro) trafitto di Gesù scinnìu nterra e fu lassu e stancu per cercare l’uomo, e che pure quello destro currìu ppi l’uomu duru e circau l’uomu ostinatu, e che il suo cuore apertu (spaccato dalla lancia) sempri amanti è portu (un porto) a tutti nui, e che, caduto più volte sotto la croce, Gesù s’alzava, guardannu circava/ l’alma ingrata dicennu: idda unn’è? Musicalmente e affettivamente efficaci pure certi ritornelli/giaculatorie quali: Vi considiru, Signura, nna ddu spasimu d’allura nella coroncina per i dolori di Maria; o …e vui Matri di duluri, va stutaci dd’arsuri (spegnetegli quell’arsura) nella coroncina per le anime del Purgatorio dove, di strofe in strofe, il ricordo/evocazione di Gesù agonizzante nell’orto, barbaramente condannato, flagellato, spogliato, deriso, schiaffeggiato, cu tri chiova (chiodi) infine in lignu appisu sì che lu sangu era a lavini (straripava), serviva a impetrare ciclicamente la liberazione dai tormenti di quelle afflitti animi pinanti. Di aura tutta rustico-paesana invece risultano, perché proiettano nei versi scene di usuale, quotidiana, disperazione nei ceti sociali più bassi (madri svergognate dai figli arrestati o rimaste sole e senza sostegno per i figli uccisi, e perciò trapanati, cioè “trapassate” dal dolore) i brani in cui a Maria, che incontra Cristo trascinato via, è proibito di dari aiutu al figlio, o quando prova strazio a vederlo laciratu, comu latru (sic!) tra dui latri, e quando, morto Gesù svinatu (svenato), resta ‘mpiagata (coperta di piaghe), senza figghiu a la stranìa (sulla via)/ viduva tra nimici e senza cura (senza soccorso); oppure ancora, quando Cristo stesso chiede a lei impotente che i mastri di li chiova (i fabbri) non li facciano tantu longhi e tantu mastini (grossi)/ pi trapanari sti carnuzzi fini (in una variante: non tantu rossi, non tantu spuntati/ ca ci àna a passari sti carnuzzi flagellati). Di vessazioni abituali e secolari per la gentuccia parlano pure l’immagine del Cristo portato marini marini con addosso una catina così rossa (grossa) che di quantu è rossa tuttu si dilassa/ e ne’ spadduzzi soi porta na fossa, e la stessa Veronica vicchiaredda (sic!) nel cui ‘mmuccaturi (fazzoletto) resta stampatu lu visu tuttu nchiaiatu, anche se divino, del condannato: Quant’era sfatta dda carni riali… (quanto era disfatta quella carne regale…). E “corale” e solidale è il dolore delle “madri” (quale appunto nelle lamentazioni funebri delle popolane) in un canto che ancora si eseguiva prima della pandemia nel borgo rurale di Sant’Anna, frazione di Caltabellotta, dal quale emerge un suggestivo contrappunto fra le donne che vanno a visitare il Calvario (O santa cruci vi vegnu a vidiri/ tutta di sangu vi trov’allagata…) e le parole di Maria: <<Piglia sta scala ed a mme figliu scinni/ quantu ci passu (accarezzo) sti so santi carni>>. Un dolore che la sera del giovedì santo era anche sottolineato per le strade dei paesi dal suono ammonitore del tamburo, come tramanda il sonetto Li sepulcri di Alessio Di Giovanni, tamburo che rimbombava fra il muoversi della folla dei devoti comu ‘mmenzu la negghia spiriti inquietanti: Lu tammuru/ sona ‘n funnu a la strata, ed a li voti/ spinci la vuci ca pari un scunciuru/ ca veni di l’abissu, e ca ti scoti; oppure da quello della troccula, la caratteristica “campana di legno”:<<Sona la troccula -cantavano e forse ancora cantano a Misilmeri vicino Palermo- affacciativi tutti,/ ca sta passannu lu me santu Figghiu>>.
Riguardo alle formule dei misteri dolorosi, esse erano sostanzialmente identiche in tutta l’isola (ad esempio le seimila vastunati della flagellazione o li spini della corona comu chiova/ciova), ma ripetute nelle diverse aree territoriali (iblea, ionica, etnea…) -come evidenziano i vari testi qui riportati- con le varianti fonetiche locali e inevitabili “scambi” lessicali, che creano e mediano all’ascolto, per il mutare timbrico ora più cupo ora dall’alone più remoto, maggiori o minori suggestioni emotive. Ad esempio: re di burla fu ‘ncrunatu/ ccu na canna sbriugnatu/svirgugnatu (svergognato) può risultare all’orecchio/cuore di alcuni formula più pregnante ed espressiva rispetto a: re di jocu fu’ ncurunatu… ccu na canna è maltrattatu; oppure nuddu c’è ca lu cunorta rispetto a nuddu c’è ca lu cunforta. Minime variazioni comunque di una stessa, viscerale, memoria storica, che non toccano l’uniformità e pia condivisione in tutta la Sicilia degli stessi simboli, immagini/mito e sostrato precettistico/dottrinale, frutto di un plurisecolare indottrinamento pedagogico dei diversi ceti sociali, filtrato dalla parola scritta e orale, dalla forza strutturante dell’iconografia, dalla stessa magnificenza ritualistico-spettacolare introdotta dalla Controriforma, e dalla ininterrotta attività fin dal XIII/XIV sec. delle numerose Confraternite, a partire da quelle dei Disciplinati, ai quali sembra (secondo Pitrè) debba farsi risalire la consuetudine, poi generalizzatasi pure in Sicilia, delle processioni/casazze sopracitate, così dette forse dai luoghi/Oratori (“casacce”, cioè grandi case) dove originariamente i confrati si riunivano per le loro pratiche di pietà. Quanto ai “canti dialogati” sopra accennati con tema l’inchiesta della Matri santa (Vaju circannu allu mo caru figghiu), molti di essi sembrano avere in comune, quale fonte unica e fondante, brani de La Passioni di Gesù Cristu di Deca Niculaci, sconosciuto poeta popolare, che per l’abbondanza delle varianti tramandate e il raggio di diffusione e riproduzione del suo testo pare avere avuto fortuna simile al notissimo Viaggiu di Binidittu Annuleru quanto agli episodi della Natività. A sviluppo più accentuatamente narrativo si presentano due canti etnei sul giovedì santo (Lu giovi santu, lu giovi a matinu, la matri santa si misi ‘n caminu); atteggiato invece a “lamentazione“ salmodiante, per le iterazioni e il ritornello intercalato al racconto, un altro sul venerdì santo (Lu venniressantu a lu matinu/ la matri santa si misi n caminu) raccolto a Palazzolo Acreide da Antonino Uccello negli anni ‘50. Le varianti contenutistiche e lessicali fra i primi due canti rendono più drammatico il testo recitato dalla contadina di 76 anni originaria di Piedimonte Etneo nel quale la Vergine Maria, al rifiuto crudele dei fabbri malfatturi (nella tradizione orale siracusana talora interviene a rafforzare il rifiuto lu riavulu infirnali che ordina ai mastri, con ira e tono vendicativo, di fare invece i chiodi proprio longhi e pizzuti, perché anu a trapanari ddi carnazzi [sic!] amari), si allontana desolata come una popolana, cu li capiddi lassati iri (con i capelli sciolti), mentre la gente attorno le va chiedendo, e si va chiedendo, se la matri santa ha ghiutu a ‘mpazziri (è impazzita). Nel canto del venerdì santo di Palazzolo, al posto dell’abituale San Giovanni che, incontrata Maria per la strada, la manda a cercare il figlio nta li casi (o corti) di Pilatu, è il fabbro, già al lavoro di buon mattino, che la indirizza là dove Gesù catturato è stato legato alla colonna fra quattro flagellatori. Il brano segue uno schema più iacoponico, perché all’invocazione ripetuta della madre: O figghiu ri ssa cruci scinni scinni (scendi scendi)/ ca nterra la to mamma t’addifenni (la tua mamma ti difende), il figlio, anche se con tenerezza, continua a ribattere anteponendo sempre la sua missione: o mamma bbriniricitimi e-gghitivinni (beneditemi e andate via),/ ca lu me cuorpu la cruci puterni (perché il mio corpo la croce pretende)! Il canto si chiude con l’urlo di Maria supra n scuogghiu (su uno scoglio) e con la trasformazione dell’acqua del mare unni patiu lu so santu Figghiu in uògghiu (olio), olio di purificazione/redenzione, e crisma di grazia, oltre che alimento pregiato per i più poveri (vedi le fave mangiate da loro più spesso senza olio). Una preghiera di Augusta del periodo della quaresima, nella dolorosa contemplazione del corpo martoriato dell’Ecce Homo, attingendo ancora una volta all’esperienza popolare, quotidiana e domestica, non trascura di annotare pietosamente un singolare dettaglio che pare evocare un usuale incidente dei lavori campestri: Cristu<< Ecci Homu>> ca’ ognunu lu sputa/ ‘nta l’ucchiuzzu ci va’ na spina minuta (sic!),/ tutta la so pirsuna è trasfurmata.
Dialogato è anche il racconto, assai diffuso nell’isola, del “sogno” edificante del peccatore tipico. Cu v’à ‘nchiuvatu sti piduzzi [miseri piedi] a vui? -chiede intenerito il peccatore alla vista in sogno del Crocifisso, visione che in una versione del territorio catanese si chiude solo con le parole/rimprovero accorate del Cristo: Tu, piccaturi, chi gloria nnai, / prima m’affenni e mi spii di chiui (prima mi offendi e per di più vieni a chiedermelo); in un’altra, del territorio ragusano, alla domanda: Signuri, cu’ vi detti morti a vui? segue l’analogo rimprovero divino: o cori scilliratu, e nun lu sai! / Mi duni morti e po’ spij cu’ fui? (mi dai morte e poi vieni a chiedere chi fu?) ma con aggiuntiva la confessione/contrizione del reo: piccai, me Diu, ora nun peccu cchiui. Corde simili, come si vede, eco l’una dell’altra quali cerchi concentrici in uno specchio d’acqua, e soprattutto antiche, ataviche… ma dai suoni e “valore” intrinseco ormai poco familiari alle nuove generazioni, come il gesto da tempo scomparso, e una volta gioiosamente augurale, che ciascuno faceva, entrando in chiesa il sabato santo (Jù trasu ‘nta sta chiesa triunfanti), di segnarsi con l’acqua benedetta, recitando: Stennu la manu ritta,/ pigghiu l’acqua biniritta,/ m’a la mettu nta lu visu,/ chista è (o piuttosto, era?) acqua do’ Paradisu.