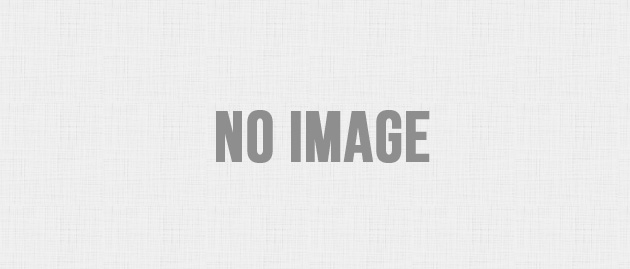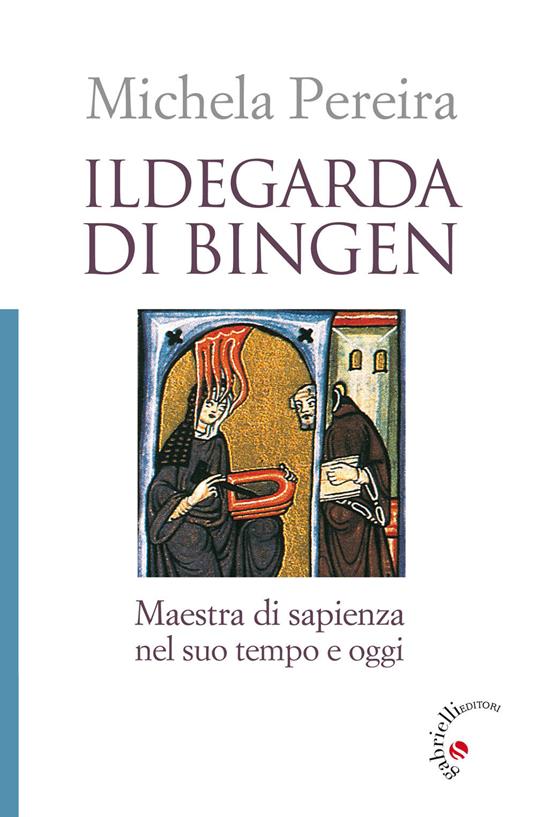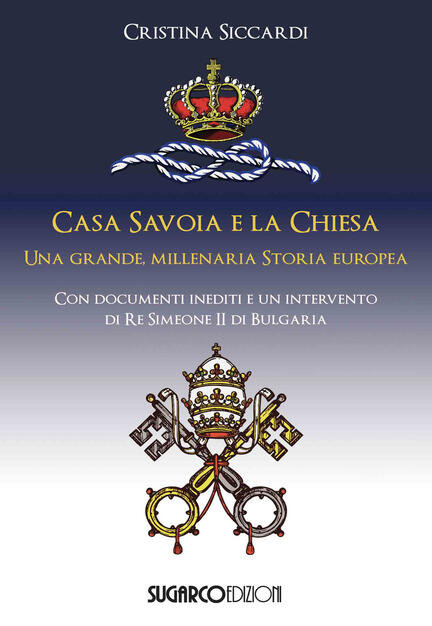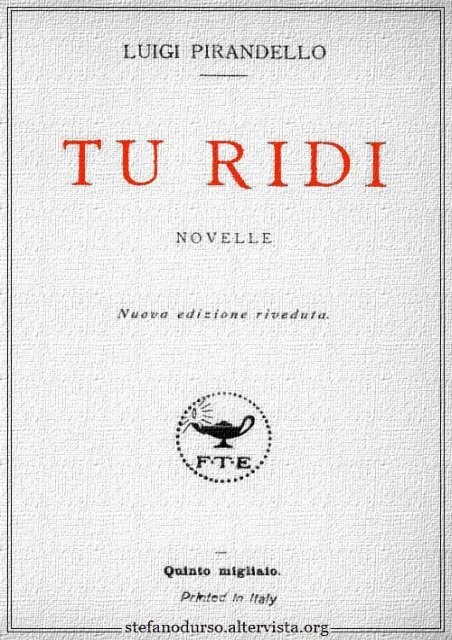Il Drago e la Fenice – di Giovanna Cavarretta
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 02 Ottobre 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 622
Raffinatezza ed esecuzione magistrale costituiscono le caratteristiche fondanti delle sculture in avorio presenti a Casa museo Thule. Realizzate nel XIX secolo, in seno alla dinastia Qing, raffigurano il sovrano e la sovrana. Un Impero che copre un arco temporale che si estende dal 1644 al 1912, anno in cui l’abdicazione dell’ultimo imperatore Pu Yi, spalancò le porte alla Repubblica Cinese. Questo accenno storico è importante per comprendere come l’arte cinese affondi le proprie radici nella sua storia millenaria, ove la dimensione filosofica, spirituale e religiosa è strettamente legata a quella sociale e politica. Sotto la dinastia Qing l’arte e la cultura subirono un brusco arresto, dovuto al ritorno di un “feudalesimo” che la precedente dinastia Ming aveva in gran parte superato. Fondamentale per avere un quadro chiaro ed una corretta comprensione del movimento dell’arte nel periodo Qing è necessario fare un passo indietro. Sebbene l’arte e la cultura durante l’impero dei Ming e dei Qing sia volta “verso aspetti più comuni”, la differenza sostanziale la si coglie nella postura, ossia nell’atteggiamento interiore che l’artista assume e con il quale si approccia all’espressione artistica. Le condizioni sociali, politiche e commerciali videro un notevole risveglio nell’era dei Ming. Tale rinnovamento influenzò enormemente la sfera filosofica, artistica e letteraria nonché il pensiero sociale e politico. Infatti, dal XVI° alla metà del XVIII secolo vennero alla luce una serie di scuole e sette che apportarono al tessuto sociale e all’ambiente culturale sviluppi significativi. La filosofia è l’essenza di questo momento storico. I punti salienti erano rappresentati da coloro che propugnavano il rifiuto e addirittura la distruzione del “tradizionale sistema feudale” e altri, invece, che pur definendosi confuciani rientravano nella “scuola filosofica di natura più speculativa”. Il tumulto dei cambiamenti sociali in epoca Ming, come la comparsa di una classe mercantile in via di sviluppo, formata in prevalenza “di proprietari terrieri e di ceti urbani”, getta le basi dei primi elementi del Capitalismo Cinese. Già divulgati da una cerchia ideologica. Questi elementi si riflettono nell’arte come “tendenze spirituali”. Le forme di espressione artistica, dalla xilografia alla narrativa, dalla letteratura vernacolare alla pittura si caratterizzano per la presenza di “un laico e profano realismo”, mentre l’arte e la letteratura di stampo tradizionale, si orientano verso il romanticismo, in ferma opposizione ad un “un classicismo artefatto”. Questi due filoni ossia, quello del realismo degli strati inferiori e quello romantico degli strati superiori descrivono i due lati della medesima medaglia: essi fondendosi, si completano, dando vita ad un’importate fioritura culturale. Con l’avvento della dinastia Qing nel 1644 si assiste ad un netto rovesciamento: tematiche, stili e contenuti si vestono di un greve oscurantismo. Lo spirito di emancipazione unito alla volontà di rottura con le tradizioni consolidate nell’era Ming subisce una battuta di arresto. Cosicché il romanticismo si trasforma in cupo sentimentalismo, il ritorno ai classici si adombra di un tetro “classicismo artefatto”. Il dolore e l’indignazione traspariva dalle opere pittoriche, mentre le sculture incarnavano un “tedium vitae”, avendo perso il vigore, la potenza espressiva e la cura dei dettagli, che in passato ne avevano fatto la grandezza. Solamente l’artigianato e le Arti minori, grazie all’evoluzione delle tecniche e ad una maggiore attenzione alla crescita delle abilità, conobbero una maggiore diffusione, anche in Occidente. L’eleganza e la ricercatezza di un artigianato sfarzoso e denso di finezza lo si può paragonare al rococò europeo. In tale contesto storico-artistico si inseriscono le preziose sculture di Casa museo Thule: il Drago, il sovrano, e la Fenice, la sovrana. In Cina tale rappresentazione veniva utilizzata come decorazione, ad esempio per rendere più bella la casa o come statue da collezione. Esse, perlopiù, erano realizzate in ceramica, porcellana ed avorio. La lavorazione di quest’ultimo ha una lunga tradizione ed è inclusa nel novero delle arti imperiali. Una delle tecniche padroneggiate dall’artista-artigiano per intagliare l’avorio era la “bachiru”. E’ proprio nel corso della dinastia Qing che la scultura in avorio raggiunge il suo apice. Figure religiose, come Budda o Guanyin, la dea della compassione ed altri bodhisattiva sono alcuni dei soggetti scolpiti. Un altro elemento da tenere in considerazione è il forte legame dell’arte cinese con la filosofia e la spiritualità. Confucianesimo, Taoismo e Buddismo erano i pilastri sui quali si regge l’espressione artistica nel suo complesso, generando in tal modo un repertorio simbolico di notevole interesse. L’intensa relazione tra l’aspetto filosofico, spirituale ed altresì esoterico strettamente collegato al richiamo mitologico, creano una sorta di linguaggio analogico; letto in maniera chiara ed esplicita da coloro i quali avevano intrapreso la Via, catalizzatore, invece di messaggi accolti inconsciamente dalla massa. Le sculture di Casa Thule ne sono una testimonianza. La solennità delle posture, la maestria tecnica e la delicatezza dell’intarsio, rendono più manifesto la ricchezza simbolica che adorna le figure. La tradizione cinese narra che Feng e Haun erano due fenici separate, un maschio e una femmina. Esse rappresentavano Yin e Yang, i principi che governano l’universo. Nello scorrere del tempo si inizia a rappresentare una sola fenice, che prese il nome di Fenghuang, divenendo simbolo di armonia assoluta. Secondo il mito, la Fenice è uno dei Quattro Spiriti, che insieme al Drago, alla Tartaruga e a Qiliu, ebbero un ruolo fondamentale nella creazione del mondo e dei cinque elementi. Infatti, essa simboleggia l’elemento fuoco ed è associata all’estate. Si racconta che il suo soave canto fosse in grado di incantare e di concedere benedizioni a chi l’ascoltava. Un altro simbolo che ritroviamo nelle sculture è la raffigurazione del Drago. In Cina, il Drago e la Fenice incarnano il potere imperiale. Il primo è emblema di fortuna, mentre la seconda sta ad indicare la bellezza, il rinnovamento e la longevità. Raffigurati insieme, il Drago e la Fenice, suggeriscono l’unione perfetta: “lo splendore del drago e la bellezza della fenice”. Dal punto di vista esoterico, nelle tradizioni orientali, il Drago denota l’energia della Kundalini, un’energia che sta alla base della colonna vertebrale e che può essere risvegliata attraverso specifiche pratiche spirituali, allo scopo di raggiungere l’illuminazione. Ancora un altro dato è da prendere in esame: il Fiore di Loto, tenuto dalla Sovrana nella mano sinistra. Questo particolare ci riporta alla matrice spirituale buddista. Il suo fiorire alle prime luci dell’alba, lo rende simbolo dell’Illuminazione dello Spirito, simbolo del Risveglio. Inoltre, il Fiore di Loto viene connesso alla purezza perché nasce puro da acque fangose, paludose. Questo ventaglio simbolico scolpito sul “Drago e la Fenice” è ulteriormente impreziosito dall’intaglio di elementi naturalistici che rendono la superfice densa di contenuti e ricca nella decorazione. Quanto finora esposto ci mostra quanto la filosofia e le correnti religiose allora presenti, Buddismo, Confucianesimo e Taoismo, abbiano inciso sullo sviluppo dell’Arte. Il Confucianesimo era la dottrina maggiormente diffusa, atta a fornire regole morali sia in ambito sociale che politico. La sua influenza si estese anche nelle Arti, sollevando un forte senso di emancipazione da norme ritenute rigide. Da qui la comparsa in epoca Ming del “confucianesimo eterodosso”. Nonostante, anche il Taoismo sostenesse la difesa dei valori tradizionali, ciò che prevalse fu “La Via del Dao o Tao”, cioè l’aspetto spirituale, volto a focalizzare l’attenzione alla natura, alla vita e all’armonia sia interiore, sia esteriore dell’uomo. Ad arricchire tale panorama filosofico, un grande contributo è dato dal Buddismo, i cui principi come Le Quattro Nobili Verità, il Nobile Ottuplice Sentiero, la Compassione e la Consapevolezza per citarne alcuni, sono stati resi visibili nell’Arte e nelle Arti, grazie ad una folta simbologia. In conclusione, l’arte cinese è un mondo a sé, essa è detentrice di saperi, che per quanto oggi ci siano accessibili, risulta difficile una profonda comprensione se non si riesce per un attimo ad entrare in punta di piedi in una cultura molto differente da quella occidentale. E’ necessario avere un attimo di totale amnesia riguardo tutto ciò che abbiamo studiato, imparato, soprattutto per quanto concerne la lettura critica di un’opera. E non è, né facile né semplice, imbevuti e condizionati dal sistema culturale di cui facciamo parte. Ma qui entreremmo nel campo dell’estetica interculturale. Ma una cosa è certa: osservare le meravigliose sculture di Casa museo Thule, sentire il profumo emanato dall’avorio e perdersi nell’universo simbolico ivi rappresentato, non può che suscitare un’intensa esperienza estetica.