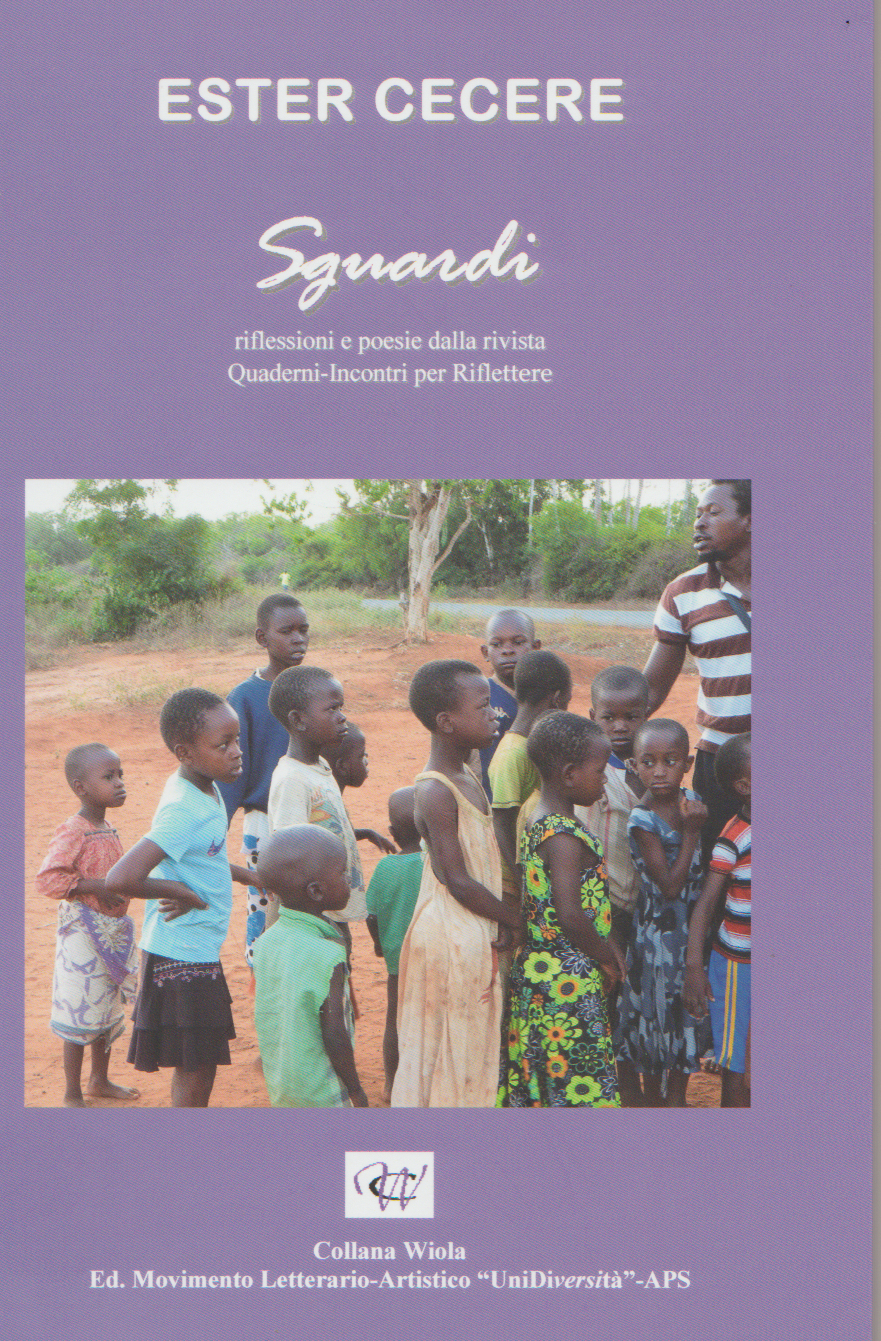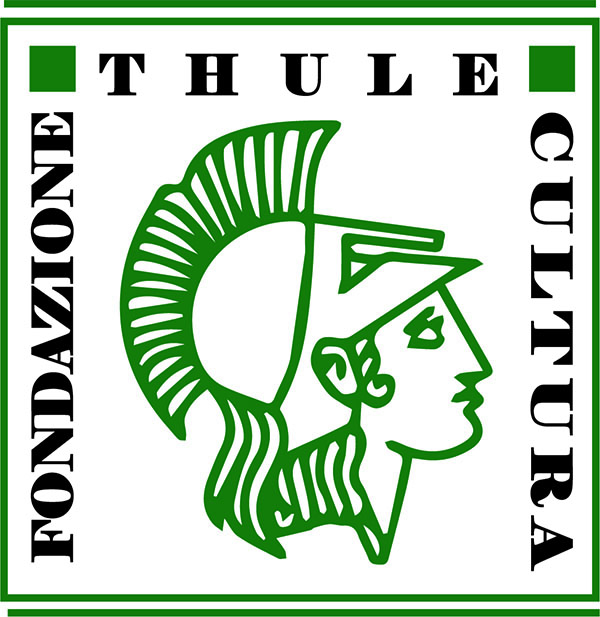"Il devastante nichilismo nemico dell'Arte" di Tommaso Romano
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 14 Aprile 2018
- Scritto da Tommaso Romano
- Hits: 3833

Il devastante nichilismo è il nemico dell’uomo e quindi dell’arte che l’uomo dovrebbe pensare e realizzare come straordinarietà creativa o ri-creativa. Cadute le certezze, brancolando nel buio della modernità, schiavizzati dalla tecnolatria, incapaci di formulare visioni di universalità, occorre ritornare, intanto individualmente, ai fondamenti dell’essere, del contemplare e del fare.
Non è ora in gioco l’attesa di un demiurgo in grado di spazzare con radicalità le nocività morali e materiali del tempo presente. Solo per chi crede, ciò sarà una chiave risolutiva nell’orizzonte apocalittico, anche di senso, tema e simbolizzazione di nuovi cieli e nuove terre, trascendente ma agente nel tempo della storia.
Aveva ragione, allora, Gottfried Benn quando diceva che era necessaria una nuova trascendenza rispetto al nichilismo, quella dell’espressione? Oggi l’espressione si è ridotta a spesso insensate sillabe che si rincorrono sui social, con accentuazione di esasperato narcisismo con Istagram, con conseguente mortificazione di ogni idea e progetto di grandezza, creatività, senso del dovere.
Diceva Nietzsche, “È una prerogativa della grandezza ricercar felicità con piccoli doni”, e non attraverso il puro possesso, l’avere, fonte di un presunto godimento da desiderio, di un momento in realtà solo transitorio, in definitiva non appagante se non che per alcuni momenti. La comunicazione è parcellizzata, non è ritenuta essenziale, a cominciare dalla consuetudine della relazione, dal dialogo spesso inconcludente, sbrigativo o effimero, oppure legato a un particolarismi che quasi mai disegna il fondamento dell’universale.
Il nuovo immaginario è tutto ridotto all’esteriorità dell’impermanente, nell’apoteosi di un narcisismo senza stile, becero e piatto. E la voluta perdita del valore, del sentimento e del principio, che agisce in nome di un’arbitrarietà ripetitiva, seriale e, in sostanza, inconcludente. La virtualità è così la nuova pseudo relazionale norma, il canone.
Dice a riguardo Stefano Zecchi: “I linguaggi privi di una effettiva relazione tra i soggetti esibiscono soltanto un’oggettività come cosa da consumare; spesso si tratta di una cosa puramente virtuale, cioè immateriale, sottratta all’esperienza vivente: una virtualità che, per comprendere i suoi effetti sulla comunicazione, non deve essere esaminata in rapporto alla realtà ma all’immaginazione. La virtualità modifica la costruzione della forma dell’immaginazione. Nella virtualità, l’immaginazione non è più una raffigurazione che risulta dalla sintesi di esperienze, di astrazioni e di processi simbolici, (…). La virtualità modifica radicalmente la struttura dell’immaginazione in un senso puramente associativo e passivo. L’esperienza virtuale è infatti una partecipazione all’azione senza il rischio reale, oppure è una rappresentazione di ciò che è indifferente al suo esserci. In essa non c’è quella tensione alla realizzazione che, in ogni tempo, ha caratterizzato le forme immaginative e utopiche. La virtualità annulla il poter-essere dell’immaginazione, mortifica l’immaginazione del sistema comunicativo: la comunicazione virtuale è senza fondamento e non ha riferimento a un centro di significato; il contesto si sfrangia; nessuna parola è capace di creare- far immaginare e rappresentare forme espressive- percorrendo la tipologia del linguaggio mitopoietico. Esito di tutto ciò è che l’arte, nel tempo della virtualità, è indifferenza”.
Ma, posta la controversia del soggettivo verso una ricerca dell’oggettivo nella bellezza (intesa come una forma plausibile della rappresentazione del divino), come si può segnare o, se si vuole, indicare un sentire di risorgenza per l’arte e la sua espressione, in tempi di negazione dell’arte stessa e di inespressività e assenza di senso altro che di significato come nuovo canone. Ripartendo da uno, dalla singolarità, non credendosi però geni né profeti, ma laboriosi artigiani, facitori di ponti, estraendo l’eterno dall’effimero, come a proposito della moda diceva Baudelaire.
Gli elementi di poeticità ci pervengono dalla Tradizione, dal mito e dal simbolo e poi dalla filosofia, senza per questo costruire astratte e improduttive gerarchizzazioni di ciò che in realtà ha una sua unità che li trascende e li fa convergere, come avviene per tutte le arti.
Certo, i media oggi stabiliscono le regole della rappresentazione, l’artista che stabilisce la sua alterità al sistema della menzogna se ne può sottrarre, stare ai margini come diceva la Arendt, con la sua opera.
Oppure affrontare la tensione, la sfida, il rischio del pensare e dell’immaginazione, della sottovalutazione di pubblico e mercato sua apparente insignificanza rispetto, appunto, alla “democrazia dell’immagine”.
La scelta consiste in una sorta di ricominciamento perpetuo, una iniziazione spirituale, un rimettersi in tensione con la controversia e il tempo in cui si opera.
Degradare la bellezza, l’amore ridotto a desiderio di possesso, è una variante violenta della perdita di senso. Ecco perché compito dell’artista solitario- pittore, poeta, scultore, musicista, letterato, architetto, non importa – è non aver paura della sua condizione, del suo isolamento, e trovare magari compagni di strada, ma non necessariamente.
Il mito è nell’originario, ha bisogno di simboli e archetipi e di immagini, che si nutrono della luce e del pensiero. Gli artisti hanno il compito, se possiedono un autentico daimon, di risimbolizzare l’immagine che creano con il sentimento, con il buon gusto, con le vibrazioni, immersi nella sacralità, che sentono come un’urgenza di proporre, una soluzione verso l’opera e l’idea stessa di arte come una indispensabile proposta e messa in atto dell’umano vissuto e del trascendente come orizzonte.
Tornare, anche in un cenacolo di pochi fra maestri e allievi, a concepire come necessaria una palingenetica educazione, intanto al buon gusto, che parte da sé medesimi, per giungere allo stile in grado di connotare la vita nel carattere e nel modo e nella maniera di essere nel mondo, fino a giungere al grande stile, se si è geni.
Il nemico resta in tal guisa sempre l’artificioso (che non è l’artificiale), il travestimento appariscente, la perdita di profondità anche, e non raramente, a partire dal confronto col proprio corpo: “La bellezza è un dono straordinario, che può essere però pericoloso. Intelligenza è sapersi vedere, comprendere i propri limiti e accettarli, imparare a usare gli artifici per correggere la propria natura senza confondere una personale insicurezza psicologica con l’idea di non piacere. Soprattutto bisogna pensare che il corpo è un messaggio di valore che non va svilito trattandolo come se fosse cosa fra le cose senza alcun significato” (S. Zecchi, Le promesse della bellezza).
Tornando al grande e infinito tema del bello e della bellezza, ci sembra estrema la seguente affermazione di Hegel, allorché proclama che: “il bello artistico è superiore al bello naturale, perché esso è un prodotto dello Spirito”. Bene, naturale e ideazione e realizzazione del fare creativo, pur con tutte le influenze e suggestioni che si manifestano al di fuori del soggetto-uomo, non sono in realtà avulse da lui, perché la contemplazione è sempre del contemplante, che è anche la vista di chi vede, e perché la naturale parte, anche se unica e privilegiata, apparteniamo.
La misura sta sempre nell’equilibrio che è il nemico della scorrettezza e del cattivo gusto. Del resto il naturale, tanto, a volte a sproposito, invocato, è attraversato dalla mano dell’uomo, dalle sue realizzazioni e costruzioni.
L’incontaminato è un’illusione, una romanticheria, tuttavia a ribadirne la realtà non vuol certo dire distruggere impunemente e non adeguatamente da salvaguardare. Perfino l’agricoltura cambia i paesaggi “naturali”, li limita nell’aspetto e nella sostanza. L’agente è sempre l’uomo o la tecnica che lui sperimenta e che rischia, questo sì, di sopraffarlo.
Ma l’arcadia è solo un bel sogno incapacitante. Ancora, il problema resta lo spaesamento, l’indistinto, il disidentico, il rapporto ancestrale che si vuole recidere con la madre terra e il focolare, come pure indicò Heidegger e come aveva ben visto, simbolicamente, Leon Battista Alberti quando scriveva che l’architettura è nata per rendere felici, sostenendo che “quando case nobilissime sarebbero scomparse dalle nostre città e tante altre nel mondo, se il focolare domestico non ne avesse mantenuto i superstiti, quasi accolti in grembo dagli antenati”.
Nella bellissima poesia La mia galleria, Walt Whitman così ci rammenta la potenza della memoria che pensa come in un ideale museo: “In una piccola casa ho appeso dei quadri, non è una casa stabile, / è rotonda, pochi pollici appena da una parte all’altra; / eppure guardate, ha spazio per tutte le mostre del mondo, tutti i ricordi! / Qui padri della vita, là gruppi di morti; ecco, lo riconoscete? È il cicerone in persona, / con il dito levato indica i quadri senza fine”.
Obliati o perduti i valori connotativi, lo stile individuale è del tutto consequenziale, così come le perdite dello stile delle città, dei paesi, anche rispetto ai suoi diversi periodi storici, che ne stabilivano l’unità, attraverso una narrazione di epoche, non in un cimitero di viventi, affaccendati verso il baratro e neppure con l’utopia fredda di Brasilia o di Dubai o con le imposizioni violente dello ZEN a Palermo, del Corviale a Roma, del Gratosoglio a Milano, o, paradosso del nome, del “Paradiso” a Brindisi. Segni assai evidenti, che insieme agli anonimi condomini e “villini” in serie, significa in sostanza una dichiarata morte dell’arte, in quanto morte del concetto stesso di solidarietà, comunicazione, amicizia, che, rappresentavano invece, il cuore pulsante della città, legati com’erano alla simbolicità di piazze, chiese, palazzi, alla sacralità propria di riti, e culti, memorie, in una parola, a quel piacere estetico, in sostanza, che accompagnava il buon vivere, anzitutto nella semplicità e nella coltivazione dell’otium.
Si dirà, con evidente fondamento, di ricordi sepolti, forse ancora sussistenti fra luoghi e paesi lontani dai centri urbani, disumanizzanti e imbrattati di sudiciume e da graffittari incolti e suggestionati dalle spire del sistema menzognero.
Si chiedeva Fausto Gianfranceschi: “Si può impunemente parlare, oggi, di Dio, della bellezza, della virtù, del carattere, dell’eroismo, dell’amore? No. Il sistema non lo vieta, esso agisce in maniera più sottile: chi pronuncia quei nomi è fuori, è indietro. E, disgraziatamente, non si tratta solo di un’imposizione sostenuta da mezzi potenti, da ricatti efficaci; ormai è entrata nella mente e nel cuore da sensazioni che quelle parole siano favolosamente inutili, se non criminali”.
Con i versi scultorei di Antoine de Saint Exupéry, concludiamo: “E lavorano nella noia. Nulla manca loro / fuorché il nodo divino / che lega le cose. / E tutto manca”.
Tocca ai cercatori e facitori di bellezza, ritrovare e indicare il senso della vita, la sua unicità e irripetibilità, almeno per curare sé stessi e il mondo, se non proprio per salvarli.