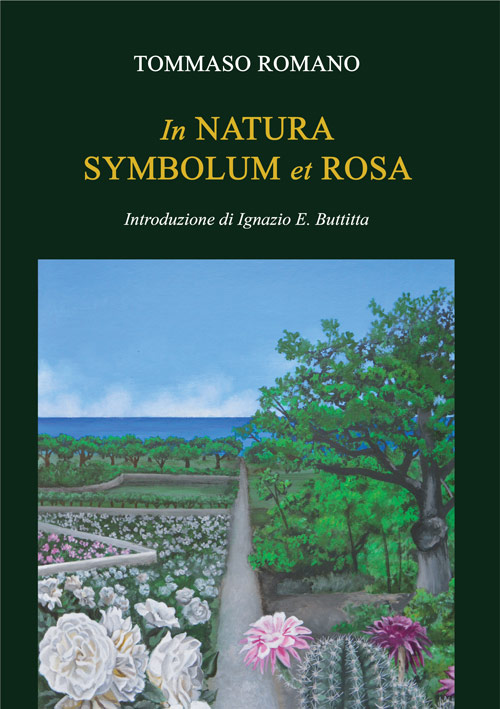“Scrivere storie con il potere intrinseco del mito.” - Nota di lettura di Arturo Donati sul “Devotion” di Patti Smith
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 19 Aprile 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1408
 “Devota come un ramo
“Devota come un ramo curvato da molte nevi
...ti insegnerò, mia anima
questo passo d’addio…”
Cristina Campo
Jean-Paul Sartre riconosceva precipuo valore filosofico al tentativo di rispondere esaustivamente all’interrogativo su cosa sia davvero la letteratura. Essa risponderebbe in primo luogo all’utopico esercizio di libertà e “motivo della creazione artistica è certamente il bisogno di sentirci essenziali nei confronti del mondo”.
Le dinamiche creative dello scrittore sarebbero pertanto subordinate alla committenza sociale che le ha poste in essere.
Viene così esclusa dalla genesi dell’opera letteraria la suggestiva relazione dello scrittore con la parola sorgiva. Nella realtà iper se non post-moderna, in linea di tendenza ciò è largamente sostenibile. Ma se lo scrittore si astraesse per un momento dalla sua preoccupazione per l’opera e per il bisogno di affermazione e si relazionasse con attenzione e meraviglia con le sue stesse parole in fuga dall’anima al foglio, facendo delle ragioni dello scrivere l’oggetto specifico della scrittura, lo spazio moralistico di risonanza sociale, imposto dalla pur sempre sussistente committenza collettiva vanificatrice della pura emersione del profondo, verrebbe ristretto sino alla soglia dell’invisibile.
Proprio dall’epicentro di questo nucleo problematico si dipana la trama ardita della sfida condotta a suo modo da Patti Smith nel prodigioso piccolo grande libro in esame nel quale, con rara intelligenza letteraria, la poliedrica artista statunitense sviluppa una fluida quanto affabulante narrazione di apparente semplicità, grazie alla quale ricostruisce e motiva la genesi della sua tormentata esigenza espressiva vera linfa della sua ultima e predominante ragione di vita.
E’ un libro che nel suo titolo adombra e sottintende una sincera apologia del sacrificio, tale infatti è l’etimo radicale e profondo della parola devozione, la cui semantica attinge al concetto di culto e di dedizione.
Di per sè il sacrificio in questione implica la sofferta rinuncia dell’io narrante alle fughe intenzionali nella libertà volitiva della temporalità espressiva. Infatti lo scrittore autentico, che opera nel nebuloso mandala contemporaneo della frastornante quanto indiscriminata comunicazione letteraria sociale, per quanto possa sempre raccontare ciò che vuole riuscirà a scrivere e dire veramente di sè e del suo circostanziato sentire, non quando lo vorrà.
Dovrà attendere comunque il sospirato intervento divino, oggi come agli albori della scrittura quando saettavano le frecce di Hermes.
Il cuore segreto del libro è messo a nudo nella prima pagina e pulsa tutto nel felice e lapidario incipit:
“L’ispirazione è la variabile imprevista. La musa che assale all’ora ignota.”
E così, grazie al sospirato ausilio della musa, viene alla luce un libro in due tempi con epilogo in cui le sezioni mantengono una relazione di fondo sostanzialmente musicale poiché il primo nucleo rappresenta quasi l’overture del processo immaginativo propedeutico al “vero” racconto che si sviluppa in apparente autonomia.
Si narra di un viaggio a Parigi per incontrare l’editore Gallimard nella monumentale sede, circondata da un ameno giardino, ove questi la riceverà nella stanza di lavoro che fu di Albert Camus. Una Parigi e dintorni da riesplorare, insieme a una compagnia discreta, nella sua topografia letteraria nella quale Patti Smith spazia e recupera memorie giovanili di una sensibilità oramai mutata per sempre che adesso anela irresistibilmente alla lettura degli afflati poetici dei grandi, condividendone le mozioni interiori. ù
La scrittrice traccia così schegge di profili delle loro spinte devozionali verso la parola scritta, approvandone le azioni guidate dal pensiero più profondo talvolta coincidente, pur se in modo differenziato, con il suo. Incarnazioni esemplari di spirito di finezza, veri compagni della sua nuova vita che si nutre di concordanze di afflati di cui rapisce i tratti più segreti. Pur nella brevità degli accenni ella dimostra di custodirli nel suo cuore che, con grazia senile, dispone a dimora di fantasmi in grado di parlarle ancora.
Trapassati protagonisti di vite irripetibili echeggiano in Patti Smith che li evoca pulsanti nello stesso ordine del discorso universale sul senso dell’umano che matura al limitare della vita e sottintende capacità di contemplazione. Proprio quella capacità di rispondere a un ordine superiore, come fu per Camus pellegrino solitario nella casa di Simone Weil, viene posta dalla scrittrice a cifra conclusiva della prima parte del libro.
Sezione che apparentemente si conclude senza ordine di continuità narrativa con un volo a Londra, ove le suggestioni giungono all’acme generativo, essenziale per le definizioni della scrittura, con la visita al cimitero di Bybrook. Luogo dove riposano le spoglie della filosofa francese alla quale dedica una enigmatica poesia che si accompagna alla fotografia della scarna lapide. Nei pregnanti versi si allude chiaramente al sacrificio:
“Giù nel profondo della terra le tue piccole ossa
...latte d’agnello è stato versato dal fianco.
...c’erano ostie a sufficienza
per ogni cosa vivente…”
La seconda parte del libro sviluppa l’anomala storia di una pattinatrice della quale non si effettuerà la disamina per lasciare intatta la fascinazione del possibile lettore. Di essa è fondamentale rilevare la sorprendente maestria di Patti Smith di sovrapporre piani narrativi e implicazioni riflessive sulle ragioni del cuore e dell’esistenza che accompagnano la descrizione della Bildung della protagonista delicatamente assunta a metafora vivente della polivalenza dei linguaggi arricchiti dalla sensibilità femminile sottilmente esplorata.
Sensibilità posta a modello iniziatico in cui l’affinità tra il visibile e l’invisibile si presenta imponente. Mentre la valutazione del principio discriminante, sulla base del quale può legittimarsi l’assunzione di scelta di un linguaggio totalizzante cui dedicarsi, resta sempre di ascendenza musicale e istintuale così come si evince da un passo particolarmente significativo:
“...di tutte le lingue che ho imparato, il pattinaggio è quella che so meglio. Una lingua senza parole, dove la mente deve arrendersi all’istinto…”
La Smith, con sottili espedienti narrativi, riesce a porre il problema dell’assunzione corporale del linguaggio per lei autentica incarnazione non mera assunzione di uno stile di vita. Piuttosto principio di necessità e vocazione irreversibile che impegna totalmente l’esistenza personale. Lo scivolamento sinuoso della danza artistica sul ghiaccio, totale espressione diretta del vivente, ha valore talmente compiuto che non sussiste bisogno della parola per essere comunicato, svelato. L’astrazione dal linguaggio “operata” dalla pattinatrice, monade anarchica paga della sua arte, è una rinnovata utopia di possibile libertà svincolata dalla socialità ingerente che in nome dell’arte deve essere in qualche modo respinta se non tradita.
Forse può giovare ricordare che Dante pose proprio i traditori della patria nel lago ghiacciato di Cocito, nel gelo glaciale della visione ove si consumava il destino dell’egoismo. Ma nella pattinatrice la metafora della rinuncia alla parola è quella di donarsi all’istinto che determina sia bellezza dinamica che vitalismo armonico guidato dall’immaginazione, quindi musicale.
Il problema fondamentale del contemporaneo è proprio quello dell’ideologia dell’ammissibilità della dissipazione dell’umano per soddisfare le istanze anche più estreme del vitalismo, posto a unico criterio ordinatore dei principi di libertà che prescindono dall’armonia. Assumere la disciplina di un linguaggio implica consacrarsi prevalentemente ad esso. Il nucleo dell’affettazione spirituale della nostra scrittrice è tutto qui nella scelta agonica tra due modalità poco compatibili di vivere intensamente la parola. Il primo quello della parola cantata attraverso un linguaggio di prodiga comunicazione di sè di alto valore sociale misurato sul piano del riscontro, impareggiabile nel suo caso.
Seconda modalità quella di vivere la parola secondo il riscontro sorgivo interiore, del silente appagamento di sè attraverso la scrittura che la esilia da tutto e la pone lontano dal porto sicuro di sempre nel quale più facilmente possono essere arginate le onde del destino. Esilio interiore che le restituisce una vertiginosa verginità poetica intrisa di stupore e di ridimensionamento senziente dell’unità di corpo e anima che necessita di solitudine (non a caso alla verginità cui in alcuni passi chiaramente si accenna).
Scrivere è uno sciogliere l’unità del corpo mutandola in parole, cifre costitutive di identità di valenza mistica.
Durante la scrittura il vitalismo si muta così in necessità di un nuovo spazio, ove la libertà si accompagna al rischio del baratro in nome dell’autenticità e del nutrimento della bellezza che cerca un corpo per esistere. La pattinatrice è una felice e complessa metafora della riscrittura dinamica del vivente in un contesto di predominante disincanto di inevitabile erosione e fugacità delle relazioni che restano incompiute nonostante estemporanee intensità e lasciano posto alle ossessioni:
“La loro era una storia che non poteva avere soluzione, ma solo un fine. Una storia con il potere intrinseco del mito… Quand’è che smette di essere una cosa bella, una cosa che riflette il cuore… e poi ti lancia in una voragine di ossessioni?”
Nel pensare di riscrivere il suo rapporto con la parola che emerge da queste voragini che risucchiano l’umano, Patti Smith si avvicina molto al concetto weiliano di ri-creazione della condizione umana che ha bisogno di leggerezza e grazia. La filosofa francese teorizza la ri-creazione e mira a perseguirla attraverso l’assunzione di una prassi totalizzante e sincretica che sia davvero all’altezza del destino e lo sfidi.
Patti Smith accettando la sfida della scrittura quale linguaggio prevalente a cui si sente destinata entra soggettivamente nella condizione agonica mentale che si accompagna alla riflessione sull’effimero.
Mentre il vissuto più o meno immaginario, divenuto oggetto di narrazione, posto fuori dalla corazza di argilla dell’ideologia del sensibile, si trasforma in dolorosa premonizione di morte, in elegante danza di sacrificio sul lago gelato ove si celebrano forme di disappartenenza alla vita:
“La frizione dei pattini accellerò la già prematura fragilità della superficie dello stagno...Eugenia non rallentò ma vorticò come se fosse al centro di un infinito di infiniti. Quel famoso spazio evocato e abitato dai mistici che non cercano più nutrimento su questa terra.”
Ma il suo è un misticismo emozionale non ancora trascendente, più mentale che religioso che non esclude forme radicali di riflessione sulla legittimità dell’esistere. Forse definibile con crudezza, una crudezza dettata soltanto da impietose ragioni di necessaria chiarezza, minimalista in quanto il misticismo resta pur sempre funzionale e ancorato alla percezione immediata e alla filosofia del fare. Con grande e rara onestà intellettuale la scrittrice ce lo lascia intendere:
“Eugenia gli confidò i conflitti con l’allenatrice. Maria non capisce il modo in cui lavoro. Come improvviso le mosse in una scacchiera. Pattinare per me è emozione pura, non la via per raggiungere la perfezione… Eugenia continuò a pattinare, ignara dei piani di entrambi. Aveva le proprie ambizioni… L’impossibile regnava nella poesia della sua mente. Fare ciò che non era stato ancora fatto, reinventare lo spazio, fare piangere.”
E se l’arte mantiene salda l’unità di senso della vita, la riflessione sulla temporalità e l’alternanza generazionale nella storicità, che nel libro viene richiamata attraverso la presentazione di un resoconto epistolare, risulta dissolta mentre nella soggettività viene mantenuta percepita in termini di fluttuazione e di legami poetici:
“Mi sentivo come se fluttuassimo nello spazio, e avevo paura… Non avendo un passato, abbiamo solo il presente e il futuro. Piacerebbe a tutti credere che l’unico posto da cui veniamo siamo noi stessi… Non ci sono segni che ci dicano chi siamo… Non aggiungeva nulla al breve resoconto della sua vita, solo variazioni della stessa poesia…”
Attraverso le suggestioni epistolari che conducono Eugenia a riflettere sulla propria origine e la definizione delle figure familiari cardini dell’esistenza, a sua volta Patti Smith reintroduce nel suo epilogo la riflessione originaria sul perchè della scrittura, vero corpo vivente del suo essere senziente. Con un volo pindarico ci riporta alla ricerca della dimora custode del mistero del trasporto verso la scrittura, tale è l’abitazione di Albert Camus nella quale si addentra autorizzata dai familiari al privilegio della consultazione del manoscritto originale de “Il primo uomo”. Il grande capolavoro incompiuto per l’improvvisa scomparsa dell’autore che lo portava con sè nell’auto che lo condusse sciaguratamente alla morte.
E la sua abitazione viene raffigurata come il nuovo tempio moderno, vero sacrario del mistero del linguaggio, dei segreti dell’ispirazione voluta dalla musa, ove il sacrificio che si celebra è nel vissuto che si consuma mutandosi nella scrittura. Se nella chiesa di SaintGermain visitata all’inizio del suo viaggio, la nostra scrittrice avvertiva “il familiare bisogno di ricevere il Corpo di Cristo” senza unirsi alla partecipazione sacramentale degli astanti diversamente in quella stanza santuario di Camus, partecipa al rito. Al rito “rovesciato” della scrittura, quello della lettura di quei fogli che effettua con intensità e lentezza divinatoria. Scorre le prime cento pagine intestate con il suo nome che scompare nelle successive. Ma anche questo rito resta incompiuto, perchè sottratto dalla sua capacità di divagazione all’assorbimento totale, alla con-fusione di quella vocazione alla propria.
E con felice tempismo la nostra scrittrice si affretta a motivare l’affievolirsi della sua concentrazione e della perdita dello stupore rilevando l’indomabilità personale di “quella pulsione che mi impedisce di arrendermi del tutto a un’opera d’arte… per sperimentare una sbirciata al divino che potrebbe diventare anch’essa una poesia. E io sono sopraffatta dall’arroganza del credere di essere in grado di rispondere a quella chiamata.”
Una dichiarazione di soggezione alla sopraffazione che lascia intendere una velata nostalgia e una contraria orgogliosa compiacenza dell’indomita volontà di cercare sempre una propria fonte generativa di intrecci che nel loro insieme per lei sono tutto e non soltanto vita.
Patti Smith con coraggio inaudito in questo piccolo libro denuda i suoi intenti titanici maturati nel viatico del suo irripetibile vissuto. Novella portatrice di un processo devozionale verso la scrittura che assume la valenza di una diversa genesi, di un tentativo utopico di sincera narrazione di un rinnovato inizio.
Una forte pretesa che le dona grande efficacia espressiva nonostante rischi di naufragare in una involontaria parodia del logos sempre più presente nel panorama letterario del nostro tempo. Adesso che la mestura tra sincretismo della bellezza e apologia della libertà ideologicamente svincolata dalla morale, relegano l’uomo, nel mondo sempre più scristianizzato, a dimorare le regioni dominate da destini minori.
Luoghi incerti, ove le volizioni senza confini sono scisse dalla perfezione e dal sacro, in cui tutto può in qualche modo essere divinizzato come la ristrettezza delle visioni, l’insorgenza delle inquietudini, la metamorfosi dei colori e la fugacità dell’amore che sorride nel candido segreto dell’inverno.
“...trascinata fuori da una finestra
da cui non si può più vedere.
C’è sangue dappertutto
prosciugato del suo colore rosso.
E la faccia dell’amore non è altro
che il candore dell’inverno
che ricopre la collina…”