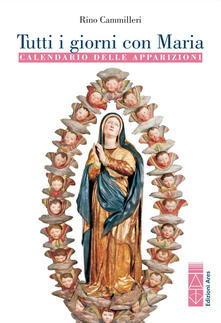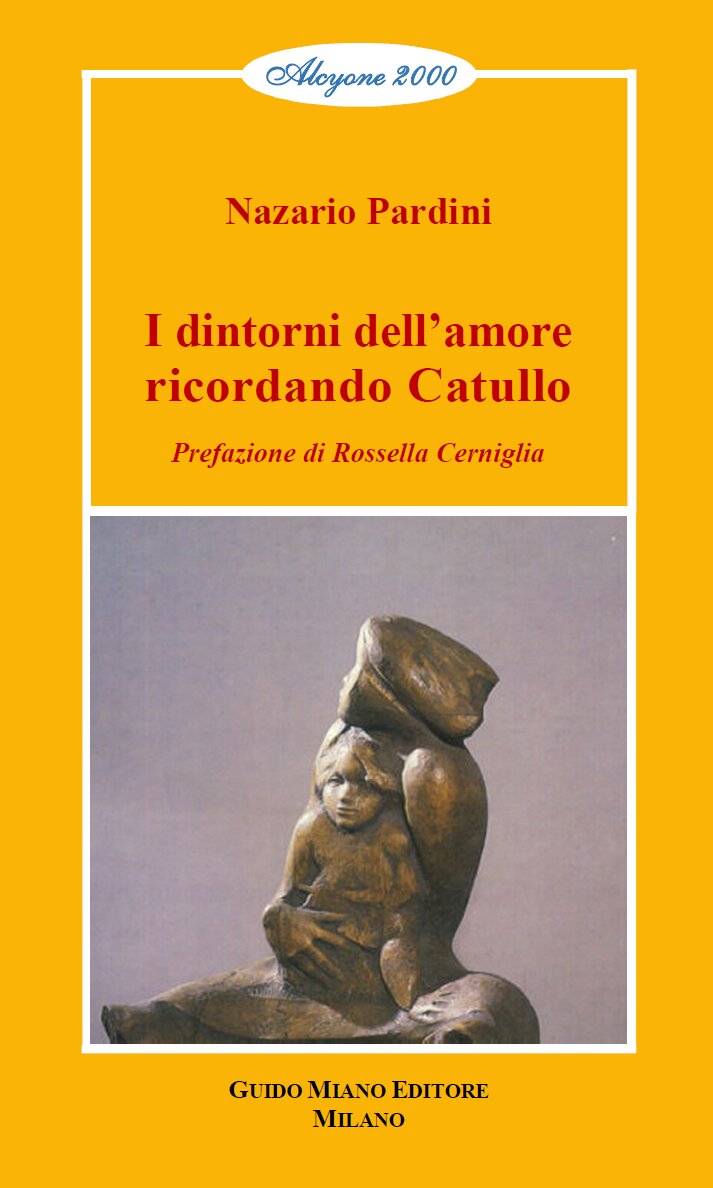Le scarpe di Van Gogh
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 28 Agosto 2018
- Scritto da Emanuele Casalena
- Hits: 4599

Nel 2000 il motto della biennale di architettura di Venezia, era "Less aesthetics, more ethics" trad. “meno estetica, più etica”, frullato di sinergia aperta tra l’arte di Dedalo e le sorelle maggiori ma soprattutto con le ultime nate, le figlie della divina tecnologia. L’architettura contemporanea non ha come obiettivo la ricerca del bello, è palese, del transfert di piacere che accarezza i sensi, val bene anche il brutto eretico, purché divergente dal passato, ma che sia pioniere affamato di nuovi strumenti di assemblaggio del progresso a 360°. A dire il vero questa riflessione del demiurgo dell’evento è assai datata e lapalissiana. Il cemento armato del giardiniere Joseph Monier fu una rivoluzione, come ignorarla, idem la pittura a olio dei fiamminghi o le resine nella scultura, ma non comportano una resa nella ricerca della bellezza, dono gratuito da consegnare all’uomo. Il bello è sempre stato il cuore del fare arte almeno fino al crack storico degli anni ’60-’70, quando i processi industriali assorbono, per proprio uso e consumo, quelli artistici per puro business (Warhol docet). Anche l’aforisma di Fuksas “Bisogna diminuire la componente puramente estetica a favore di quella etica” è una bilancia fra due elementi non inversamente proporzionali, perché se l’estetica è la dottrina del bello sia naturale che creativo e l’etica la ricerca di comportamenti razionali buoni, giusti, leciti, entrambe le due branche perseguono lo stesso fine: la verità ch’ è fusione di bene con bello. Diminuire il peso di una delle componenti porta alla scesa dell’altro e viceversa; il tempio greco è armonia geometrica tra le parti che nell’insieme dialogano, in assoluto rispetto, con l’ambiente naturale, cui s’ispirano; così è per la casa Kaufmann di F. L. Wright poggiata come un vassoio sul ruscello Bear Run in Pennsylvania, magari la stessa interconnessione non si rileva invece nella brutale chiesa di S. Paolo Apostolo a Foligno dell’archistar con la testa nella Nuvola.
Il nocciolo, tolta la buccia amara, è un altro, parafrasando le parole del “folle uomo” della Gaia Scienza, gli eunuchi dell’hi tech gli fanno annunciare: “L’arte è morta! L’arte resta morta! E noi l’ abbiamo uccisa! Come ci consoleremo noi, gli assassini […]?”, beh con un’etica laica, antropocentrica, fondata esclusivamente sulla libertà assoluta di perseguire diritti civili e sociali in virtù del proprio ego interconnesso ad altri, il progressismo tanto caro al pensiero Dem americano.
Sulle pareti delle Gallerie, sui muri delle periferie quanto sulle torri delle City, fino agli schermi mai spenti dei tablets scorrono i necrologi delle vecchie arti figurative, la loro tragedia sacrificale è in atto, l’ecatombe di Tessali, un tempo rimandata di anno in anno, è in avanzata mattanza, trasversale alle “arti belle dove s’adopera il disegno” come le chiamò Filippo Baldinucci storico dell’arte fiorentino del ‘600. E’ il Kali yuga anche del bello in un’epoca di precipitazione gravitazionale verso lo 0 dei valori tradizionali, la morte bussa anche alla filosofia madre dell’Estetica, alchimista del fenomeno artistico, ormai cul de sac senza via d’uscita della società industriale e postindustriale.
Thomas Adorno nella Teoria estetica (1970) si domandava se una società di massa avvertisse ancora il bisogno dell’arte, anzi, per il filosofo della Scuola di Francoforte, questa necessità è stata abolita, uccisa, per lasciar posto all’arte di massa: il Kitsch, termine tedesco che significa “scarto”, oggetto vistoso, dozzinale, di dubbio gusto, rimozione della paura del brutto. L’industria prospera secondo protocolli rigorosi, soddisfare i bisogni presenti creandone di nuovi, espandere l’offerta stimolando nuove domande alle quali sfornare risposte, e questo accade anche per l’arte, lo sperimentalismo cerebrale annoia, è inutile, non serve, cattura solo élites di collezionisti, di scommettitori sui prodotti a rischio, ma non incide più di zero nella quotidianità culturale della massa. L’arte o si rapporta con l’industria, con il desiderio di possesso orizzontale del prodotto o diviene un’ottusa manifestazione di estraneazione-alienazione dal contesto dinamico del sistema globale, un’aliena chiusa in prigione. E’ il sensazionale che eccita gli ormoni, smuove i capitali, mette in fila l’uomo-cosa in coda ai grandi magazzini, lo chiude in una stanza davanti al cellulare perché senza “le cose” non può vivere anche se non sa nulla della scienza che le ha create.
Il mio relatore arch. Giulio Roisecco aveva lasciato l’esercizio della professione, lui che disegnava a matita città ideali al pari di quella pierfrancescana di Urbino, viveva da monaco nel suo studio perché schifava il brutto che avanzava ovunque nel nome della sola téchne, il mio vicino A.V. passava ore a stendere paziente velature sui suoi quadri secondo un metodo antico ma senza alcun successo commerciale. I sarti sono scomparsi dai paesi, le mamme non rammendano un calzino, la maestra dei bambini è solo la televisione, il telecomando è una filosofia di vita: si cambia! La tecnica ha trasformato il linguaggio, sminuzzandolo in frasi convenzionali, situazionali, idiomatiche, memorizzati ma privi di un “vedere pensante”, sufficienti alla comunicazione quotidiana, alla sopravvivenza. Il verbum decade ad anoressico strumento minimale, virtuale, colui che lo emette non ne conosce il significato, è un analfabeta, ne fa uso come accendere una radio, aprire una portiera d’auto, messaggiare veloci SMS sincopati.
L’ente, quello che impropriamente chiamiamo essere, diventa una cosa della quale non conosciamo la verità intrinseca ma solo la funzione di servizio; è un processo in atto e non ci è dato saperne gli sviluppi ma presto la robotica ci piegherà al suo di linguaggio nelle parole come nelle realizzazioni d’arte, anzi questo già accade, basta merlinare con l’informatica.
A noi qui interessa la comune meta di Estetica ed Etica, cioè la Verità o Alétheia, rivelazione, stato di non nascondimento dell’essere, cui le arti costituiscono fondamento, messa in opera dell’epifania della verità, secondo Martin Heidegger.
Stimolato da un esempio assai celebre del filosofo tedesco, osservo da auto alienato (direbbe Marx) il dipinto Un paio di scarpe, olio su tela di Vincent Van Gogh datato 1886 anno della sua permanenza parigina. Quel che vediamo sono due scarponi assai malmessi, simili agli anfibi militari, ridotti in fin di vita per l’usura, poi entrambi sinistri, ben aperti quasi da avvertirne l’odore rancido del cuoio impregnato di sudore, le stringhe sono al bianco del cotone, espressionismo di sagome deformate, sono soli, appoggiati su quel ch’ appare un sacco giallo che lascia intravedere un pavimento in mattoni posti a taglio. L’oggetto che scrutiamo all’apparenza è un semplice quadro, la mimesis d’un paio di scarpe, dal punto di vista strumentale esso non serve a niente perché non posso indossarle, perciò commenterebbe l’homo tech: cui prodest? Posso però riflettere e immaginare, con un po’ di fantasia, come fece Heidegger, che le scarpe vestano i piedi d’ una contadina, lei se l’è sfilate, le ha poggiate sul pavimento dopo una lunga giornata di lavoro nei campi, quegli scarponi raccontano la sua fatica, quella giornaliera del mondo contadino, il camminare sulla terra bagnata, dare appoggio sicuro nel fango dei viottoli dei campi, lungo i filari, calpestare lo stabbio delle aie, salire sulle scale appoggiate ai rami, ecc..Ora che sono lì a riposo, sfatte dall’uso del giorno, respirano e ci raccontano. Van Gogh nel farne delle modelle, trasformando la loro umiltà in opera d’arte, rivela ai nostri occhi la loro essenza, “ciò da cui e per cui una cosa (le scarpe) è ciò che è ed è come è “, in pratica quelle scarpe manifestano l’essere proprio e del mondo cui appartengono, aprono alla sua conoscenza, all’essenza della vita rurale, ci illuminano della sua verità e l’apparire della verità è la bellezza oggettiva. Due enti, l’artista e il quadro sono interdipendenti, l’uno non può esistere senza l’altro, ma il compito del primo è altamente etico: la ricerca difficile, ostica della verità ( i dei fuggiti) cioè l’essere nascosto nell’ente e disvelarlo. Non ci addentreremo oltre nella teoria estetica di M. Heidegger che ha suscitato non poche polemiche tra storici dell’arte “specializzati” sull’artista olandese ma sottolineiamo due elementi:
Heidegger coglie in anticipo il forte disagio di una società tecnocratica dove l’arte e l’estetica non avendo funzione pragmatica vengono relegate a mero esercizio ornamentale, di arredo, ormeggiate nel grande porto del consumo e questo fare o subire è profondamente antietico.
L’arte è fondamento ontologico del mondo o dei mondi se preferite, se non attua questa sua vocazione diventa esercizio superfluo, minimale, vergine stolta senza olio per accendere la luce, posizione antitetica, la nostra, a quella del poeta P. Valéry che definiva ottusa un’arte non integrata nel piranha dell’economia industriale.
John Keats scrisse nel 1819 un’ode dedicata alla bellezza senza tempo di un’urna greca ( l’ente), bellezza per noi uguale alle scarpe di Van Gogh, ne riportiamo la prima e l’ultima strofa:
“ Tu ancora inviolata sposa della quiete,
Tu figlia adottiva del silenzio e del lento tempo,
Narratrice silvana, tu che sai esprimere
Una favola fiorita più dolcemente delle nostre rime […]
“Bellezza è verità, verità è bellezza,-questo solo
Sulla Terra sapete, ed è quanto basta. “
Quell’urna antica, dopo secoli, ancora ci disvela la verità di un mondo bucolico, agreste non diversamente da Un paio di scarpe di Van Gogh.
Emanuele Casalena