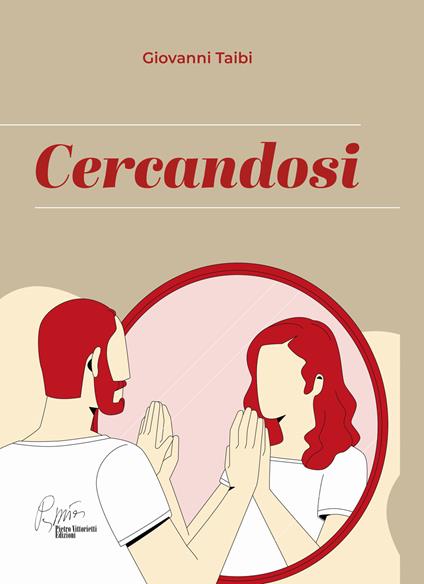"CANTO GRECO" Il mito e la poesia di Giovanni Teresi
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 10 Maggio 2018
- Scritto da Giovanni Teresi
- Hits: 2964

Prefazione
Nella lirica del poeta Giovanni Teresi la descrizione del paesaggio è concentrata attorno a quelli che diverranno i caratteri topici del locus amoenus: l’acqua corrente, gli alberi, il prato fiorito, la brezza primaverile; ma il tutto è avvolto in un’atmosfera di intensa sacralità. Gli spazi attorno il tempio appaiono come uno scenario adatto per una epifania, un luogo degno degli dei e capace di elevare alla sfera del divino anche le comparse umane che ne fanno parte.
Il rito si rivela come l’unico spazio in cui il divino può scendere al livello dell’umano e l’umano elevarsi al divino; l’unico spazio in cui è consentito varcare per un istante il limite che separa l’umano dall’eterno.
L’autore, innamorato della originaria sacralità dei luoghi della sua terra, impianta in essi un palcoscenico naturale ove si svolgono scene della mitologia greca; ciò si evince in tutte e cinque i componimenti presenti in questa nuova silloge.
Senza dubbio è anche l’influsso dello studio di noti autori greci che lascia una traccia nel versificare del poeta Teresi, intrisa però della sua originale musicalità.
Nel poema “L’amore platonico” l’uomo è visualizzato solo in ragione del suo apparire vicino alla fanciulla Altèa che è la vera destinataria del canto. La rassegna dei sintomi delle vicende amorose, è sviluppata con cristallina lucidità e occupa l’intero componimento.
I versi, nella rima alternata, esprimono un’armoniosa musicalità ch’è tipica dei canti greci. Infatti nell’epica greca la musica andò sempre strettamente unita alla poesia, ed in seguito anche alla danza. Col canto il poeta descrive lo scenario attorno al tempio di Segesta ove si snoda una processione di figure che elevano canti saliari (1) ed offrono doni agli dei.
Nel poema “Il figlio della pioggia d’oro” l’autore apre l’ode con un dolce canto arvale (2): “Iniziò una pioggia leggera,/ poi sottile e portentosa…/ l’aria mandava riflessi,/ n’era piena di luccichii ed odorosa.” mentre tutta la storia mitologica si svolge nel tipico paesaggio mediterraneo “alle rive sabbiose di Sèrifo”.
Come sappiamo miti e leggende si sono stratificati per millenni nelle memorie dei popoli del Mediterraneo costituendo un patrimonio vasto di cui emergono riconoscibili ancora oggi i temi dei racconti biblici accanto alle tragiche vicende della tradizione greca.
Coi poemi “L’eroe tutta forza” e “Le dodici fatiche” il poeta Teresi ripropone la mitologia con una nuova veste scenografica e col rigoroso rispetto dei canoni estetici nella struttura, nella forma ed anche nell’uso delle parole.
Con l’immaginazione la tenda si alza sullo spettacolo delle prime stelle che si inseriscono nel blu del cielo che lentamente si fa nero anche per gli influssi sovrannaturali.
Col poema il “Canto greco pietoso” dai dolci versi iniziali: “Le dorate arpe suonavano note prodotte da mani sapienti…/Ninfe leggiadre cantavano l’amore/ accompagnato da venti/” si passa al doloroso canto di Niobe moglie di Anfiòne, che patì la morte dei suoi figli per mano di Artèmide. In tutta l’opera l’autore vuole soprattutto dimostrare che la poesia non è soltanto un uso specifico del linguaggio, ma anche chimica della civiltà e delle credenze e che in particolare la cultura classica mediterranea è la fucina di sensibilità e pensiero.
Elisa Magurno
- (1) I canti saliari, prerogativa dei Salii sacerdoti di Marte, venivano cantati danzando intorno all’altare del dio accompagnandosi col suono delle spade.
- (2) I canti arvali, cantati dai sacerdoti di Cerere, celebravano la natura e la fecondità della terra.

L’amore platonico
Sulle chete colline ridenti
Zefiro soffiò con inaudite forze
sollevando sterpi e polveri ingenti;
preparava la terra ad accoglier
/nelle pozze
le acque fertili con gioia…
Transumavano gli armenti
/vicino la fiumarella
sull’erba tenera con gaia
guida d’una leggiadra pastorella,
che di tanto in tanto rincorreva
le stupide pecore belanti;
così fresca allegria faceva
su quei colli con grida e canti.
L’erbosa valle s’estendeva rigogliosa,
vicino ad una cittadella radiosa
chiamata Segesta, ch’era famosa
per il commercio e le sue gesta.
Sulla vicina piazza a sera
/si radunava la gente mesta,
in processione andava portando
fiori e ceri, a ritmo danzando…
inneggiava cantando un inno sacro
/al tempio.
Lì giunti e prostrati al Dio,
si consumavano i ceri in silenzio pio,
ciascuno si chiudeva nel proprio io.
Coscienziose dell’offerte opulenti,
le fanciulle sfilavano nei loro panni,
offrivano con gesti lenti
i canestri colmi di frutta e carni.
S’uccideva il bue, l’agnello…
Continuavano le danze a notte fonda,
finché nell’oscuro mantello,
lasciava il dì l’ultima sua onda.
Da lì a poco il tempio s’illuminava
/di tenui luci,
imponendosi maestoso tra il volo d’uccelli.
I festanti stanchi lasciavano alle fauci
dei lupi le ossa e le pelli;
poi rinvigoriti dall’alba gioiosa,
iniziavano da amici e fratelli
a lavorare la terra non più ombrosa.
Anche la pastorella, di nome Altèa,
volgendo lo sguardo all’aurora,
si spogliò delle sue vesti, altera
nella fiorita primavera,
rincorrendo le pecore ogn’ora.
Visto che danze e canti
/divennero i misteri,
si costruì un teatro di forma circolare,
ove lasciare i propri pensieri.
Allora, volò in circolo alare
una bianca tenera colomba…
si pensò portasse dai vicini Greci
delle buone nuove dall’ombra
dell’imminente guerra con i Fenici.
Ma…le acque minacciose s’estesero
a deturpar le vicine sponde.
Zeus furente dipinse il cielo tutto nero
come pure il mare colle sue onde.
L’ammonimento fu valido per un anno,
dopo si riprese a danzare, a cantare
senza pensare ad alcun affanno.
S’offrirono fiori sull’altare…
Dalle taverne Bacco usci tra i vicoli sinuosi
offrendo il novello vino rosso e bianco;
Sileno seguì traballante gli amorosi
nel frenetico ballo fianco a fianco.
Altèa, fanciulla bella e sana,
non conosceva ancor alcun uomo;
ma pensava sola nella sua tana
d’incontrar il suo principe buono.
Furono eretti molti santuari
agli Dei dell’Olimpo; si dettero feste
/alle Delphinia,
che, a primavera e alle fasi lunari,
facevano gustare le primizie offerte dalle Thargelia.
Ma per selve inesplorate e valli ombrose,
aspetto guerriero assunse la festa d’Apollo,
dio dall’arco d’argento e dalle frecce radiose.
Colà giunse, attirato da una cerva e da un pollo,
un giovane, Atteòne famoso cacciatore.
L’ospitale isola accolse pure Artèmide la bionda
anch’ella amante dell’arco, la faretra in tutte l’ore.
Le frecce dalle punte d’oro scoccate dalla bionda
andavano dritte al segno tra fronzuti faggi.
In compagnia di Ninfe e giovanette mortali
trascorreva le sue giornate con assaggi
di lepri, lungi dalla guerra e dai mali.
Atteòne s’avvicinò per ammirare
da vicino la dea, che celere col cavo della mano
spruzzò semplice acqua di mare
in faccia al cacciatore sin allora umano.
Subito ad Atteòne spuntarono le corna, il pelo,
gli si mutarono in zampe le mani,
ansante fuggì affrontando il gelo
disperatamente inseguito dai suoi stessi cani.
Però la bella Artèmide era d’animo gentile,
protesse le donne che a lei si rivolgevano
e al parto ne alleviò i dolori amari come la bile.
Sulla spiaggia sicana le sirene cantavano,
l’acque si quietavano e posavano i venti,
i naviganti quelle voci leggiadre udivano,
veleggiavano emozionati battendo i denti.
Attratti dalle ninfe formose,
dimenticarono le mogli partorienti,
come d’incanto furono attratti da inutili cose.
Le donne a terra si tiravano i capelli,
gridavano strappandosi le vesti consunte…
Lì vicino altri uomini ponevano gioielli
sui gradini dei templi di Selinunte.
Tutto quel vociare stralunato
sulle lunghe spiagge indorate
annebbiò la vista e mozzò il fiato
ai marinai per intere giornate.
Lontana dal frastuono, Altèa sognava
con le sue pecore belanti,
una calda preghiera volgeva
ai numerosi dei vaganti
tra le calcaree colonne poste a dismisura
sui verdi colli e sulle pianure estese
volte al cielo, alle stelle
/con le maestose mura.
Povera, solitaria, bella ma cortese
Altèa tra le canne della fiumarella
vide muoversi qualcosa;
subito sentì nel suo cuore una fiammella…
Era un giovane! Divenne radiosa.
S’aggirava guardingo tra gli arbusti
un abile cacciatore di nome Oriòne
col suo cane, le frecce, gl’archi giusti,
con coltelli ed anche un piccone.
Alla vista della bella giovinetta
il suo sguardo divenne smagliante,
simile ad una cerva su d’una vetta,
l’osservò immobile e ansante:
“Qual è il tuo nome? O gracile fanciulla!
Un egual fiore non sboccia in tal luogo,
né agile gazzella si ferma nel nulla
ad osservar le proprie carni presto sul rogo!”
La giovane, timida e pensosa alle crude parole
del cacciatore spavaldo, indietreggiò:
“Il mio nome è Altèa…” il suo viso
/avvampò come il sole
“ sono sola con le pecore” balbettò.
L’abile Oriòne sfrecciò un sorriso:
“Allora tra i templi cacciagione ce n’é tanta!
Non puoi nascondere il rossor del tuo viso!
Se parlar non vuoi, almeno canta”
Così un leggero suono di piffero di canna
si levò attorno con armoniose note,
le membra si sciolsero come fior di panna
e al sole più bianche erano le sue gote.
A tal inusitata timida bellezza
Oriòne non esitò a farle un dono
trasse dalla farètra con gaiezza
un piccolo anello cantando così a tono:
“Non vedranno mai i miei occhi
cotanta bellezza calpestar le zolle!
Le note vagar eleganti ai tocchi
delle sottili labbra empiendo
/di magia il colle,
di fiori profumati è colma l’aria fine
e dolce amor cosparge la tua danza!
Raggio di sole è il dorato crine,
batte il mio cuore con baldanza…
Tal dono è piccola cosa!
Non voglia Venere adombrarsi
per la terrena bellezza gioiosa,
ma faccia sì che amarsi
sia accompagnato da simil canto
tra i templi maestosi”.
Nella prospiciente verde valle
un volo di stormi copiosi
si levò tra i rami dell’irto calle.
Sìrio, fido cane d’Oriòne, puntò
le astute orecchie pronto a prendere
la selvaggina, tra sterpi e sassi saltò
baldanzoso cominciando ad abbaiare.
Il cielo si cosparse di fitte frecce
che l’abile cacciatore scagliò tra i colombi…
Altèa d’istinto sciolse le bionde trecce,
indi indietreggiò muovendo
/gli scultorei lombi;
l’anello intanto provava al dito, timorosa
guardando Oriòne ed il suo cane ansante.
Artèmide, colla sua abilità, gelosa
disdegnava tal puro sentimento gigante,
schioccò due frecce dritte ai cuori
di Sirio e Oriòne che tramortirono tra le canne.
Zeus, che dall’Olimpo, scrutava fuori…
da tal gesto inusitato volle trarne
il ricordo del cacciatore e del suo fido
in mirabile eterna costellazione.
Ad Altèa rimase l’anello al dito,
un attimo d’amore che non fu finzione;
guardò in alto l’oscuro cielo,
intravide tra le stelle severe e immote
la costellazione, commossa si tolse il velo.
L’amor, che segnò il giovine cuore,
mutò il destino in caparbio e duro…
L’odio si versò su Artèmide in tutte l’ore,
serbò l’aureo anello vicino a un muro.
Altèa divenne fragile e cogli anni vecchia.
Sirio e Orine stanno ancor lì tra le stelle
a guardar la stanca terra senza macchia
divenuta rinsecchita e senza pelle.
Il figlio della pioggia d’oro
Iniziò una pioggia leggera,
poi sottile e portentosa…
L’aria mandava riflessi, n’era
piena di luccichii ed odorosa.
Coprì d’oro la torre marmorea
ove Acrìsio aveva rinchiuso la figlia
Dànae, bellissima pari ad una dea.
Il Fato, giunto da parecchie miglia,
fece che la pioggia entrasse
dalle sottili fessure nella squallida cella,
ove giaceva sotto le umide asse
Dànae con la pallida ancella.
Zeus era la pioggia dorata,
desideroso d’unirsi con la figlia di Acrìsio,
non disdegnò uscir dall’acqua salata
e baciò l’amata con soave brusio.
Nacque Pèrseo, il grande eroe,
sbalordì il re ch’ebbe paura:
quel neonato un dì l’avrebbe ucciso nell’ore
impensate; così trasse dalle mura calcaree
madre e figlio, chiudendoli in una cesta,
li affidò alle turbolenti onde del mare.
Alle rive sabbiose di Sèrifo, giunse mesta
la cassa ripescata dal re Polidette.
Costui li ospitò grattandosi la cresta
in quell’isola piena di rocciose vette.
Trascorse il tempo… Pèrseo passò
la breve giovinezza bello e forte,
con l’impeto d’un toro amò
la figlia del re invidiata dall’intera corte.
Una missione pericolosa gli affidò Polidette,
doveva in quell’isola portare la testa di Medusa
perché di Pèrseo la poderosa forza temette.
Così, volgendosi ad una musa,
/alimentava la speranza
che il giovane perisse nel compiere l’impresa.
Però Pèrseo, fiducioso nella sua valenza,
nell’aiuto degli dei fece tutta la sua presa.
All’uopo Ermes, dall’Etna,
/affilò una falce diamantina
per tagliar la testa alla Medusa infernale,
ed Atena fabbricò uno specchio
/per guardar, quella mattina,
la mostruosa testa senza scrutar lo sguardo fatale.
Anche dalle Fòrcidi ebbe aiuto, ninfe severe,
da cui ebbe dei calzari alati,
una bisaccia ed un cappuccio dalle falde nere.
Pèrseo s’incontrò con le Gorgoni: non venerate
perché orribili con le teste inghirlandate
da serpenti, zanne prominenti e mani artigliate.
Dormivano i mostri quando Pèrseo,
/servendosi dello specchio,
riconobbe la testa scellerata.
Prese di mira chiudendo un occhio,
e la testa mozzò con la falce dentata.
Subito da quel tronco insanguinato
nacque Pègaso: cavallo alato.
Ripose l’eroe il capo mozzato nel sacco,
salì coi calzari alati sfuggendo all’ira delle sorelle
rendendosi anche invisibile
/col cappuccio color tabacco.
Veloce come il vento e l’acque delle fiumarelle,
attraversò paesi misteriosi sin in Etiopia
ove liberò Andròmeda dalle bianche mammelle.
Era destino compiere un’opera pia
dato che il re Cefèo l’aveva data in pasto
/ad una bestia immonda
mandata da Posidone a punizione del gran fasto
e superbia della regina Cassiopèa dalla faccia rotonda.
Ancor Pèrseo liberò quella gente dal mostro,
poi Andròmeda sposò in elegante chiostro.
Dopo tanti tribolazioni e affanni
lasciò gli Etiopi diritto verso Sèrifo solitario.
Pietrificò Polidette che tramava da anni,
regalò ad Atena la testa col sudario.
Ma il Fato si compì egualmente:
non ebbe colpa Pèrseo, fu una disgrazia!
Durante la gara un disco tristemente
colpì Acrìsio nella sua senile baldanza.
L’eroe tutta forza
Eracle, figlio di Zeus e Alcmena,
uomo dal muscoloso petto
/e braccio scattante,
non esitava a far forza
/per romper la catena;
coperto di pelle di leone,
/aveva la mano possente.
D’aspetto austero e pensoso,
ebbe vita travagliata ed errabonda.
Del suo temperamento focoso
soffrì la moglie Megara dal viso rotondo
che gli dette un figlio pure iroso.
Era, figlia di Cronos e Rea, fu ostile
alla nascita di Eracle
/per il regno di Argo e Micene;
gli sconvolse la mente, divenne pazzo e vile,
uccise moglie e figlio tagliandone le vene.
Dopo, Eracle volle pagare il fio della sua colpa,
partì a Delfi a consultar l’oracolo:
“Andrai a servire Euristèo per riscattar la tua colpa,
di fatiche sarai sottoposto ogn’ora, solo un miracolo
potrà salvarti e mangerai non la polpa
ma le ossa degli armenti del tuo pascolo!”
Furono ben dodici le fatiche
dall’uccisione del leone di Némea
alla cattura del cane Cerbero, belve a lui nemiche.
Affrontò monti e agitate maree,
lottò con Achelòo, dio fluviale,
ne sposò pure la figlia Deianira.
Ma l’uccisione del centauro Nesso gli fu fatale
tanto che costui, con raggiro, mostrò tutta la sua ira.
Nella tunica, intrisa col sangue suo, fu l’inganno;
la diede a Dianira per farla indossare a suo marito;
dicendole che, se la provava, l’avrebbe amato ogni anno.
Eracle si vestì dell’orrenda tunica, ma da tal rito,
ne usci dolorante e ferito.
Morì soffocato dal fumo d’un rogo su questa terra.
Zeus l’assunse al cielo godendo d’eterna giovinezza.
Lassù sposò Ebe. Così immortale l’anima sua erra
con la forza e la spavalda bellezza.
Le dodici fatiche
Le terre di Némea devastava
un leone dalle fauci possenti;
la gente aveva paura nell’Argolide,
/donde stava.
Eracle affilò armi e denti;
pur forte il felino, alle frecce appuntite,
perì soffocato dalle sue mani possenti.
Della pelle ne fece un ampio mantello,
della fiorente cresta un elmo bello.
Vestito di pelle girava per lungo e largo…
Quando entrò in una lugubre caverna
s’imbatté col mostro dalle teste di drago.
Sotto il taglio della spada, l’idra di Lerna
non mollava le fauci appuntite,
così Eracle bruciò il drago spossato,
si servì della bile per rendere le frecce
/velenose e ardite.
Subito l’eroe riprese un po’ di fiato,
partì per l’Arcàdia e lì vicino a Erimanto
catturò un cinghiale d’aculei armato.
Indi lo portò a Euristeo,
/avvolto nel suo manto.
Errò per selve ombrose morto di fame
a caccia d’una cerva dalle corna d’oro
che cercò di catturarla.
/Velocissima dagli zoccoli di rame,
dopo tanti stenti, la colpì in una zampa
/in groppa ad un toro
risalendo il monte Mènalo
/che acutizzo la sua fame.
Li vicino era il lago di Stìnfalo,
/dalle acque chiare
gremito da voracissimi uccelli, il cui becco
era di bronzo al pari delle ali.
Colle frecce velenose e ardite, ecco!…
riuscì a disperderli senza indugio
/tra gli impervi canali.
Dopo un meritato riposo, ripulì le spade,
mise ordine alle armi e alle pelli;
doveva combattere le Amazzoni,
/comandate dall’Ade.
Ippòlita era regina delle donne guerriere,
incontrò il muscoloso eroe che l’uccise
prendendone il cinto che alla vite mise.
Un dì Eracle fu costretto,
nell’Elide per pulire le stalle del re degli Epèi,
a deviare il corso del letto
dei fiumi Alfèo e Penèo.
S’intorpidirono le acque intrise di letame,
alle onde del mare affogò l’ira del deo.
Intanto a Creta il grano maturo
copriva i campi dorati,
ma un toro, saltando da muro a muro,
devastava il raccolto e i frutti appena nati.
I commensali non potevano più gustare le cene;
così Eracle, chiamato all’uopo,
catturò il toro e tiratolo per le corna
/lo portò a Micène,
giungendo al travagliato scopo.
I cavalli di Diomede, re della Tracia,
scalpitavano ferocissimi cibandosi di carne umana.
L’eroe lottò col re sotto un albero di acacia,
le giumente imbizzarrite uscirono dalla tana
e subito divorarono Diomede.
Colle criniere al vento furono consegnate a Euristèo,
mentre le maciullate spoglie del re giunsero all’Ade.
Altre fatiche di lì a poco
si presentarono all’eroe muscoloso;
che dovette uccidere: il gigante Eurizione
/e non fu cosa da poco,
il cane Ortos, che con due teste era bavoso,
infine Gerione, orribile mostro in tre corpi uniti.
Compiuta l‘impresa, andò in Gallia stanco ma borioso.
Scese in Italia facendo morti e feriti.
Ospitato da Evandro uccise il giovane Caco il ladrone,
figlio d’Efesto, ignorando dell’Olimpo i riti.
Compì faticosi viaggi, si nutri di montone;
s’incontrò con Atlante per rubare gli aurei frutti
delle Espèridi, figlie della notte.
Vinse i marosi, sorresse la volta del cielo,
/con astuzia vinse tutti.
Infine scese nell’Erebo nella buia notte,
catturò il cane tricipide, lo mostrò a Euristèo.
Dopo, ancora integro nelle forze liberò l’eroe Tèseo.
Canto greco pietoso
Le dorate arpe suonavano
note prodotte da mani sapienti…
Ninfe leggiadre cantavano
l’amore accompagnato da venti.
Nìobe superba, prigioniera
nella roccia del monte, dormiva;
moglie di Anfiòne re di Tebe era.
Candide lacrime il marmo stillava
alle divine note cullate dai venti:
“O che follia è questa!” gridava
sdegnata Latona
“preferire gli dei alle dive presenti?”
Dall’alto dell’Olimpo lampi e tuoni
chiedevano vendetta…
Febo, figlio nel volto feroce,
prese l’arco e la saetta,
mirò, scoccò la freccia veloce
che nel collo di Imeno s’infisse.
Caddero ad uno ad uno
i figli ardimentosi prima ch’uscisse
Niobe da Tebe per difender ognuno.
Pietà non ebbe Febo e non trattenne
la sua freccia d’oro.
“Pasciti pure, Latona, del dolor perenne!
Sazia il tuo cuore feroce, sonoro!
Tu esulta vittoriosa nemica! Io sono rovinata!
A me misera resta più prole
e coraggio dopo tanta uccisione, oh dannata!”
Ma ecco che Artèmide con tutta la sua mole
assalì le figlie con gli strali d’argento.
Già sei erano cadute, la madre invocava:
“lasciatemela,la piccola lasciatemela!”
/Gridava con ardimento.
La madre superba rimase di stucco:
“I piedi sono di sasso come pure i capelli!”
Senza alcun trucco,
ormai insensibile a tanto fragore,
/di pietra divenne alla morte dei suoi gioielli.
S’alzò un vento vorticoso, furente
si batté contro la roccia di Sibilo;
rupe che lacrimò disperatamente.
Giovanni Teresi